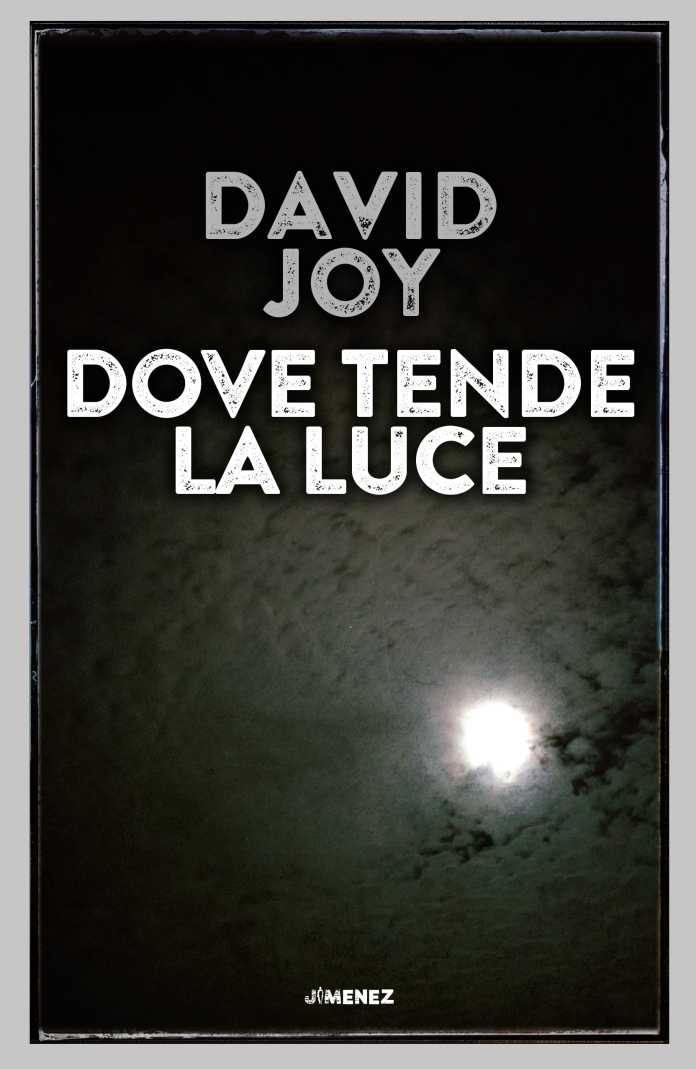Prigionieri del destino come animali in trappola, i personaggi di David Joy sanguinano dibattendosi inutilmente, sino all’inevitabile, tragico epilogo. Dove tende la luce, folgorante esordio dello scrittore americano, segna già i cardini della sua narrativa. “Non c’era scampo da ciò che ero e da dove venivo”, afferma il protagonista Jacob McNeely, figlio di una tossicomane e di uno spietato trafficante di metanfetamine. La luce resta un sogno inappagato, un’irrealizzabile utopia prima di precipitare nuovamente nell’oscurità. L’amore di Maggie è un’illusoria ancora di salvezza in un mondo che non offre vie di fuga. L’insensatezza dell’esistere può trovare effimero sollievo nella sensazione della pioggia che dilava il corpo dai suoi peccati, in una sorta di battesimo impossibile. Come in un romanzo di Bernhard, l’unica correzione si trova nella morte. Il paesaggio della Carolina del Nord appare opprimente, il buio solcato dai fari dei pick-up che trasportano cacciatori di orsi, o semplicemente gente dallo sguardo perso alla ricerca dello sballo. Jacob percepisce la maledizione che scorre nelle sue vene: il sangue dei McNeely lo spinge verso quel wild side che imprigiona la sua vita. Da questo punto di vista, Jacob è già condannato. Non riuscendo a credere nella salvezza, l’ha già perduta. Jacob non ha scelta. Come un personaggio di Faulkner, appare già segnato dal destino. La sua figura è tragica e isolata.
 Con stile cinematografico, non a caso dal libro è stato tratto un film a firma Ben Young, colmo di dettagli di crudo realismo, in grado di tratteggiare paesaggi dell’anima di estrema oscurità, Joy narra una vicenda sanguinaria non esente da sprazzi di puro lirismo. Dalla vera violenza, per usare un’espressione di Roberto Bolaño, non si può fuggire. Terre devastate dall’uomo bianco ricordano la caduta, quel peccato originale dal quale non vi è riscatto. Così un quadretto raffigurante un indiano in groppa a un cavallo diviene simbolo della perduta libertà, della struggente nostalgia verso una esistenza in sintonia con il mondo della natura. Il senso di colpa verso i nativi, sterminati senza pietà, traspare in queste pagine. La punizione si manifesta in una società annichilita dalla droga e dall’assenza quasi totale di legami emotivi. Le fiamme, vere protagoniste dell’ultimo romanzo di Joy dal titolo Queste montagne bruciano, balenano nell’incendio della casa della madre di Jacob; lingue di fuoco che non divorano un mondo estinto per annunciarne uno nuovo, ma che semplicemente rappresentano la distruzione di un Paese agonizzante.
Con stile cinematografico, non a caso dal libro è stato tratto un film a firma Ben Young, colmo di dettagli di crudo realismo, in grado di tratteggiare paesaggi dell’anima di estrema oscurità, Joy narra una vicenda sanguinaria non esente da sprazzi di puro lirismo. Dalla vera violenza, per usare un’espressione di Roberto Bolaño, non si può fuggire. Terre devastate dall’uomo bianco ricordano la caduta, quel peccato originale dal quale non vi è riscatto. Così un quadretto raffigurante un indiano in groppa a un cavallo diviene simbolo della perduta libertà, della struggente nostalgia verso una esistenza in sintonia con il mondo della natura. Il senso di colpa verso i nativi, sterminati senza pietà, traspare in queste pagine. La punizione si manifesta in una società annichilita dalla droga e dall’assenza quasi totale di legami emotivi. Le fiamme, vere protagoniste dell’ultimo romanzo di Joy dal titolo Queste montagne bruciano, balenano nell’incendio della casa della madre di Jacob; lingue di fuoco che non divorano un mondo estinto per annunciarne uno nuovo, ma che semplicemente rappresentano la distruzione di un Paese agonizzante.
Scene di tortura ricordano l’immaginario di Quentin Tarantino, in particolare certe atmosfere di Reservoir dogs con il quale il regista scompaginò le convenzioni narrative del genere. L’accumulo progressivo della violenza, il senso di claustrofobia, le origini del male sono temi che accomunano i due autori. Pur circondati da enormi distese boschive e montane, i personaggi di Joy sentono di non poter fuggire. Il male li avvolge nelle sue spire, soffocandoli a poco a poco. Il silenzio di Dio li atterrisce, come in una pellicola di Bergman. Soli al mondo, si aggrappano alle loro illusioni, nella consapevolezza che ogni sforzo è vano, che ogni tentativo di sottrarsi alla trappola che li ghermisce aumenta il dolore e li avvicina sempre di più alla loro fine.