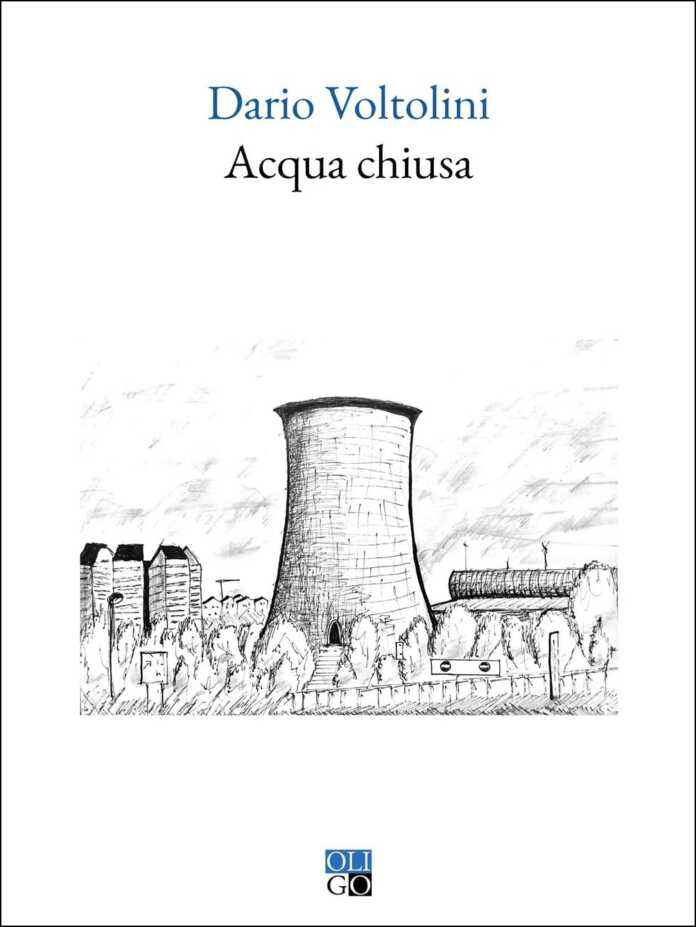Raccontare luoghi, e disegnarli: questo sembra essere il primo obiettivo della collana “Ronzinante”, recentemente inaugurata dalla casa editrice mantovana Oligo e diretta da Marino Magliani; il cavallo di Don Chisciotte è però una guida vera e non soltanto un letterario emblema – magari di un qualche donchisciottismo, invece del tutto assente (anche nell’altro titolo, Corsica, firmato da Magliani) – di questi volumetti, che presentano divagazioni e digressioni di varia natura, in forma di narrazione breve, in una graziosa edizione brossurata. Nel Quijote, del testo, Ronzinante riceve il proprio nuovo nome ancor prima del suo cavaliere, fornendo così un ulteriore impulso alla creazione letteraria cervantina: Ronzinante instaura un rapporto di elevazione e al tempo stesso distorsione del suo status di “ronzino” denunciando per contro – come una sorta di understatement su quattro zampe – come davvero pericolosa la follia latente nella nostalgia del suo cavaliere per l’epoca delle gesta cavalleresche.
Ecco, anche le narrazioni di Magliani e, soprattutto, di Voltolini sfuggono costantemente alla tentazione della nostalgia, di quella scrittura elegiaca dei luoghi che – in Acqua chiusa soprattutto – potrebbe facilmente scaturire dal ritorno letterario ai luoghi della storia famigliare. Caduta (fin dal lapidario incipit: «E così tutto cade»), rovina, passaggio dalla nettezza delle forme geometriche all’indistinto: questi sono i movimenti che si percepiscono nella scrittura e nei disegni di Voltolini, ma sempre all’interno di un processo di raffreddamento – tanto emotivo quanto stilistico – che elude ogni possibile sentimentalismo e cerca di farsi referto (come già segnalato, ad esempio, nella recensione di Rossella Pretto per “L’Ottavo”, in analogia con il romanzo di Voltolini, Invernale, già finalista al Premio Strega).
È soltanto dal risvolto di copertina, ad esempio, che apprendiamo che nella zona della città di Torino raccontata e disegnata, in quella stessa area dove «c’era un’enorme fabbrica della Michelin e ora c’è un centro commerciale», «è vissuta la famiglia di mio padre», appiglio autobiografico che Acqua chiusa continuamente cela e sovraespone, in un mutamento di paesaggio che è perdita luttuosa e, al tempo stesso, pura e semplice, quasi meccanismo, trasformazione. Opacità e paradosso che, quindi, non possono che coinvolgere anche tutta quella storia economica e politica che si può facilmente immaginare (perché tanto spesso, nel secondo Novecento, è stata associata a Torino) e che Voltolini evita e continuamente pone davanti agli occhi – come, appunto, il dolore per una morte è sempre evocato e reso presente, eppure mai rappresentato direttamente, da un referto autoptico.
Come brillantemente nota Alice Pisu, nella sua accurata introduzione al testo, nella lingua precisa, calviniana, ma non per questo meno aperta a cambi di registro e improvvise impennate, di Voltolini l’oggettivazione ha risvolti paradossali, persino favolistici: «L’assenza di precisi riferimenti temporali e spaziali e l’anonimato di personaggi che finiscono per annientarsi nel loro ruolo celano il passo favolistico del racconto: sfilano sulla pagina figure che lambiscono quotidianamente la catastrofe, accomunate da una coscienza anteriore alla loro esistenza». Ancora una volta, però, non si ha né escapismo né idealizzazione: «Lo sguardo del narratore rende tangibile la privazione, incapace di immaginare una forma di grazia in un passato proletario verso cui stride ogni nostalgia».
Accade unicamente che in una simile, gelida, desertificazione, continui imperturbabile a scorrere l’acqua chiusa del titolo, nei canali intombati sui quali è stata costruita quest’area urbana del capoluogo piemontese. È un’acqua infernale, come racconta Voltolini in un mirabile passaggio che val la pena di citare quasi per intero: «[…] ora c’è anche un museo “dedicato alle tematiche ambientali”. Ha vinto il pulito sull’orrore dei fumi e degli scarichi infernali nel fiume. Ma quando vincono i buoni, che ne è del tifo che si fa per i perdenti? Possiamo tifare per un organismo inumano in cui il nerofumo si incollava all’operaio che poi per lavarsi doveva usare la pialla del falegname o almeno la cartavetro? E i cui polmoni venivano vulcanizzati insieme ai copertoni? E il cui stomaco doveva liberarsi vomitando a colpi di latte e anice? Possiamo in tutta coscienza preferire quel tempo, il tempo del caucciù e delle mescole e degli stampi, a questo? Relativamente al genius loci, sì».
Stretto tra il tempo «dei buoni», anche in letteratura, e quello di un «organismo inumano» apparentemente consegnato al passato e in realtà, mutatis mutandis, ancora presente, lo scrittore sembra indugiare per un attimo nella visione romantica del genius loci, ma anche qui né la nostalgia né l’elegia possono reggere: il fiume infernale va attraversato, con le parole carontesche di Voltolini, per approdare a un vero e proprio inferno, piatto, banale e grigio, che non ha nulla della maestosità allegorica dantesca. È un mucchio di detriti, coperti dalla trasformazione del luogo in non luogo postmoderno: Ronzinante è il viandante che attraversa questi luoghi e passa oltre, sapendo che la scrittura fredda della caduta è la via stretta per approdare a un futuro dove – purtroppo, o forse per fortuna (almeno di noi lettori) – non c’è alcun Don Chisciotte ad aspettarci.