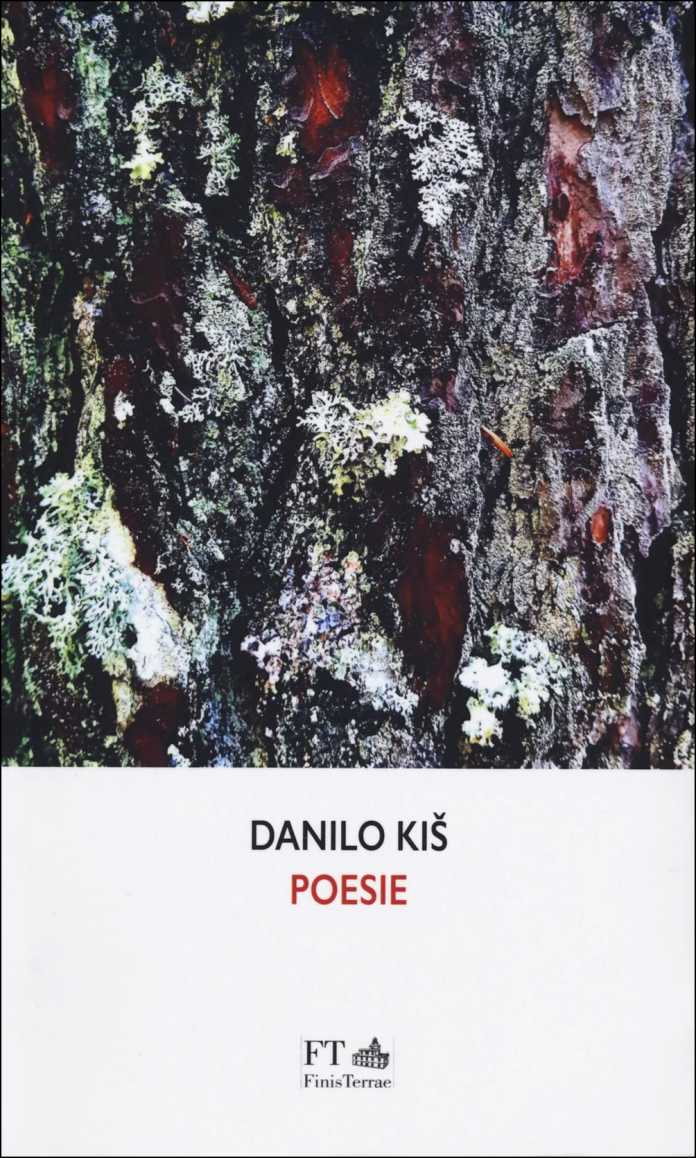Ci sono almeno due traduzioni italiane che, nell’ultimo anno, hanno inteso completare il catalogo italiano dello scrittore jugoslavo Danilo Kiš (1935-1989), la cui opera narrativa – e in parte saggistica – è stata già pubblicata nel corso dei decenni da Adelphi. La prima è la riflessione sulla letteratura intitolata L’ultimo bastione del senso e tradotta per i tipi di Wojtek – dove fa buona compagnia, nella collana Ostranenie, a Teoria della prosa (2021) dello scrittore argentino Ricardo Piglia – e la seconda è l’antologia delle sue poesie pubblicata ora da Ibis-Finis Terrae, nella collana Le Meteore curata da Anna Ruchat e Domenico Brancale.
 In calce all’antologia delle Poesie, la nota dell’ottima traduttrice, Margherita Carbonaro (coadiuvata, in questo libro, da Slavo Šerc), riporta un estratto da un’intervista di Kiš del 1965: “Come tutti quelli che iniziano a occuparsi di letteratura, ero profondamente convinto di essere un poeta. […] Per tutta la vita mi ero preparato a diventare un poeta, ma all’improvviso ho capito di essermi sbagliato”. Come puntualizza Carbonaro, non bisogna dare credito immediato alle parole di Kiš, nella loro apparente eco del famoso monito sulla poesia attribuito a Fabrizio De André: “Fino a diciotto anni tutti scrivono poesie; dopo, possono continuare a farlo solo due categorie di persone: i poeti e i cretini”; occorre, piuttosto, riconoscere nell’autore serbo lo stigma del poeta (non è un caso che nelle sue poesie ricorra più d’una volta il poeta-albatro baudelairiano) e la lotta, in primo luogo con sé stessi, per far emergere questo lato della sua produzione come, almeno, un necessario complemento dell’opera più ampiamente riconosciuta.
In calce all’antologia delle Poesie, la nota dell’ottima traduttrice, Margherita Carbonaro (coadiuvata, in questo libro, da Slavo Šerc), riporta un estratto da un’intervista di Kiš del 1965: “Come tutti quelli che iniziano a occuparsi di letteratura, ero profondamente convinto di essere un poeta. […] Per tutta la vita mi ero preparato a diventare un poeta, ma all’improvviso ho capito di essermi sbagliato”. Come puntualizza Carbonaro, non bisogna dare credito immediato alle parole di Kiš, nella loro apparente eco del famoso monito sulla poesia attribuito a Fabrizio De André: “Fino a diciotto anni tutti scrivono poesie; dopo, possono continuare a farlo solo due categorie di persone: i poeti e i cretini”; occorre, piuttosto, riconoscere nell’autore serbo lo stigma del poeta (non è un caso che nelle sue poesie ricorra più d’una volta il poeta-albatro baudelairiano) e la lotta, in primo luogo con sé stessi, per far emergere questo lato della sua produzione come, almeno, un necessario complemento dell’opera più ampiamente riconosciuta.
Da questo punto deriva – ed è quasi inevitabile, partendo da un simile investimento sulla parola poetica – un corpus quantitativamente limitato: trentacinque poesie in tutto, delle quali l’antologia propone un’ulteriore selezione di ventisette testi. Si inizia con alcuni Appunti su un foglio, che hanno tutto fuorché l’estemporaneità ingenua dell’ispirazione – si passa, infatti, dall’annotazione diaristica (“Ah, quanto mi piacerebbe innamorarmi di qualcuno – ma non posso!”) a immagini non immediatamente surrealiste, e che comunque risultano di grande densità e intensità (“quando le mani di qualcuno scendono fra noi come due sbarre bianche a un incrocio”) – e si finisce con i granitici e forse testamentari versi di Alla notizia della morte della signora M.T., completata poco prima della morte dello stesso Kiš: “Che lavoro è stato per te, Morte, / che dimostrazione di forza. / (Come se non ti avessimo / preso in parola.)”.
Se la prima poesia presenta immagini, come quella delle “due sbarre bianche a un incrocio”, che, unite ad altri accenni nella poesia successiva (ad esempio, la chiusa: “Domani! …Domani”), ricordano per lessico e intensità uno degli apici del modernismo transnazionale come Trilce di César Vallejo, vi sono altri episodi dove la forza del dettato poetico di Kiš si stempera verso tonalità che, pur mantenendo un certo post-surrealismo di fondo, appaiono più descrittive e, in generale, meno affascinanti. I saliscendi sembrano inevitabili, anche all’interno di un corpus poetico così rastremato, ma non necessariamente limato e purificato in modo ossessivo.
D’altronde, due delle figure più ricorrenti, e al tempo stesso più potenti, della poesia di Kiš sono “l’aborto” e “l’immondezzaio”. Domina, cioè, un’idea di scarto e di resto che ha a che vedere anche, in senso metaletterario e autocentrato, con il resto della produzione di Kiš; in primo luogo, però, evidenzia il rapporto statutario della poesia con la dimensione tragico-esistenziale, da un lato, e con quella scatologica, dall’altro.
Più che l’autoreferenzialità di certi passaggi, interessa tuttavia come Kiš metta in luce il proprio percorso di avvicinamento alla poesia come creatura mostruosa, che procede da materiali abnormi e si dirige verso un destino di scarto e di resto: “e forse da tutto questo / è nato il mostro / (questa poesia) / perché il suo arrivo / non è stato accompagnato né / da un lampo né dal grido / obbligato della maternità o / dalla paternità né / da una stella cometa // anche se il silenzio / era degno / di rispetto.” (Pioggia dorata).
Una maieutica sofferta e sofferente del verso che è recentemente riemersa nei versi di un’altra scrittrice jugoslava, Marija Čudina (1937-1986), preziosamente tradotti da Božidar Stanišić per l’ultimo numero della rivista La Macchina sognante. In una poesia, intitolata La volpe del deserto, e dedicata proprio a Danilo Kiš, ecco allora un’altra epifania dell’autore e della sua poesia che trova echi sorprendenti nelle Poesie tradotte da Carbonaro (risuonando anche con il vasto campo della poesia mondiale, se si vuole tornare, ad esempio, all’ambientazione parigina dell’ultima parte della vita di Vallejo): “Un uomo dal temperamento speciale, magro, con la vita stretta, / i capelli arruffati come la vegetazione della foresta pluviale dicono che lo è, / ha visto la volpe del deserto per le strade di Parigi. Dio, / ribatte il poeta, cosa fa quella creatura del deserto? / tra gente indegna della sua bellezza…”