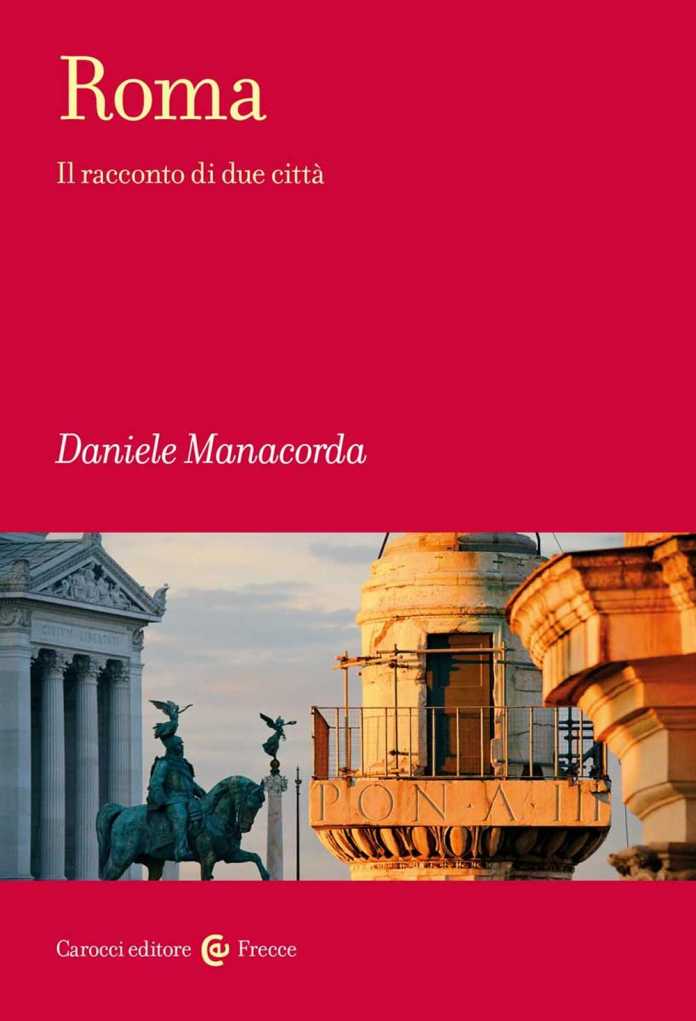Una delle città invisibili di Italo Calvino, Argia, è una metafora visiva perfetta dei resti archeologici sepolti: una città che è tutta sottoterra e ha terra dove le altre hanno aria: “Le vie sono completamente interrate, le stanze sono piene d’argilla fino al soffitto, sulle scale si posa un’altra scala in negativo, sopra i tetti delle case gravano strati di terreno. (…) Di Argia, da qua sopra, non si vede nulla; c’è chi dice: ‘È là sotto’ e non resta che crederci”.
 Forse se lo chiedono in pochi ma come mai i resti materiali antichi sono, in buona parte, finiti sottoterra? A volte perché qualcuno li ha seppelliti: un tesoretto di monete, ad esempio, nascosto nel timore che sarebbe stato rubato; le persone morte, perché a noi umani – sin dai Neanderthal – sembra questo il giusto modo per onorarli e conservarne la memoria. Ma la maggior parte delle cose che sono oggi sottoterra non sono state direttamente sepolte, sono finite lì per una serie di eventi artificiali e naturali. Prima dell’invenzione degli escavatori e delle macchine per il movimento della terra, le operazioni di smaltimento e di rimozione delle macerie erano difficili, perché eseguite manualmente, e dunque limitate: spesso si costruiva un edificio sopra al precedente. Rialzi del piano di camminamento sono stati determinati anche dall’accatastamento dei rifiuti, dal sovrapporsi degli strati di crollo delle strutture, da eventi alluvionali, dall’accumulo delle polveri portate dal vento. Così la terraferma, il piano dove camminiamo e viviamo, è cambiata nel tempo. In pochi metri di superficie di crosta terreste (uno spessore minimo in paragone ai 12.000 km di diametro della Terra) si conservano i resti materiali legati a tutta la storia umana. È una memoria piena, fatta in prevalenza di terra e pietre; è la storia della Z, ovvero la coordinata cartesiana indicativa della profondità del tempo.
Forse se lo chiedono in pochi ma come mai i resti materiali antichi sono, in buona parte, finiti sottoterra? A volte perché qualcuno li ha seppelliti: un tesoretto di monete, ad esempio, nascosto nel timore che sarebbe stato rubato; le persone morte, perché a noi umani – sin dai Neanderthal – sembra questo il giusto modo per onorarli e conservarne la memoria. Ma la maggior parte delle cose che sono oggi sottoterra non sono state direttamente sepolte, sono finite lì per una serie di eventi artificiali e naturali. Prima dell’invenzione degli escavatori e delle macchine per il movimento della terra, le operazioni di smaltimento e di rimozione delle macerie erano difficili, perché eseguite manualmente, e dunque limitate: spesso si costruiva un edificio sopra al precedente. Rialzi del piano di camminamento sono stati determinati anche dall’accatastamento dei rifiuti, dal sovrapporsi degli strati di crollo delle strutture, da eventi alluvionali, dall’accumulo delle polveri portate dal vento. Così la terraferma, il piano dove camminiamo e viviamo, è cambiata nel tempo. In pochi metri di superficie di crosta terreste (uno spessore minimo in paragone ai 12.000 km di diametro della Terra) si conservano i resti materiali legati a tutta la storia umana. È una memoria piena, fatta in prevalenza di terra e pietre; è la storia della Z, ovvero la coordinata cartesiana indicativa della profondità del tempo.
Il racconto della Z, in un luogo eccezionale dove la materialità della storia è ineludibile e ridondante, è quanto ha fatto l’archeologo Daniele Manacorda nel suo ultimo libro su Roma: una storia della città dalle origini sino all’età moderna con una particolare attenzione alla tridimensionalità, alle modalità di accrescimento e di alterazione del suolo, al volume prima che alla rappresentazione cartografica. Una lettura complessa e affascinante, non semplice per chi non è del mestiere ma molto interessante per chiunque voglia cimentarsi con l’essenza di un’archeologia globale, focalizzata non tanto su un periodo determinato del passato ma piuttosto sulla diacronia della città, sulle sue trasformazioni nel tempo.
 Se nella storia di Roma la X e la Y, le coordinate che determinano l’estensione dell’abitato, sono rimaste relativamente stabili per secoli (le mura Aureliane costruite nel III secolo d.C. hanno racchiuso anche la città medievale e moderna), la Z, invece, cioè il livello di camminamento e insieme lo spessore del sedime urbano, è molto variata. In tre millenni di storia (dal IV secolo a.C. a oggi) il livello dell’abitato si è alzato in media dai 6 agli 8 m. Che qualcosa sia successo, lo si nota facilmente camminando per la città. La soglia d’ingresso di molte chiese (ad esempio San Vitale, Santa Pudenziana) si trova diversi metri più in basso rispetto all’attuale livello stradale, a un piano d’uso abbandonato da secoli; i templi di età romana repubblicana dell’area archeologica di Largo Argentina si trovano circa 6 m più in basso rispetto alla piazza; le strutture romane rinvenute in piazza Barberini sono a 10 m di profondità; sotto via Nazionale e via Quattro Fontane, a una profondità di 17 m, passa una strada antica; la via Lata romana giace a una profondità di 12 m dall’attuale via del Corso. Il rialzo del suolo è stato ridotto o nullo sulla sommità dei colli ma molto evidente nelle vallate: un fenomeno che ha profondamente modificato, nel tempo, la topografia della città e la percezione dei suoi dislivelli. In parte la crescita è avvenuta già in età romana per la costruzione di nuovi edifici sopra le macerie di demolizione e crollo di quelli più antichi; questo vale per i grandi complessi termali: quello di Traiano, costruito su un settore della Domus Aurea neroniana che si è così conservato ed è attualmente visitabile; le terme di Caracalla tra Aventino e Celio, che seppellirono una residenza privata sotto almeno 6 m di strati di riporto; quelle di Diocleziano, quando la terra derivata dalle operazioni di scavo fu addossata alle mura serviane (un tratto delle quali, in grandi blocchi di pietre, è oggi visibile nel piazzale della Stazione Termini e fu riscoperto durante i lavori per la costruzione del complesso ferroviario, rimuovendo gli accumuli di età dioclezianea). Il rialzo fu favorito anche dai numerosi casi di riuso di architetture antiche trasformate in chiese nella tarda antichità e nel medioevo, come accadde ad esempio a diversi edifici del foro (la chiesa di San Lorenzo in Miranda, che occupa parte del tempo di Antonino e Faustina, ha una soglia posta 10,5 m più in alto rispetto a quella dell’edificio pagano).
Se nella storia di Roma la X e la Y, le coordinate che determinano l’estensione dell’abitato, sono rimaste relativamente stabili per secoli (le mura Aureliane costruite nel III secolo d.C. hanno racchiuso anche la città medievale e moderna), la Z, invece, cioè il livello di camminamento e insieme lo spessore del sedime urbano, è molto variata. In tre millenni di storia (dal IV secolo a.C. a oggi) il livello dell’abitato si è alzato in media dai 6 agli 8 m. Che qualcosa sia successo, lo si nota facilmente camminando per la città. La soglia d’ingresso di molte chiese (ad esempio San Vitale, Santa Pudenziana) si trova diversi metri più in basso rispetto all’attuale livello stradale, a un piano d’uso abbandonato da secoli; i templi di età romana repubblicana dell’area archeologica di Largo Argentina si trovano circa 6 m più in basso rispetto alla piazza; le strutture romane rinvenute in piazza Barberini sono a 10 m di profondità; sotto via Nazionale e via Quattro Fontane, a una profondità di 17 m, passa una strada antica; la via Lata romana giace a una profondità di 12 m dall’attuale via del Corso. Il rialzo del suolo è stato ridotto o nullo sulla sommità dei colli ma molto evidente nelle vallate: un fenomeno che ha profondamente modificato, nel tempo, la topografia della città e la percezione dei suoi dislivelli. In parte la crescita è avvenuta già in età romana per la costruzione di nuovi edifici sopra le macerie di demolizione e crollo di quelli più antichi; questo vale per i grandi complessi termali: quello di Traiano, costruito su un settore della Domus Aurea neroniana che si è così conservato ed è attualmente visitabile; le terme di Caracalla tra Aventino e Celio, che seppellirono una residenza privata sotto almeno 6 m di strati di riporto; quelle di Diocleziano, quando la terra derivata dalle operazioni di scavo fu addossata alle mura serviane (un tratto delle quali, in grandi blocchi di pietre, è oggi visibile nel piazzale della Stazione Termini e fu riscoperto durante i lavori per la costruzione del complesso ferroviario, rimuovendo gli accumuli di età dioclezianea). Il rialzo fu favorito anche dai numerosi casi di riuso di architetture antiche trasformate in chiese nella tarda antichità e nel medioevo, come accadde ad esempio a diversi edifici del foro (la chiesa di San Lorenzo in Miranda, che occupa parte del tempo di Antonino e Faustina, ha una soglia posta 10,5 m più in alto rispetto a quella dell’edificio pagano).
 La città è cambiata a ritmi diversi, gradualmente o nel corso di svolte repentine, sulla base di variabili culturali; si è modificata irrimediabilmente e poi è rinata nel mito, nella memoria e nell’immaginario, come è successo alla Roma antica durante l’età medievale (XII-XIII sec.). Della Roma medievale apparentemente è restato poco perché i palazzi, le chiese, le facciate sono stati poi ricostruiti ma la trama urbanistica e il tessuto edilizio interno spesso si sono conservati. È proprio in età bassomedievale (in particolare a partire dal pontificato di Pasquale II, 1099-1118) che la città torna a essere un polo attivo, grazie ai numerosi interventi di committenza ecclesiastica e a operazioni generalizzate di rialzo e di livellamento del suolo che segnano una rottura con le radici antiche e determinano la formazione di una città nuova (questo è tra l’altro il periodo di massiccia e quasi improvvisa diffusione del campanile). Nella Roma rinascimentale i cambiamenti proseguono e si sviluppa una nuova viabilità rettificando, allargando e lastricando le strade esistenti; sarà proprio lo sviluppo di un servizio di nettezza urbana dal XVI secolo in avanti che permetterà la stabilizzazione delle quote. In età moderna, infatti, i rialzi del suolo sono stati nulli o poco rilevanti e ben più invasivi gli interventi di liberazione dei monumenti di età romana dalle superfetazioni e di sventramento urbano: quelli di epoca fascista nell’area dei Fori, ma ancora di più quelli connessi con i lavori di costruzione della nuova capitale tra 1872 e 1885, che comportarono la movimentazione di più di 80 milioni di metri cubi di terra, la distruzione di monumenti, l’isolamento di quelli mantenuti, lo sterro indiscriminato senza alcuna considerazione del sedime urbano. Soltanto a partire dagli anni Ottanta del XX secolo, con la comparsa dell’archeologia urbana, un’archeologia ormai moderna, inizia la riflessione sulla Z. “Quando osserviamo la Z delle stratificazioni urbane” – scrive l’autore – “dobbiamo guardarci dal commettere l’errore semplicistico di considerare il fenomeno di accrescimento dei suoli quale una sorta di variabile indipendente dagli abitanti del luogo, un fenomeno dunque prevalentemente fisico e quantitativo, del quale l’uomo sarebbe stato al più protagonista inconsapevole quando non spettatore estraneo. La stratificazione urbana, nella sua misurabile fisicità, è un fenomeno sostanzialmente culturale”.
La città è cambiata a ritmi diversi, gradualmente o nel corso di svolte repentine, sulla base di variabili culturali; si è modificata irrimediabilmente e poi è rinata nel mito, nella memoria e nell’immaginario, come è successo alla Roma antica durante l’età medievale (XII-XIII sec.). Della Roma medievale apparentemente è restato poco perché i palazzi, le chiese, le facciate sono stati poi ricostruiti ma la trama urbanistica e il tessuto edilizio interno spesso si sono conservati. È proprio in età bassomedievale (in particolare a partire dal pontificato di Pasquale II, 1099-1118) che la città torna a essere un polo attivo, grazie ai numerosi interventi di committenza ecclesiastica e a operazioni generalizzate di rialzo e di livellamento del suolo che segnano una rottura con le radici antiche e determinano la formazione di una città nuova (questo è tra l’altro il periodo di massiccia e quasi improvvisa diffusione del campanile). Nella Roma rinascimentale i cambiamenti proseguono e si sviluppa una nuova viabilità rettificando, allargando e lastricando le strade esistenti; sarà proprio lo sviluppo di un servizio di nettezza urbana dal XVI secolo in avanti che permetterà la stabilizzazione delle quote. In età moderna, infatti, i rialzi del suolo sono stati nulli o poco rilevanti e ben più invasivi gli interventi di liberazione dei monumenti di età romana dalle superfetazioni e di sventramento urbano: quelli di epoca fascista nell’area dei Fori, ma ancora di più quelli connessi con i lavori di costruzione della nuova capitale tra 1872 e 1885, che comportarono la movimentazione di più di 80 milioni di metri cubi di terra, la distruzione di monumenti, l’isolamento di quelli mantenuti, lo sterro indiscriminato senza alcuna considerazione del sedime urbano. Soltanto a partire dagli anni Ottanta del XX secolo, con la comparsa dell’archeologia urbana, un’archeologia ormai moderna, inizia la riflessione sulla Z. “Quando osserviamo la Z delle stratificazioni urbane” – scrive l’autore – “dobbiamo guardarci dal commettere l’errore semplicistico di considerare il fenomeno di accrescimento dei suoli quale una sorta di variabile indipendente dagli abitanti del luogo, un fenomeno dunque prevalentemente fisico e quantitativo, del quale l’uomo sarebbe stato al più protagonista inconsapevole quando non spettatore estraneo. La stratificazione urbana, nella sua misurabile fisicità, è un fenomeno sostanzialmente culturale”.
 Proprio perché fenomeno culturale, la riflessione sulla Z ha a che vedere non soltanto con le modifiche fisiche della città ma anche con quelle percettive, che forse ancora di più sono il segno di un modo diverso di vivere, di uno sguardo ormai mutato. Il riuso visivo è un fenomeno estremamente interessante a cui Manacorda accenna a proposito delle colonne coclidi (le colonne onorarie di età romana decorate da un fregio a rilievo – la più nota è quella di Traiano – che rimasero sempre visibili nelle varie fasi storiche della città) definendolo una “particolare forma di sussistenza” che “sembra indicare una continuità di visioni (nel variare dei paesaggi!) connessa (…) a una continuità di ammirazione, e quindi (…) una forma di riuso di carattere astratto, più che funzionale”. Il cambio di percezione si esplica durante la lenta formazione, tra la tarda antichità e il Medioevo, di un paesaggio di rovine, mentre vaste aree della città si ruralizzano, l’area dei Fori torna a essere semi-paludosa, alcuni edifici vengono in parte riutilizzati, altri lasciati in abbandono o usati per il recupero dei materiali da costruzione e, gradualmente, si perde la memoria legata a nomi e funzioni degli edifici antichi.
Proprio perché fenomeno culturale, la riflessione sulla Z ha a che vedere non soltanto con le modifiche fisiche della città ma anche con quelle percettive, che forse ancora di più sono il segno di un modo diverso di vivere, di uno sguardo ormai mutato. Il riuso visivo è un fenomeno estremamente interessante a cui Manacorda accenna a proposito delle colonne coclidi (le colonne onorarie di età romana decorate da un fregio a rilievo – la più nota è quella di Traiano – che rimasero sempre visibili nelle varie fasi storiche della città) definendolo una “particolare forma di sussistenza” che “sembra indicare una continuità di visioni (nel variare dei paesaggi!) connessa (…) a una continuità di ammirazione, e quindi (…) una forma di riuso di carattere astratto, più che funzionale”. Il cambio di percezione si esplica durante la lenta formazione, tra la tarda antichità e il Medioevo, di un paesaggio di rovine, mentre vaste aree della città si ruralizzano, l’area dei Fori torna a essere semi-paludosa, alcuni edifici vengono in parte riutilizzati, altri lasciati in abbandono o usati per il recupero dei materiali da costruzione e, gradualmente, si perde la memoria legata a nomi e funzioni degli edifici antichi.
Quante Roma sono esistite? La città è da considerarsi quantomeno duale, conclude Manacorda nel denso capitolo finale, dove ci si interroga sul rapporto e sul dialogo (a volte assente) tra la città contemporanea e quella sepolta, quella in rovina e quella resuscitata grazie all’archeologia. Roma è una città indubbiamente d’eccezione, non solo per la quantità e qualità delle persistenze antiche ma anche per uno statuto unico – di città simbolo – mai perso e che ha consentito la salvezza di molti suoi manufatti architettonici. La città pagana è rimasta nell’immaginario proprio in virtù dei resti che abitavano il suo sottosuolo e la superficie; grazie, quindi, a un approccio non tanto critico e storico verso il passato, ma piuttosto mitico e visionario.
Oggi il metodo archeologico e stratigrafico (la prospettiva della Z) è la chiave per comprendere il contesto, che non è altro che il paesaggio che abitiamo carico di tutte le tracce e le trasformazioni determinate dal tempo; lo strumento per vedere gli aspetti dinamici del passato in qualcosa che è pressoché statico (natura, tessuto edilizio, manufatti architettonici, resti archeologici). L’archeologia dei paesaggi urbani può “contribuire ad arricchire e a mutare, anche radicalmente, la percezione che ciascuno di noi ha della città in cui vive”, oltre a dare un senso (che sia quello andato perduto o uno del tutto nuovo) ai monumenti del passato e alla loro esistenza tra di noi. È un’idea di archeologia diversa da quella più diffusamente divulgata (le scoperte sensazionali, gli oggetti che riemergono dal sottosuolo e il cui impatto scuote – per quanto tempo? – la nostra emotività). Una prospettiva che si potrebbe definire, usando una metafora tratta dall’arte, cubista: perché cerca di superare lo sguardo bidimensionale (per sua natura carente di tempo e quindi di storia) e la visione puramente contemplativa, astratta e retorica dell’antico, che può essere confortante per un tempo breve o lungo, può farci sorridere, commuovere, persino piangere ma non inciderà mai realmente sulla nostra esistenza perché ancorata all’idea che ciò che è passato è irrimediabilmente perduto. In quella Z che calpestiamo, invece, c’è tutta l’infinita e contradditoria variabilità del vivere, che ancora ci può compromettere.