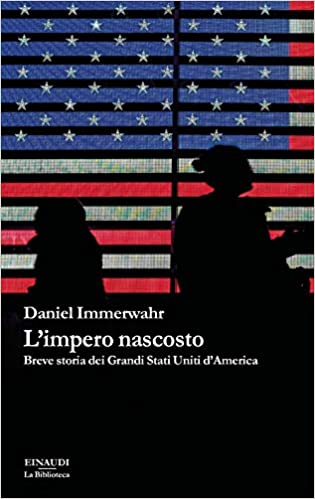Gli Stati Uniti si sono sempre pensati e rappresentati come una repubblica fondata sui più alti ideali di libertà e democrazia. Sin dalle origini hanno menato vanto della loro costituzione quale sommo esempio di sovranità e indipendenza, e si sono posti come un faro per i popoli in lotta per l’autodeterminazione: d’altra parte, sono nati da una rivolta antimperialista. Questo formidabile immaginario, profondamente radicato nella memoria nazionale, è il filo rosso che ne attraversa la storia.
Con l’intento di decostruire tale immaginario, svelare la cruda realtà che esso cela, è apparso di recente uno studio, pubblicato in Italia dall’editore Einaudi: L’impero nascosto. Breve storia dei Grandi Stati Uniti d’America, opera dello storico Daniel Immerwahr.
L’autore parte dallo smascheramento della cosiddetta “mappa-logo”, con cui il territorio degli Stati Uniti figura sulle carte geopolitiche, un universo geograficamente ben definito, delimitato a nord dal Canada, a sud dal Messico e dagli oceani a oriente e occidente. Da tale rappresentazione furono per lunghissimo tempo esclusi i territori annessi a vario titolo, dall’Alaska alle isole Hawai’i (divenute stati solo nel 1959), a Puerto Rico, alle Filippine, a Guam, alle Samoa statunitensi, alle miriadi di isole e arcipelaghi sparsi per il globo, dove sventola la bandiera a stelle e strisce. Tutto ciò lascia intendere che gli USA siano uno spazio politicamente uniforme: un’unione di stati in cui si entra volontariamente, su un piano di parità. “Ma non è vero e non lo è mai stato”, ammonisce Immerwahr. Dal giorno in cui fu ratificato il trattato che sanciva l’indipendenza dalla Gran Bretagna fino a oggi, gli USA “sono un insieme di stati e territori. Sono un paese diviso in due sezioni, in cui si applicano leggi diverse”, dove milioni di cittadini non hanno goduto e non godono degli stessi diritti. In definitiva, quella degli Stati Uniti è la vicenda di un impero che ha sempre negato di essere tale.
Questa immagine degli Stati Uniti come repubblica è consolatoria, ma anche “costosa”, e gran parte di tali costi sono ricaduti sugli abitanti delle colonie e delle zone occupate: “La mappa-logo li ha relegati nell’ombra, ed è un posto pericoloso in cui vivere”. Ma essa ha dei costi anche per gli abitanti del continente: “Dà loro una visione tronca della propria storia, che esclude una parte importante del paese”. Ecco dunque la tesi fondamentale sostenuta in queste pagine: dovremmo pensare in modo diverso agli Stati Uniti, non come una massa contigua bensì considerando le sue grandi e piccole colonie.
Naturalmente la questione dell’imperialismo americano è stata posta innumerevoli volte: ormai è pacifico che l’espropriazione operata a danno dei nativi americani (le cui vicende sono qui lucidamente ricostruite), massacrati e rinchiusi nelle riserve, è stata un atto imperialista per eccellenza, come lo furono la guerra negli anni Quaranta dell’Ottocento contro il Messico (cui fu sottratto con la forza un terzo del territorio), la colonizzazione dell’Alaska nel 1867 e l’occupazione di migliaia di isole del Pacifico, la guerra alla Spagna del 1898 e l’annessione della maggior parte dei suoi possedimenti d’oltremare (tra cui Cuba, Puerto Rico e le Filippine), delle terre non spagnole delle Hawai‘i, dell’isola di Wake e delle Samoa Americane, quindi nel 1917 delle Isole Vergini statunitensi. Così come è noto che l’impero americano raggiunse la massima espansione dopo la Seconda guerra mondiale, rivendicando il proprio potere nel Pacifico e istituendo migliaia di basi militari in tutto il mondo, schierando le proprie forze armate per conflitti esistenti o potenziali (dal 1945, 211 volte in 67 paesi – ad oggi).
Ma è la prospettiva scelta da Immerwahr a rendere interessante il suo studio, che propone analisi innovative e si segnala per una concezione originale del significato odierno di impero e di globalizzazione. L’assunzione di un nuovo punto di vista muta la percezione delle cose, degli eventi: fa emergere “una versione della storia degli Usa sorprendentemente diversa”. Oggetti culturali ormai logori assumono nuova importanza, episodi storici sconosciuti appaiono “terribilmente importanti”. Dunque, il contributo principale di questo libro non è archivistico (non porta alla luce nuovi documenti mai visionati in precedenza), bensì di prospettiva: “Vedere in modo diverso una storia familiare” (un esempio su tutti, il dislocamento dei nativi americani, l’enorme Territorio Indiano creato negli anni Trenta dell’Ottocento, che per Immerwahr rappresenta la prima colonia degli Stati Uniti).
In particolare, ci si focalizza sulla questione del razzismo: “Mettendo in rilievo i Grandi Stati Uniti – cioè i territori posseduti e non solo gli stati riconosciuti – si scopre che la questione della razza è stata addirittura più importate nella storia degli USA di quanto si pensi solitamente”. In realtà, “le storie degli afroamericani e dei popoli colonizzati sono strettamente incrociate, talvolta sovrapposte”, perché “il razzismo che pervadeva il paese dai tempi dello schiavismo riguardava anche i territori. Al pari degli afroamericani, i soggetti coloniali non potevano votare ed erano stati privati dei diritti di cittadinanza, venivano chiamati ‘negri’, subivano pericolosi esperimenti medici ed erano usati come pedine sacrificali in guerra”.
L’autore ricostruisce poi il mutamento di scenario avvenuto dopo il secondo conflitto mondiale, quando, sia per i movimenti indipendentisti che accesero il mondo, sia per l’affinamento di una serie straordinaria di tecnologie che produceva vantaggi senza dover materialmente possedere un territorio, l’usuale paradigma di impero cambiò, e si stabilì una nuova relazione con i territori: gli Stati Uniti “rimpiazzarono la colonizzazione con la globalizzazione”. Gli USA inaugurarono quindi un nuovo modello di potenza globale, “basato non tanto sul reclamare vaste porzioni di terra quanto sul controllo di piccoli punti”, con un capillare sistema di basi militari: è il cosiddetto “impero puntillista”, che si estende su tutto il pianeta e che continua ad essere ignorato dai cittadini americani. È una delle parti più interessanti del libro, in cui Immerwahr analizza questioni vitali poco indagate dalla storiografia, come il fenomeno della standardizzazione, le innovazioni nel campo della chimica e dell’ingegneria industriale, la padronanza della logistica.
Altro notevole merito di questo libro è la ricostruzione, operata con grande empatia e notevoli abilità narrative, delle sanguinose vicende e delle terribili sofferenze patite dagli abitanti delle colonie (Cuba, Puerto Rico, Hawai‘i, Filippine, Isole Aleutine, Micronesia): una storia di atrocità e violenze, di massacri e torture da parte dell’esercito statunitense di occupazione, che nelle isole dove sorgevano le basi militari instaurò un autentico regime, con “metodi da Gestapo”, con costi umani enormi – è l’impero “nascosto sotto il tappeto”, una storia nascosta, gestita da una ferrea censura.
In questa operazione di svelamento emergono dettagli agghiaccianti, come quel che accadde a Puerto Rico, dove i medici statunitensi condussero sulla popolazione esperimenti degni di quelli famigerati dei nazisti, dove si sterilizzarono le donne contro il loro volere, dove i militari “testarono i gas e le loro attrezzature su più di sessantamila uomini del proprio esercito”, test segreti venuti alla luce solo negli anni Novanta, quando si scoprì che alcuni di essi venivano condotti in base alla razza: su afroamericani, nippoamericani e portoricani.
In conclusione, al di là del grande affresco storico offerto, presentato con ampiezza di sguardo e attenzione al dettaglio, con prosa sempre godibile e venata d’ironia, il grande merito di questo studio provocatorio è l’aver sottratto all’oblio luoghi e vicende oscure, personaggi straordinari (nel bene e nel male). La sua lettura è insomma in grado di stimolare e soddisfare la curiosità di quanti sono interessati allo svelamento della verità delle vicende umane contro ogni falsificazione storica. Perché, in ultimo è lampantemente chiaro, “La storia degli Stati Uniti è la storia di un impero”.