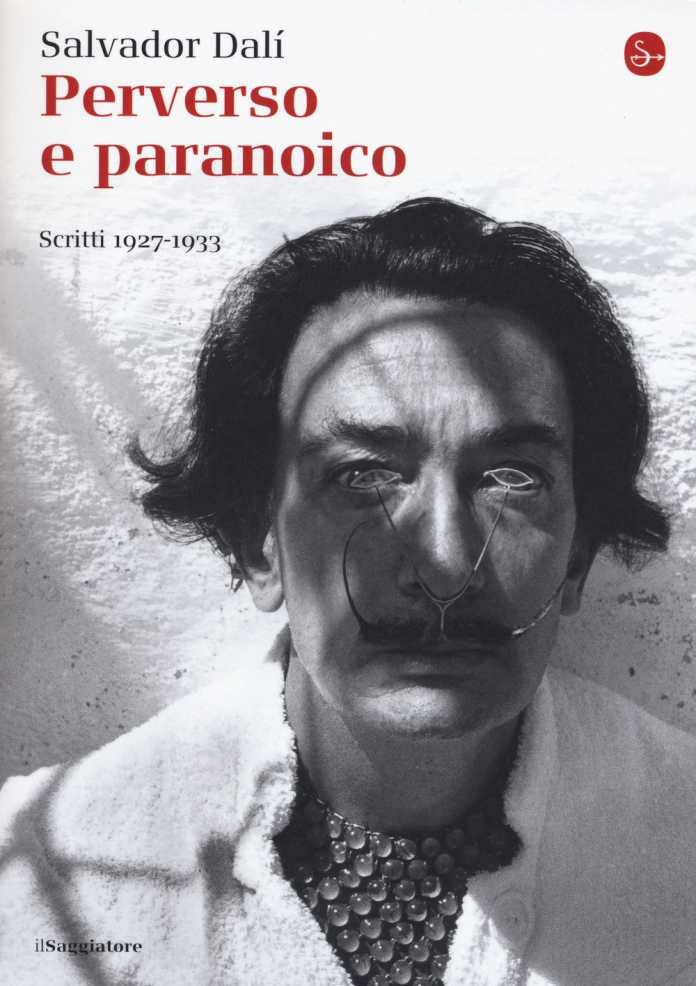«Prima di tutto ritengo indispensabile denunciare il carattere eminentemente avvilente che ha l’atto stesso di fare una conferenza e, ancor più, l’atto di ascoltarla. È dunque con ogni sorta di scuse che mi accingo a fare recidiva in un atto simile, che va senz’altro considerato quanto vi può essere di più lontano dall’atto surrealista più puro, il quale, come ha spiegato Breton nel suo secondo manifesto, consisterebbe nello scendere in strada, con la rivoltella in pugno, e cominciare a sparare a caso, sulla folla, fino all’esaurimento». Ho sempre sognato di cominciare così una conferenza, ma davanti al microfono e all’uditorio in attesa mi sono lasciato ogni volta sopraffare da un profondo senso di paranoia.
Nell’antica Grecia παράνοια indicava un generico stato di follia che adottava meccanismi lucidi, non dissimili dai normali processi cognitivi. Agli inizi del Novecento lo psichiatra tedesco Emil Kraepelin considerava la paranoia un sistema delirante duraturo e incrollabile, un delirio elaborato intellettualmente in unità coerenti, senza grossolane contraddizioni interne. Per Freud era soprattutto un tentativo di guarigione, un processo ricostruttivo in cui il paranoico ricostruisce col lavoro del suo delirio l’universo in modo tale da poterci vivere di nuovo. Per gli scrittori postmodernisti la paranoia è sia elemento tematico sia strategia narrativa, il plot della trama letteraria diventa un complotto architettato ai danni dei personaggi e del lettore. Pynchon cantava tra le pagine di Gravity’s Rainbow: «Oh, chiama il tuo avvocato, Paranoia, / Del mio culo ti lascio eterna erede!». Bob Dylan se ne serviva per ridicolizzare la caccia alle streghe anticomunista del senatore McCarthy e le paure irrazionali dell’americano medio (ma nel 1963 gli fu proibito di eseguire “Talkin’ John Birch Paranoid Blues” all’Ed Sullivan Show e dovette escludere la canzone dal suo nuovo album). Come strategia politica la paranoia serviva da collante durante la Guerra fredda per tenere separati i due blocchi, così come negli anni Novanta è servita ai creatori di Twin Peaks e X-Files per mantenere alta la tensione dello spettatore e spingerlo a guardare la puntata (o la stagione) successiva.
Tutto questo Salvador Dalí l’aveva immaginato nel 1930, quando nel saggio “L’asino putrefatto” scriveva: «Credo che sia vicino il momento in cui, attraverso un processo di carattere paranoico e attivo del pensiero, sarà possibile (in concomitanza con l’automatismo e con altri stati passivi) sistematizzare la confusione e contribuire al discredito totale del mondo della realtà», inventando in quell’istante il postmodernismo e il poststrutturalismo, partorendo Derrida, Sgarbi e “Lercio” in una volta sola, l’opera aperta di Umberto Eco e la post-verità di cui oggi discutono i filosofi – che in fondo non è altro che Orwell+internet, la notizia accettata come verità sulla base di sensazioni ed emozioni soggettive, senza bisogno di basi concrete o reali: «Se il delirio d’interpretazione», scrive Dalí, «è arrivato a collegare il senso delle immagini di quadri eterogenei esposti su una parete, basterà questo perché nessuno possa più negare l’esistenza reale di questa connessione. La paranoia si serve del mondo esterno per affermare l’idea ossessiva, con la conturbante particolarità di rendere valida anche per gli altri la realtà di questa idea». Nel 1936 lo definisce «un metodo spontaneo di conoscenza irrazionale fondato sull’associazione interpretativo-critica dei fenomeni deliranti», gettando di fatto le basi per l’elezione a presidente degli Stati Uniti di Donald Trump: basta osservare attentamente il dipinto Dormiente, cavallo, leone invisibile, riprodotto (insieme ad altri) all’interno del libro per rendersene conto.
Viene da pensare che se Dalí avesse avuto accesso a internet – lui che riteneva che «niente è venuto a dare ragione al surrealismo quanto la fotografia» –, avrebbe elogiato il Web come mezzo surrealista per eccellenza. Probabilmente il suo famoso asino putrefatto, così come l’«oggetto a funzionamento simbolico» che descrive nel saggio “Oggetti surrealisti” – «Una scarpa da donna, all’interno della quale è stato posto un bicchiere di latte tiepido, al centro di un impasto di forma duttile di colore escremenziale», corredata da «numerosi accessori», tra cui «peli del pube incollati a una zolletta» e una «piccola fotografia erotica», in cui si immerge «una zolletta di zucchero sulla quale è stata dipinta l’immagine di una scarpa» – sarebbe diventato immediatamente virale su Youtube, raggiungendo addirittura più visualizzazioni del cinghiale che fa gli auguri di Pasqua. Del resto, quale altra epoca ha fatto della «fruizione distratta» teorizzata da Walter Benjamin la propria ragion d’essere? È solo «in un momento di completa distrazione – dunque in assenza di ogni intervento dell’immaginazione» – che secondo Dalí ci si libera dall’intelligenza che si è «costituita artificialmente» e si riesce a cogliere la (sur)realtà dell’insieme. Liberarsi dall’intelligenza non è stato poi così difficile. È bastato farci un profilo Facebook e scrivere un bel post, «allegro / come un violento calcio in culo di Salvador Dalí».