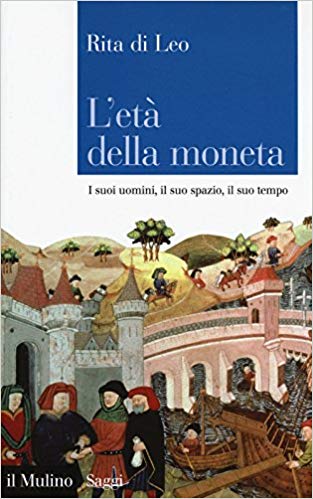Per chi apprezza le sintesi storiche di ampio respiro, intrise della capacità di saper cogliere ed enucleare, con pacata lucidità e incalzante vigore argomentativo, le dinamiche fondamentali che spiegano le trasformazioni epocali del nostro mondo, un libro come L’età della moneta di Rita Di Leo risulta indispensabile. Professore emerito di relazioni internazionali della Sapienza-Università di Roma, da anni Rita Di Leo si dedica alla riflessione sul percorso politico-sociale-economico del Novecento, esibendo una bibliografia di rilievo orientata a cogliere su scala globale il modificarsi di equilibri e rapporti di forza nel corso del secolo breve. Esperta sovietologa, da una postazione che potremmo definire “da sinistra” e supportata da un retroterra teorico marxista, ha saputo, come pochi, analizzare le cause profonde del fallimento dell’esperimento sovietico (come la studiosa ama chiamare la vicenda politico-statuale scaturita dalla Rivoluzione d’ottobre, incorporando forse in questa definizione la marcata natura di azzardo storico che l’ha caratterizzata). Ciò che la segnala come una saggista di prima grandezza, in grado di stimolare l’interesse e trasgredire “verità” consolidate, è la spiccata propensione a spaziare tra ambiti cronologici e tematici apparentemente distanti, stabilendo collegamenti in grado di costruire mappe concettuali inedite e ancorandosi a una nutrita bibliografia di riferimento. Attraverso una terminologia metonimica di sapore favolistico (l’uomo della moneta, della spada, del libro, del lavoro, i filosofi-re) e un periodare di immaginifica suggestione, Rita Di Leo sa ridurre ai minimi termini l’estensione temporale e spaziale del reale senza nulla togliere alla sua problematica complessità.
Con L’età della moneta descrive una parabola che si dipana sui tempi lunghi della storia di braudeliana memoria per sfociare nell’attualissima contemporaneità del mondo globale dominato dalla finanziarizzazione. Un viaggio incentrato sul protagonismo di coloro che vengono definiti gli “uomini della moneta”, cioè i soggetti storici che assumendo diverse forme (il mercante, l’imprenditore manifatturiero, il finanziere) sono andati contrapponendosi, dal basso Medioevo sino ai nostri giorni, prima agli “uomini della spada” (i signori feudali, i principi, i monarchi assoluti, l’aristocrazia terriera improduttiva) successivamente agli “uomini del lavoro” (il movimento sindacale, le organizzazioni e i partiti operai), riportando, pur con qualche sconfitta o arretramento (la Rivoluzione bolscevica, il compromesso socialdemocratico), una vittoria netta che ha dischiuso loro la guida della società nella totale assenza di un’ipotesi alternativa.
Si tratta di un percorso che inizia nel Quattordicesimo secolo, allorché si comincia a utilizzare su scala relativamente vasta la moneta come strumento di scambio, e gli uomini della spada che controllano la comunità feudale acquistano merci proveniente al di fuori del microcosmo autosufficiente del feudo. In esso vigeva un regime di totale dipendenza del contadino dal feudatario. Dipendenza che riguardava non solo la prestazione lavorativa, ma l’intera esistenza del sottoposto. Non si trattava di un rapporto monetizzato, per secoli non è esistita una monetizzazione del lavoro.
Uomini della moneta e uomini della spada hanno avuto una genesi e uno sviluppo separato e autonomo, sono cresciti gli uni accanto agli altri e gli uni prima degli altri. Non così, invece, per gli uomini del lavoro (“proletari” in termini marxiani), che sono generati dagli uomini della moneta: “Come ha ben spiegato Karl Marx nei Grundrisse, nel capitalismo manifatturiero i proprietari dei mezzi di produzione e gli uomini del lavoro appartengono alla stessa matrice, c’è un legame naturale a unire gli uni agli altri. Senza capitali non c’è lavoro, senza lavoro le macchine restano inattive. […] Quasi naturale la trasformazione del contadino/servo della gleba in una propria creatura al lavoro con la propria macchina, nella propria impresa dove ha investito i propri capitali.” (p. 31) Risulta così fondamentale per gli uomini della moneta legare strettamente a sé su di un piano umano-psicologico gli uomini del lavoro negando la parità di ruoli: “con modalità differenti dal borgo-comunità del medioevo europeo ma con la medesima istanza: fidelizzare la persona cui si dà lavoro al luogo di lavoro, alle regole sacrali che ieri provenivano dal castello e oggi da qualche algoritmo […]. Così è stato nella fase della prima industrializzazione europea e così si è ripetuto anche nell’ultimo quarto del Novecento, quandole grandi multinazionali hanno aperto le prime fabbriche in Asia. L’ipotesi di una parità sociale tra chi vendeva e chi comprava il suo lavoro era anni luce lontana dalle aspirazioni del bracciante del Galles del 1870 così come lo è oggi per il migrante cinese degli stabilimenti Apple del 2000 o per l’operaia etiope ingaggiata da società cinesi.” (pp.30-31)
Tra la fidelizzazione della prima industrializzazione sette-ottocentesca e la fidelizzazione del capitalismo globalizzato del Ventunesimo secolo, si colloca il Novecento (qui inteso alla Hobsbawm come secolo breve dalla Rivoluzione sovietica del 1917 al 1989), nel corso del quale si distende la “guerra” tra gli uomini della moneta e gli uomini del lavoro supportati questi ultimi dalle teorie dagli “uomini dei libri” (generali dell’esercito i cui soldati sono gli uomini del lavoro), gli intellettuali al “servizio della classe operaia”, come venivano definiti, in grado di produrre idee, programmi, pensiero critico, organizzazione. “Molto spesso il suo [dell’uomo del libro. n.d.a] universo di provenienza è quello dello strato sociale degli uomini della moneta e molto più raramente quello dell’élite della spada: in ambedue i casi la fuga dal proprio nido è il rigetto personale pre-politico della propria origine. È stato cosi nel 1200 per il prototipo cristiano, Francesco d’Assisi, e così è stato nel 1900 per il prototipo ebreo, Lev Trockij. Per entrambi la rottura con il proprio ambiente è stata di una radicalità più estrema a confronto con il nido laico-borghese da cui, nell’Ottocento-Novecento europeo, sono volati via gli altri.” (p. 34)
La figura dell’uomo del libro (nell’accezione di intellettuale sostenitore sul piano ideale e teorico di prassi e istituzioni concretizzate da determinate classi sociali) si estende, nella trama plurisecolare di Rita Di Leo, sino a inserire l’ecclesiastico medioevale, che fornisce alla società feudale gerarchizzata un supporto trascendente che la giustifica e sacralizza, l’umanista rinascimentale a libro paga del principe uomo della spada, gli illuministi del Settecento, che hanno dato posto le basi di un “altro mondo possibile” rispetto all’ordine nobiliare della spada, sino ai generali dell’esercito del lavoro (dal socialismo utopistico al socialismo scientifico).
Il maggior successo di questi ultimi è stata la Rivoluzione bolscevica del 1917. “Nel 1917, in Russia una piccola setta di uomini dei libri riesce a spezzare la catena del potere degli uomini del capitale nel luogo dove è possibile farlo […]La bomba bolscevica fa un gran rumore, non solo in Russia, ma in buona parte del mondo, e le sue conseguenze sono una lunga stagione di lotte d’ogni forma, culturale, ideologica, economica, militare, che è durata per quasi otto decenni e si è chiusa con la vittoria dell’ universo del capitale nel 1989” (pp. 42-43). Ma per circa settanta anni la sola esistenza dell’URSS ha alimentato speranze nella possibilità di un’alternativa al modello dominante in Occidente, aggregando attorno all’esercito del lavoro milioni di uomini, la cui adesione a partiti e sindacati antagonisti d’ispirazione marxista non è stata scalfita dai successivi disastri dell’universo sovietico (Berlino est nel 1953, Budapest nel 1956, Praga nel 1968) e dalla propaganda diffusa dagli uomini dei libri schierati con gli uomini della moneta proveniente sovente da un passato comunista (Arthur Koestler, George Orwell, André Gide, Ignazio Silone), che denunciava la repressione del dissenso e le difficoltà della vita quotidiana in URSS. È in questo contesto che il capitalismo nel cosiddetto “trentennio d’oro” (1945-1975) deve fronteggiare un forte movimento sindacale e partiti comunisti e socialisti in costante crescita elettorale, adattandosi al compromesso e a parziali cedimenti e concessioni. La contrattazione nazionale, le rappresentanze sindacali nelle fabbriche, le tutele sociali e il Welfare State ne sono la conseguenza. L’offensiva degli uomini della moneta inizia alla fine degli anni Settanta con figure come Ronald Reagan e Margaret Thatcher, capofila di una nuova élite politica capace d’imporre innovazione tecnologica e riorganizzazione del lavoro nelle industrie e nei servizi in modo da chiudere la stagione keynesiana. “[…] le élite finanziarie egemoni hanno reso il lavoro umano marginale, gli hanno dato mille forme precarie e infine hanno reso marginale persino l’economia reale.” (p. 54)
Sulle cause del tracollo sovietico, che tanto ha contribuito al tramonto dell’ipotesi alternativa degli uomini del lavoro, Rita Di Leo non si sofferma più di tanto, richiamando a questo punto altre sue pubblicazioni, il cui contenuto va riassumendo nel presente volume.
La svolta decisiva viene individuata nell’eliminazione operata da Stalin degli intellettuali bolscevichi che avevano fatto la rivoluzione e che avevano attorniato Lenin (che vengono chiamati i filosofi-re), uomini dei libri dotati di un sapere di cui erano del tutto sprovvisti gli ex-operai chiamati da Stalin a dirigere le industrie e le aziende agricole e che, nella loro incompetenza e inadeguatezza, si adattavano ad assumere un ruolo di meri esecutori di disposizioni provenienti dall’alto, da quegli uffici della pianificazione diretti da altri ex-operai cooptati dal partito, costretti a convogliare direttive di estrema semplicità ai terminali industriali, onde permettere l’esecuzione delle mansioni. Lenin aveva intuito la necessità di affidare l’apparato produttivo sovietico all’esperienza dei tecnici dell’antico regime e aveva inaugurato la Nep, consapevole dell’arretratezza in cui si dibatteva la società russa e della necessità di fronteggiare l’isolamento economico e politico che si profilava una volta fallite le rivoluzioni in Occidente. Non vivrà a sufficienza per elaborare i contenuti di una nuova fase. Con i piani quinquennali si afferma l’operaismo e con esso ai posti di comando nell’economia e nell’amministrazione si collocano i funzionari di partito ex-operai e s’instaura un aperto ostracismo per chi operaio non è, sia intellettuale, tecnico o contadino. “Le incapacità non saranno mai ufficialmente ammesse da Stalin e tanto meno dai suoi immediati successori. E la ragione sta nel fatto che l’ammissione avrebbe rotto l’equilibrio politico che teneva in piedi l’esperimento nonostante le difficoltà quotidiane. L’equilibrio produceva consenso di massa al partito poiché teneva fede al rovesciamento sociale promesso: i lavoratori manuali erano andati al posto dei padroni in fabbrica e avevano occupato le loro abitazioni, i diritti politici erano stati negati ai borghesi e ai popeRita, chiuse le porte dell’istruzione superiore ai loro eredi. Ma soprattutto, secondo il senso comune corrente, i lavoratori manuali, se lavoravano bene […], potevano salire ai posti di comando, governare il paese.” (p. 61)
Negli ultimi decenni di vita dell’Unione Sovietica, all’economia formale dettata dal piano con tutte le sue inefficienze è andata gradatamente affiancandosi un’economia informale “in nero” che si realizzava nelle stesse sedi e con gli stessi mezzi dove si realizzava il piano, ma orientata a un mercato “sommerso” incentrato sulla legge della domanda e dell’offerta. È andato così crescendo all’interno della società sovietica uno strato di “cripto” uomini della moneta che, al momento del passaggio al capitalismo ed alle privatizzazioni, si sono pappati gli impianti statali e le risorse naturali, anche grazie ai rapporti stretti con membri della nomenclatura.
La parte del mondo in cui l’”uomo della moneta” non si è trovato nella necessità di contrapporsi all’ “uomo della spada” è la nazione statunitense, se si esclude la fase della guerra per l’indipendenza, dove per altro il potere da combattere si situava al di là dell’oceano. I primi immigrati nel nuovo mondo erano già formati come uomini della moneta con una mentalità finalizzata ad affermarsi attraverso la produzione di merci o la messa a frutto di terreni o mandrie una costruzione antropologica modellata dalla dottrina protestante. “Il consenso è basato sul principio della libertà di azione del singolo, sull’assioma dell’uomo libero di fare e avere senza limiti se non quelli posti dall’Antico Testamento. È l’offerta degli uomini della moneta a un popolo per il quale l’universo deve funzionare secondo le loro aspettative. Sono aspettative nate e consolidate rifiutando utopie politiche europee, che promettono la parità tra interessi divergenti, la parità tra strati sociali concorrenti.” (p. 113). La società americana non ha conosciuto la fase feudale (le piantagioni schiavistiche del sud la rievocavano nella forma, ma non nella sostanza mercantile e monetaria) e nemmeno quella della lotta tra borghesia e aristocrazia per la conquista dello Stato, della legislazione e del potere coercitivo della forza. Da una società tribale (la civiltà dei nativi indigeni soppressa dai nuovi arrivati) si è passati direttamente all’industrializzazione capitalista (a differenza dell’America centrale e meridionale colonizzata da uomini della spada che vi hanno esportato il modello feudale nella variante monoculturale). E brevemente e in modo frammentario e disorganizzato, in essa si è manifestata, a inizio Novecento, qualcosa che assomiglia alla lotta di classe. “È stato l’industrialismo a cambiare lo stato delle cose. Nelle grandi fabbriche l’operaizzazione di massa ha integrato gli alieni sulla base di un do ut des. Gli emigrati senza mestiere, senza alfabetizzazione […] si sono identificati con il luogo dove avevano ottenuto lavoro, retribuzione, ruolo professionale. È stata un’identificazione dove la riconoscenza per quello che avevano ottenuto superava il desiderio di lottare per ottenere di più” (p. 116). Data questa premessa i conflitti di lavoro di stampo europeo erano percepiti come manifestazioni di aperta ostilità verso la società che li aveva accolti. Nella nazione statunitense si celebra l’assoluto dell’uomo della moneta: “Nella democrazia presidenziale americana il fare del governo proviene formalmente dall’esercizio del voto di scambio reso tale dalla flessibilità della democrazia rispetto alla rigidità delle monarchie e dell’assolutismo nobiliare. Lo scambio tra le parti in competizione riguarda: far eleggere alle massime cariche il “proprio” rappresentante, far approvare da organi democraticamente eletti le politiche di distribuzione delle risorse secondo le richieste delle élite locali, far eleggere nei corpi intermedi funzionari che operino in collegamento con gli interessi di chi li ha fatti eleggere”. (pag. 119)
Se la posizione dominante dell’uomo della moneta ha sbarazzato il campo dal paradigma alternativo agito dagli uomini del lavoro supportati dagli uomini dei libri, alla sua egemonia nel Ventunesimo secolo si contrappone la parte del mondo su cui si è imposto il potere delle élite teocratiche, spazi nei quali la naturalità liberata da vincoli praticata e teorizzata dagli uomini della moneta e dai loro uomini del libri è raffrenata dagli uomini del Libro (con la lettera maiuscola), vale a dire del Corano (con tanto di taglio di mano e lapidazione dell’adultera). Laddove in Occidente gli uomini del libro subiscono l’oscuramento nei confronti di menti e comportamenti e le masse accorrono nei supermercati per celebrare il rito dell’avere, le élite teocratiche dettano l’agenda alla vita quotidiana dei fedeli. Paradossalmente la storia ha subito una curvatura che ha di nuovo contrapposto come nel medioevo agli uomini della moneta gli uomini dei libri sacri. “Per la prima volta nella storia colui che in forme differenti aveva sempre deciso per il mondo intero è stato spinto dalla logica della globalizzazione finanziaria a far sedere al proprio tavolo le élite di paesi che in passato erano stati terreno di sue conquiste militari.” (p. 145)
In conclusione il Ventunesimo secolo ha decretato la sconfitta degli uomini dei libri, che nell’Ottocento e nel Novecento hanno prodotto teorie, idee, progetti, utopie funzionali alla prospettiva di governare l’agire e il sentire comune sottraendolo allo stato di natura basato sulla pulsione al fare e all’avere e all’ipostasi della legge del più forte. Respinta la guida dei filosofi-re, gli uomini del lavoro hanno abbandonato partiti, sindacati, lotte e rivendicazioni e si sono affidati a chi promette di tenere lontano i migranti e il protezionismo dalle merci cinesi.
Si può, forse, rimproverare a Rita Di Leo un eccesso di pessimismo nel chiudere spiragli a un possibile rilancio di una prospettiva alternativa o anche solo di riformismo forte. È indubbio, tuttavia, che le questioni poste colgano nel segno, fotografando una tendenza prevalente nel vuoto di antagonismo e minaccia di assumere una dimensione epocale (ancora una volta la lunga durata braudeliana).
Il libro interroga implicitamente la sinistra (che ne è del profetismo marxista? E del materialismo storico-dialettico? È vero che il capitalismo ha i secoli contati?). E in particolare, gli intellettuali, che dovrebbero ritornare ad assumere il ruolo di filosofi-re di un esercito disperso, riattivando una soggettività in controtendenza con il flusso (inesorabile?) della storia.