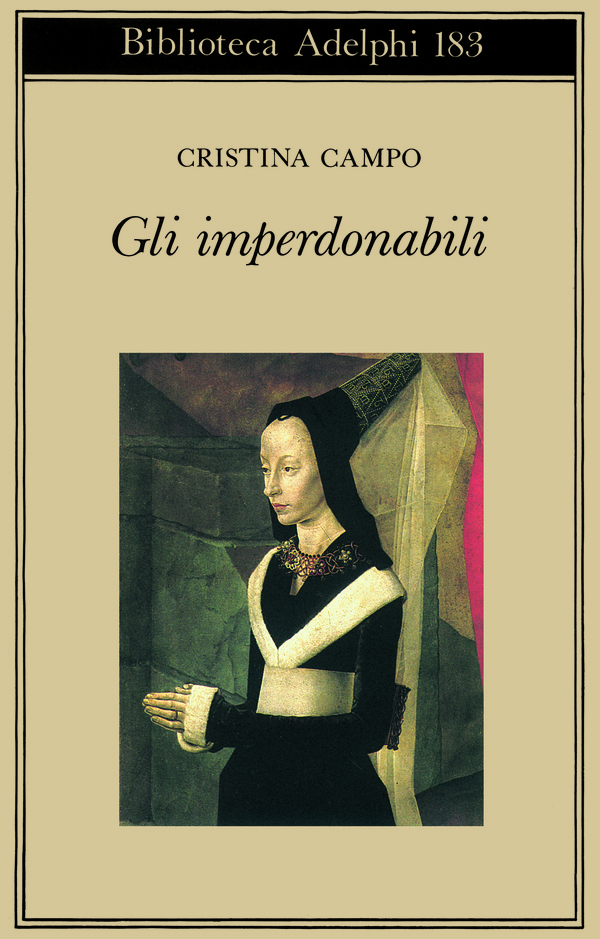Poche pagine soltanto di scritti letterari, se escludiamo le poesie, Cristina Campo (pseudonimo di Vittoria Guerrini) dedicò a chi, ieri, ha sostato nei pressi della sua amicizia. A chi, oggi, da una lontananza inappagata, voglia avvicinarsi a quel fuoco che non smette di ardere, Cristina lancia al cielo presagi d’incendi che potrebbero, dovrebbero, devastare quest’immutabile e disarmonico mondo delle lettere.
 Chi si è accorto di quel fremito inalterato non potrà più generare futilità senza che egli stesso d’improvviso si tramuti in sabbia e macerie polverose, egli non potrà che accogliere l’occhio vigile e severo d’una donna capace di generosità incommensurabile, d’attenzione mai paga né vinta dalla stanchezza: “ho visto finalmente il suo racconto su “Paragone”. L’inizio mi sembra di una lentezza esasperante, pieno di cose inutili, andrebbe forse ridotto della metà; ma dai momento nei quale i due ragazzi si mettono a ‘fare l’opera’ (dialogo della stanza da letto) c’è un ritmo meraviglioso, tutto danzato…” (Da Lettere a un amico lontano, Scheiwiller 1989).
Chi si è accorto di quel fremito inalterato non potrà più generare futilità senza che egli stesso d’improvviso si tramuti in sabbia e macerie polverose, egli non potrà che accogliere l’occhio vigile e severo d’una donna capace di generosità incommensurabile, d’attenzione mai paga né vinta dalla stanchezza: “ho visto finalmente il suo racconto su “Paragone”. L’inizio mi sembra di una lentezza esasperante, pieno di cose inutili, andrebbe forse ridotto della metà; ma dai momento nei quale i due ragazzi si mettono a ‘fare l’opera’ (dialogo della stanza da letto) c’è un ritmo meraviglioso, tutto danzato…” (Da Lettere a un amico lontano, Scheiwiller 1989).
Gli echi di cui Cristina Campo si fece carico non permettono nessuno sfibramento dell’attenzione: soltanto attraverso di essa il poeta può condurre la decifrabilità della “pura poesia”, attraverso quell’atto che tende a rendere inseparabili le cose della scrittura: “Se qualche volta scrivo è perché certe cose non vogliono separarsi da ma come io non voglio separarmi da loro. Nell’atto di scriverle esse penetrano in me per sempre – attraverso la penna e la mano – come per osmosi”. Severità, non minaccia – antichità che non riesuma ma inventa rendendo vive di grande vita una storia, una narrazione. La forma bizantina si anima d’un fuoco indescrivibile ma leggibile come un antico testo di sapienza.
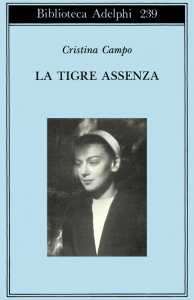 L’Abbazia è la casa di Cristina. Le sue letture si fondano dove la liturgia di Simone Weil si sommava alle spinte frenetiche capaci di condurre una vita fin sulla soglia terribile, ma al tempo stesso appagante, della fine (esplicative, a questo proposito, le lettere scambiate tra la Weil e Joë Bousquet durante l’anno di guerra 1942). Lo sguardo di seppe subito dove posarsi, dove apporre gli strumenti della propria meditazione, i frutti che oggi sono raccolti nel volume adelphiano de Gli imperdonabili (1987). Nessuno come lei ci ha detto che la nostra vita è scagionata attraverso la percezione, e che la stesso percezione si fonda sull’inflessibile esercizio della vita, al pari dello studio, della fraternità e della religione: “La liturgia, iniziatrice sovrana, splende, lume coperto, soltanto sulle rocce più inaccessibili – ii Monte Athos, qualche vetta benedettina – o in minimi colombari perduti, dimenticati nelle metropoli. Chi resterà a testimoniare dell’immensa avventura, in un mondo che confondendo, separando, opponendo o sovrapponendo corpo e spirito ii ha perduti entrambi e va morendo di questa perdita? Nel tempo vaticinato in cui i vecchi vedranno visioni e i giovani sogneranno sogni, forse unicamente i poeti, che hanno dimora simultanea nella vecchiaia e nella fanciullezza, nel sogno e nella visione, nel senso e in ciò a cui ii senso allude perennemente”.
L’Abbazia è la casa di Cristina. Le sue letture si fondano dove la liturgia di Simone Weil si sommava alle spinte frenetiche capaci di condurre una vita fin sulla soglia terribile, ma al tempo stesso appagante, della fine (esplicative, a questo proposito, le lettere scambiate tra la Weil e Joë Bousquet durante l’anno di guerra 1942). Lo sguardo di seppe subito dove posarsi, dove apporre gli strumenti della propria meditazione, i frutti che oggi sono raccolti nel volume adelphiano de Gli imperdonabili (1987). Nessuno come lei ci ha detto che la nostra vita è scagionata attraverso la percezione, e che la stesso percezione si fonda sull’inflessibile esercizio della vita, al pari dello studio, della fraternità e della religione: “La liturgia, iniziatrice sovrana, splende, lume coperto, soltanto sulle rocce più inaccessibili – ii Monte Athos, qualche vetta benedettina – o in minimi colombari perduti, dimenticati nelle metropoli. Chi resterà a testimoniare dell’immensa avventura, in un mondo che confondendo, separando, opponendo o sovrapponendo corpo e spirito ii ha perduti entrambi e va morendo di questa perdita? Nel tempo vaticinato in cui i vecchi vedranno visioni e i giovani sogneranno sogni, forse unicamente i poeti, che hanno dimora simultanea nella vecchiaia e nella fanciullezza, nel sogno e nella visione, nel senso e in ciò a cui ii senso allude perennemente”.
Alle spalle di una siffatta esperienza troviamo personalità della letteratura e del pensiero unite sotto il segno della “grazia pensosa”: Katherine Mansfield, Hugo von Hofmannsthal, John Donne, Simone Weil… Sono questi gli “amici lontani” a cui s’abbevererà la sua instancabile mente. Per essi l’occhio di questa donna, prima di andarsene definitivamente, lavorò a lungo senza che i legami diventassero oltre misura pesanti. Si conosce, del resto, il progetto d’una rivista che avrebbe dovuto chiamarsi “L’attenzione”. Tutta l’arte venne da lei applicata con l’ala d’una maestria intelligente e sobria, allontanando il presente e il futuro dal compimento del prodigio, ritenendo il tempo un tramite da annichilire non appena attuato il trasbordo nella storia da salvare dalla condanna, dall’immersione nell’oblio (così come la Venise sauvée di Weil). Anche se l’unica dimora fosse stato un sepolcro, ebbene in tal luogo Cristina Campo avrebbe difeso il suo sguardo a quelli degli amici (gli amici di Hofmannsthal) dal pensiero vacillante dei morti, dalle conclusioni luttuose di vite sprofondate nel dolore. Suoi nutrimenti furono la dolcezza misteriosa della fiaba, la lotta contro il terrore e la follia notturna del mostro venuto a conoscenza della Bella – la scioltezza d’una espressione poetica rivelata come un salmo, come un’infinita variazione di Bach o una cantata gregoriana.
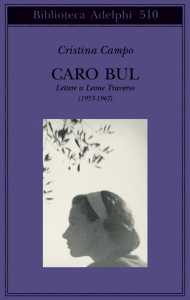 La privata liturgia di Cristina Campo è preconciliare, testimone ultima di una letteratura vissuta come fonte principale d’esistenza, contemplazione monacale della propria fede. Null’altro. Oggi noi spettatori, se penetriamo in questo mondo affascinante, al limite di un’erudizione inaffrontabile, non possiamo che sottostare a una lettura che ci viene incontro con massima naturalezza, come di fronte a ciò che esiste da sempre, che risale fino a noi da epoca remota. Nasce così una contemplazione di rara efficacia, come se davvero fosse nostro il merito. Sappiamo che non è così, ma Cristina sarebbe contenta di vedere questo fenomeno, accorgersi che le sue parole agiscono fuori da ogni genere di controllo. Un’estrema fedeltà si stabilisce fra i suoi posteri. La nascita di un dialogo tra i vivi e i morti, essendo questi ultimi ormai angeli di sé stessi, e angeli di tutti noi.
La privata liturgia di Cristina Campo è preconciliare, testimone ultima di una letteratura vissuta come fonte principale d’esistenza, contemplazione monacale della propria fede. Null’altro. Oggi noi spettatori, se penetriamo in questo mondo affascinante, al limite di un’erudizione inaffrontabile, non possiamo che sottostare a una lettura che ci viene incontro con massima naturalezza, come di fronte a ciò che esiste da sempre, che risale fino a noi da epoca remota. Nasce così una contemplazione di rara efficacia, come se davvero fosse nostro il merito. Sappiamo che non è così, ma Cristina sarebbe contenta di vedere questo fenomeno, accorgersi che le sue parole agiscono fuori da ogni genere di controllo. Un’estrema fedeltà si stabilisce fra i suoi posteri. La nascita di un dialogo tra i vivi e i morti, essendo questi ultimi ormai angeli di sé stessi, e angeli di tutti noi.
Attualmente Cristina Campo si presenta come una marziana in un campo di menti stordite dal commercio intellettuale e omologato a logiche outlet, e marziani sono i pochi che si trovano alle prese con libri che definire “inattuali” appare come un momento di riflusso etilico. Il suo gesto del lavoro sulla terra lascia da parte qualunque tirannia epocale (il ’900 ne è pieno), prendendo dentro di sé quelle cose che da lei non volevano separarsi, e ridonandole agli amici, presenti ai suoi anni e ineluttabilmente sempre più “postumi”. Oggi, quando pochi ormai sembrano seccati da una misera inguaribilità, l’opera di Cristina Campo punta valente e sicura il dito verso l’etica di un’esistenza, appunto civile: se fossimo ancora in tempo per fare qualcosa, per averne un po’ di consolazione.