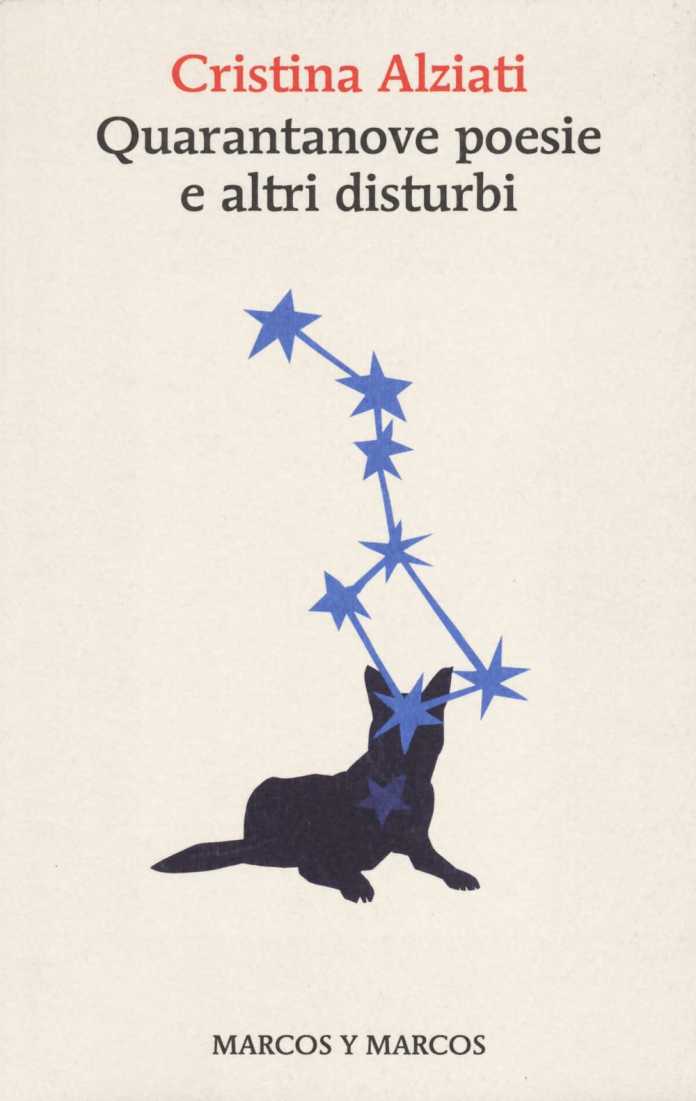A questo punto occorre dire che nel nostro peggior presente, costellato di punteruoli e deflagrazioni, dentro a tutto questo esiste e resiste ancora chi per virtù, storia personale e poetica impavida, scrive poesie che trapassano il dolore reale e guardano ancora alle figure favolose dei boschi, dei germogli, delle albe: cose e misure temporali che non spargono equivoci intorno. Cristina Alziati dona la propria metrica esigente, il proprio libero pensiero accompagnato da una fermezza narrativa che costringe a fermarsi e ascoltare. In questo suo nuovo libro, vicende personali e collettive si ritrovano nel segno di “civiltà” e “politica” già messe in evidenza da Fabio Pusterla a proposito della precedente raccolta dell’autrice, Come non piangenti, uscita dodici anni fa.
 È vero che certi versi convincono persone care e meno care a svegliarsi da sonni troppo indulgenti o oppiacei, e che altri versi fanno barriera agli incendi detonanti del risucchio della storia. È vero che il destino umano può ritrovarsi in poesie di Hölderlin, Fortini e Brecht, rincasanti grazie all’attenzione inesausta di Cristina pronta a farne scuola, lavoro, e espansione di pensiero. Nuovo, difficile, contro le giustificazioni odierne che scompigliano i repertori veri, e frammentano le rocce dure dei canoni dentro ammassi di polvere impercorribili (e irricevibili).
È vero che certi versi convincono persone care e meno care a svegliarsi da sonni troppo indulgenti o oppiacei, e che altri versi fanno barriera agli incendi detonanti del risucchio della storia. È vero che il destino umano può ritrovarsi in poesie di Hölderlin, Fortini e Brecht, rincasanti grazie all’attenzione inesausta di Cristina pronta a farne scuola, lavoro, e espansione di pensiero. Nuovo, difficile, contro le giustificazioni odierne che scompigliano i repertori veri, e frammentano le rocce dure dei canoni dentro ammassi di polvere impercorribili (e irricevibili).
Flotte navali di note potenze, e treni della fuga compaiono in alcune pagine di questa raccolta, subito afferrati in un debito che non ammette soluzione, e trincerati in ciò che la letteratura può dare al suo meglio, traendo il nome giusto dai dizionari, rammemorando agli inermi e agli inerti che la poesia è soggetto attivo – e non oggetto da sfoggiare in salotti librari o peggio. Gli anni in questo libro ci sono tutti, definiti da bollettini bellici e perdite, dentro il realismo di una parola che induce a seguire le “avvertenze”. Via dal linguaggio furbesco. Nessuno verrà meno al compito di lavarsi dentro una “notte spessa”, al cospetto di un “pascolo alpino” che dice di esistere nel colmo dei secoli. È questo che Alziati verifica in ogni poesia: il tempo è propenso a durare fin dall’inizio ma è il nostro balbettio a renderlo oggi tanto fragile da sfilacciarsi. Il paesaggio ne risente, l’onere dello sguardo sta nella sua caparbietà, lo ritroviamo nei versi più adesi al baratro del reale mentre lo sguardo (la scrittura) percorre l’interno dei treni merci pieni di gente in fuga. È sempre la cenere a soffocare il respiro, ma è sempre la vita a passare il deserto (“Qui non c’era deserto”) fin quando il piede si allena sulle parole.
I “disturbi” si collocano nella realtà della poesia, sono il segno della fine delle illusioni, ma l’autrice non sta in disparte, ha ben svegli i sistemi conoscitivi tutti volti allo svelamento del mondo attuale. Buona verso di noi nel concedere germogli e fermi-immagine dai colori e contorni netti e irrevocabili. Non si commenta Fortini e Alziati, si legge la loro poesia senza giustificarsi, o cedere all’invasiva distrazione dei nostri giorni indistintamente filmati.