Ci colleghiamo con Google Meet e appare subito la bella zazzera aggrovigliata di Colson Whitehead, uomo dabbene e dalle movenze eleganti, autore di otto romanzi, tra cui La ferrovia sotterranea (Sur, 2017), I ragazzi della Nickel (Mondadori, 2019) e Il ritmo di Harlem (Mondadori, 2021). I primi due sono stati decorati ognuno da un Premio Pulitzer: se si pensa che lo splendido quartetto composto da Thomas Pynchon, Don DeLillo, Paul Auster e Jonathan Franzen non l’ha mai vinto, si capisce subito quanto Colson (ma i suoi nomi “originari” sono Arch e Chipp) sia un tipo davvero tosto.
L’incontro telematico organizzato dalla casa editrice Mondadori per l’arrivo di Whitehead in Italia – è ospite del Festival Internazionale di Roma “Letterature”, con il reading di un racconto preparato a bella posta per l’evento, Il comico – coinvolge blogger e testate online. L’autore newyorkese, classe ’69, laureato a Harvard, è sereno, disteso nel volto e dispostissimo a raccogliere gli spunti proposti dagli intervistatori via etere, che si succedono nelle domande seguendo un ordine inscalfibile. Ça va sans dire, siamo tutti “onoratissimi” di poter conversare con lui.
 “Scrivere romanzi storici che esplorano e rappresentano periodi passati – osserva Whitehead con voce stentorea – offre sentieri creativi differenti. Alcuni dei miei primi romanzi, come John Henry Festival e Zona 1, erano ambientati nel contemporaneo. Sono convinto della bontà di questa massima: se non si ha niente da dire su un argomento, è meglio tacere. Riguardo alla raffigurazione della contemporaneità ho pensato che fosse ormai arrivato per me il momento di tacere. Per tale motivo mi sono rivolto al genere storico. Negli ultimi testi mi sono messo nei panni di chi è stato testimone di un’altra epoca. E, quanto alla documentazione, ho utilizzato ad esempio i memoir degli schiavi che vivevano nelle piantagioni: mi hanno praticamente fornito il lessico. Ho rubato dalla loro prosa sostantivi, verbi, aggettivi. In Il ritmo di Harlem, invece, fondamentali sono stati gli archivi dei giornali. Sono andato al New York Times e ricordo di aver letto in una pagina del 1961 la campagna elettorale per la sindacatura e, affianco, la pubblicità di un tizio che vendeva mobili, due attestazioni della vita di quel periodo. Insomma, il lavoro di documentazione paga enormemente”.
“Scrivere romanzi storici che esplorano e rappresentano periodi passati – osserva Whitehead con voce stentorea – offre sentieri creativi differenti. Alcuni dei miei primi romanzi, come John Henry Festival e Zona 1, erano ambientati nel contemporaneo. Sono convinto della bontà di questa massima: se non si ha niente da dire su un argomento, è meglio tacere. Riguardo alla raffigurazione della contemporaneità ho pensato che fosse ormai arrivato per me il momento di tacere. Per tale motivo mi sono rivolto al genere storico. Negli ultimi testi mi sono messo nei panni di chi è stato testimone di un’altra epoca. E, quanto alla documentazione, ho utilizzato ad esempio i memoir degli schiavi che vivevano nelle piantagioni: mi hanno praticamente fornito il lessico. Ho rubato dalla loro prosa sostantivi, verbi, aggettivi. In Il ritmo di Harlem, invece, fondamentali sono stati gli archivi dei giornali. Sono andato al New York Times e ricordo di aver letto in una pagina del 1961 la campagna elettorale per la sindacatura e, affianco, la pubblicità di un tizio che vendeva mobili, due attestazioni della vita di quel periodo. Insomma, il lavoro di documentazione paga enormemente”.
 La ferrovia sotterranea, che ha ricevuto anche il National Book Award nel 2016, è stata definita dalla giuria del Pulitzer “un’intelligente fusione di realismo e allegoria che coniuga le brutture della schiavitù e il dramma della fuga in un mito che parla all’America contemporanea”. Questo ci consente di porre Whitehead sotto l’egida di uno storicismo temperato da istanze simboliche e serie denunce sociali, già presenti peraltro nel romanzo “speculativo” L’intuizionista, opera d’esordio datata al 1999. Alla domanda se la serie televisiva della Ferrovia sotterranea, diretta da Barry Jenkins e andata in onda nel 2021, gli sia piaciuta, Whitehead risponde non mostrando il minimo alone d’incertezza: “È forse la cosa migliore che mi sia capitata nella vita. L’ho vista due o tre volte e mi ha commosso. Non avrei potuto pensare a un adattamento migliore”.
La ferrovia sotterranea, che ha ricevuto anche il National Book Award nel 2016, è stata definita dalla giuria del Pulitzer “un’intelligente fusione di realismo e allegoria che coniuga le brutture della schiavitù e il dramma della fuga in un mito che parla all’America contemporanea”. Questo ci consente di porre Whitehead sotto l’egida di uno storicismo temperato da istanze simboliche e serie denunce sociali, già presenti peraltro nel romanzo “speculativo” L’intuizionista, opera d’esordio datata al 1999. Alla domanda se la serie televisiva della Ferrovia sotterranea, diretta da Barry Jenkins e andata in onda nel 2021, gli sia piaciuta, Whitehead risponde non mostrando il minimo alone d’incertezza: “È forse la cosa migliore che mi sia capitata nella vita. L’ho vista due o tre volte e mi ha commosso. Non avrei potuto pensare a un adattamento migliore”.
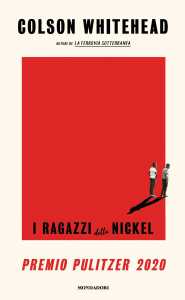 I ragazzi della Nickel si rifà a ciò che realmente accadeva alla Dozier School for Boys in Florida, dove i ragazzi condannati per reati minori subivano abusi e violenze di ogni tipo: una fabula cruda e priva di peli sulla lingua. “L’angolazione, il modo di narrare – se al presente o al passato, se in prima persona o in terza – sono cose che vengono in un secondo momento. Tutto nasce da un’idea, dall’ispirazione iniziale. Credo che i generi letterari abbiano pari dignità. Il realismo, i dispositivi immaginari, l’hard boiled sono soltanto strumenti. Mentre La ferrovia sotterranea è qualcosa che ho inventato per costruire la mia America, I ragazzi della Nickel si attiene ai fatti, a un quadro preciso. Si tratta di due maniere diverse di raccontare il mondo. C’è snobismo, a mio giudizio, nella distinzione tra letteratura alta e letteratura di genere. Negli Stati Uniti nessuno ci fa più caso. Dentro i romanzi di Cormac McCarthy, Toni Morrison, Philip Roth coesistono elementi reali e situazioni fantastiche: è letteratura alta o letteratura di genere? Credo stia lì a pensarci soltanto chi ha letture limitate. Questa gente non la invitiamo ai barbecue, dove si mangia carne arrostita e si beve birra; può tranquillamente continuare a consumare vino e formaggio nei salotti”.
I ragazzi della Nickel si rifà a ciò che realmente accadeva alla Dozier School for Boys in Florida, dove i ragazzi condannati per reati minori subivano abusi e violenze di ogni tipo: una fabula cruda e priva di peli sulla lingua. “L’angolazione, il modo di narrare – se al presente o al passato, se in prima persona o in terza – sono cose che vengono in un secondo momento. Tutto nasce da un’idea, dall’ispirazione iniziale. Credo che i generi letterari abbiano pari dignità. Il realismo, i dispositivi immaginari, l’hard boiled sono soltanto strumenti. Mentre La ferrovia sotterranea è qualcosa che ho inventato per costruire la mia America, I ragazzi della Nickel si attiene ai fatti, a un quadro preciso. Si tratta di due maniere diverse di raccontare il mondo. C’è snobismo, a mio giudizio, nella distinzione tra letteratura alta e letteratura di genere. Negli Stati Uniti nessuno ci fa più caso. Dentro i romanzi di Cormac McCarthy, Toni Morrison, Philip Roth coesistono elementi reali e situazioni fantastiche: è letteratura alta o letteratura di genere? Credo stia lì a pensarci soltanto chi ha letture limitate. Questa gente non la invitiamo ai barbecue, dove si mangia carne arrostita e si beve birra; può tranquillamente continuare a consumare vino e formaggio nei salotti”.
Il ritmo di Harlem – ma il titolo in inglese suona con uno springsteeniano Harlem Shuffle – è un romanzo poliziesco ambientato, ovviamente, a New York negli anni ’60. “Harlem è un quartiere molto dinamico – prosegue Whitehead, per nulla affaticato dalla raffica di interrogativi catodici –, che purtroppo ha una forte componente di criminalità. Tuttavia, c’è una parte di persone oneste, che lavorano, che vanno a scuola, che vivono normalmente. Mi sono concentrato sul côté malavitoso, perché il cittadino ossequente e ligio alle leggi suscita meno interesse di quello che le vìola”.
Sia nei Ragazzi della Nickel che nel Ritmo di Harlem emerge una sorta di duplicità, di conflitto: da un lato abbiamo Elwood Curtis, idealista afroamericano, che crede in un cambiamento, laddove il cinico Jack Turner è convinto del contrario; dall’altro c’è una scissione interna al protagonista, il Ray Carney probo commerciante e il Ray Carney che accetta compromessi con la teppa. E come nascono nella scrittura di Whitehead queste antinomie morali? “In verità, dipende dalla vicenda. Non penso di essere un autore che è consciamente alle prese con questioni etiche. Certo, i dilemmi ci sono e devono essere risolti. Ma nel primo caso sono descritte due maniere contrapposte di affrontare la vita, l’ottimista e il pessimista, due filosofie incompatibili. Differente è la vicenda del Ritmo di Harlem: un uomo che cerca di restare a galla in un mondo che lo penalizza per via della sua razza. Un personaggio che si conosce, si vede, si autogiudica e che ho provato a effigiare nella sua quotidianità”.
Un autore incantato dall’atmosfera di New York è Jonathan Lethem (per non parlare del Pynchon di V.). Ma si avverte una dieresi sostanziale rispetto alla N.Y. di Whitehead, maggiormente asciutta, corrugata. Le ultime righe del Ritmo di Harlem recitano corruscamente: “Si diresse verso la metropolitana. Doveva scambiare due parole con il suo contatto per le pietre preziose, e il telefono era da escludere. L’ufficio del contatto era in 90th Street all’altezza di Second Avenue, e quel giorno la metropolitana era un casino, esplosione di una tubatura dell’acqua nell’East Side. Poi aveva appuntamento con Elizabeth, per andare a vedere una casa in Strivers’ Row. Vendita giudiziaria. Riverside Drive era carino, ma non potevi lasciarti sfuggire un’occasione in Strivers’ Row. Se ci riuscivi. Era un isolato bellissimo, e certe sere era così fresco e silenzioso che non sembrava neppure di vivere in città”.
 Ed ecco qual è la N.Y. di Whitehead: “Se dovessi mai pronunciarmi in maniera definitiva sulla città, potrei concludere lì la mia carriera di scrittore. Continuo ad avere idee mobili su N.Y.: sono tutti tentativi di dire qual è la mia N.Y. Ne ho parlato in forma allegorica (nell’Intuizionista), in forma saggistica, realistica etc. Sono sempre alla ricerca di essa, senza mia carpire la versione finale. Quando mi dedicavo al Colosso di New York (saggio del 2003, edito da Mondadori nel 2004, ndr), mi domandavo spesso: molti grandi del passato hanno raccontato N.Y., come farò io, così piccolo rispetto a loro? Quest’ansia ora mi è scivolata via di dosso. Se scrivo di schiavitù o di guerra, so che già qualcuno ne ha parlato meglio di me. Se scrivo di guerra c’è stato Omero, se scrivo di schiavitù c’è stata Toni Morrison. Provo soltanto a lavorare al meglio delle mie potenzialità. Se riuscirò a essere bravo, sarò in buona compagnia”.
Ed ecco qual è la N.Y. di Whitehead: “Se dovessi mai pronunciarmi in maniera definitiva sulla città, potrei concludere lì la mia carriera di scrittore. Continuo ad avere idee mobili su N.Y.: sono tutti tentativi di dire qual è la mia N.Y. Ne ho parlato in forma allegorica (nell’Intuizionista), in forma saggistica, realistica etc. Sono sempre alla ricerca di essa, senza mia carpire la versione finale. Quando mi dedicavo al Colosso di New York (saggio del 2003, edito da Mondadori nel 2004, ndr), mi domandavo spesso: molti grandi del passato hanno raccontato N.Y., come farò io, così piccolo rispetto a loro? Quest’ansia ora mi è scivolata via di dosso. Se scrivo di schiavitù o di guerra, so che già qualcuno ne ha parlato meglio di me. Se scrivo di guerra c’è stato Omero, se scrivo di schiavitù c’è stata Toni Morrison. Provo soltanto a lavorare al meglio delle mie potenzialità. Se riuscirò a essere bravo, sarò in buona compagnia”.
Le ultime domande volgono verso la società americana, il pericolo della cancel culture, la pandemia, le nuove avventure letterarie. “Il lockdown è stato un momento molto creativo per me. Subito dopo aver terminato Il ritmo di Harlem, ho iniziato a mettere in piedi il sequel. Ero abituato a rimanere sulla scrivania fino alle tre del pomeriggio. Con l’arrivo dello smart-working ho potuto scrivere il doppio… Al centro del racconto che presento qui a Roma ho inserito un comico che sta cercando il suo posto nel mondo. Allo stesso modo in cui io sto cercando di capire quale sarà il prossimo Colson. Sono in attesa di tracciare la mia nuova strada per il futuro”.



