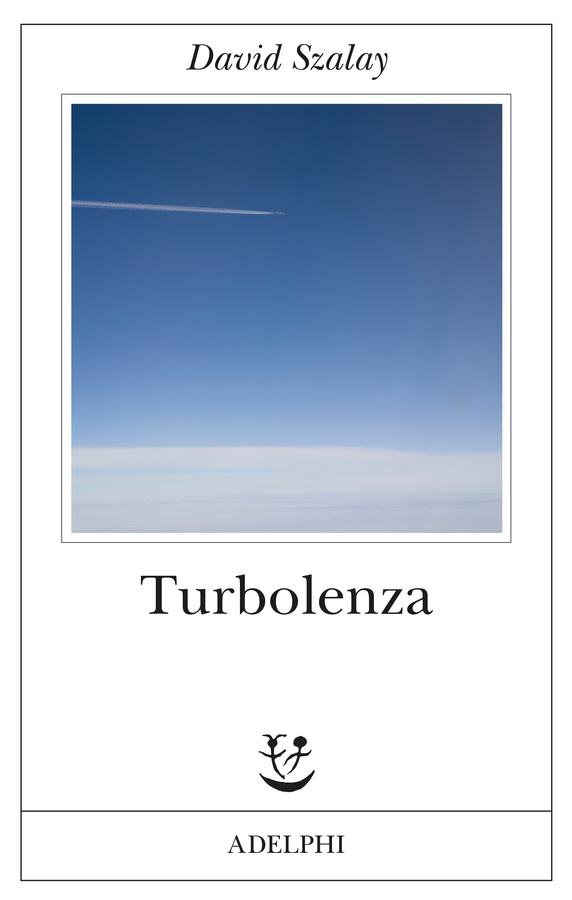Le storie, David Szalay ne è convinto, viaggiano in aria, e precisamente a 10.000 metri: dove per lo più s’incrociano gli aerei di linea. È a quell’altitudine che le questioni personali e familiari dei personaggi narrati dall’autore vanno a sbattere l’una contro l’altra, in mezzo a turbolenze sempre più frequenti dovute al riscaldamento globale. E quando scendono a terra agitando le loro zampe nervose, si trovano immersi in laboriose e fittissime metropoli orientali e occidentali, dove probabilmente non sanno affrontare le avversità e i nemici giurati della loro impossibile placidità.
Scopriamo ben presto quanto i dodici personaggi di Turbolenza abbiano l’uno a che fare con l’altro, dentro a una concatenazione micidiale ideata da Szalay come se volesse vendicarsi di qualcosa. Se non di queste figurine, di un mondo che traballa e appiattisce una volta sganciati i propri abitanti sul terreno, dopo averli trasportati ad autorevoli altezze. Del resto lo scrittore ci aveva già descritto, in Tutto quello che è un uomo, un’Europa abitata da esseri umani depressi. E dove la biologia s’intreccia strettamente a rapporti decostruiti nelle loro parti meno nobili.
Il brutalismo filmico di Turbolenza sembra ancora più raffinato: tutti sono prigionieri di una routine impossibile da strappare, dove l’infelicità si abbina a campi da golf, cocktail edulcorati, matrimoni e separazioni inutili. Ogni racconto s’interrompe come una mannaia non appena lo stesso personaggio forse si aspetta un cambio di rotta. Niente da fare, l’aereo atterra o riparte senza neppure far sentire il rombo dei motori. Le fusoliere sono ben equipaggiate, attutiscono i rumori ma non gli scrolloni dati dalle turbolenze, e in qualche modo inebetiscono i pensieri dei viaggiatori in attesa di venire imprigionati ancora una volta nelle loro vite sovrapposte. Non c’è rifugio possibile per loro, ogni tentativo di fuga, ammesso che ne abbiano davvero la convinzione, viene situato dall’autore in posti impossibili da gestire, e quasi sempre certi avvenimenti, piccoli o grandi che siano, diventano egemoni delle sorti.
La scrittura di Szalay affronta chirurgicamente le diverse situazioni, difficili o vaporose, come se l’École du regard anni Sessanta non fosse passata invano. I dialoghi non sono sexy (e neppure gli aerei), non ce n’è bisogno, e le piane strategie fra i corpi alludono a un tempo che passa quasi inosservato. Bisogna sottolineare come l’ottima traduzione di Anna Rusconi segua con encomiabile esattezza lo stile dell’autore, che sembra ripetere il ticchettio delle azioni di controllo ai terminal degli arrivi e delle partenze. Ossessioni, precarietà, paure e inquietudini sono tutti lì, e si riversano nelle esistenze di chi appena uscito dagli scali si ritrova davanti ai fenomeni quotidiani che ancorano i piedi alla terra.
Anche la melanconia s’intreccia alle diverse impotenze che Szalay infonde nei suoi eroi ed eroine in negativo, immersi in un mondo preso da incompetenza globale proprio mentre tecnica e tecnologia mescolano il meglio e il peggio. Il corredo dato alle dodici creature, e per estensione a coloro che incontrano per caso o volontà, e dunque alle imitazioni sparse per le regioni, è un bric-à-brac d’inizio secolo (il nostro) che presuppone un futuro ancora più inquieto: ecco perché il teatro di questi viventi in aria, sapientemente sceneggiato, mostra in modo perfetto quel che siamo diventati, e peggio, quel che diventeremo.