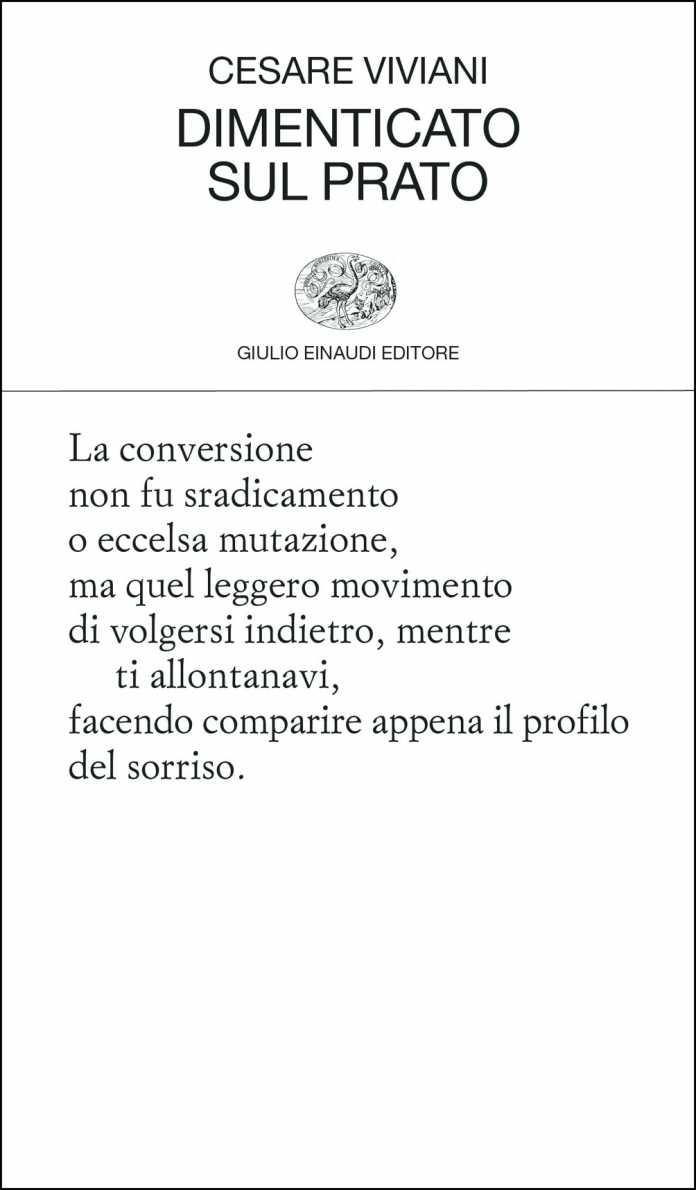La lingua del poeta, resistendo alle folgori dell’epoca che si è data l’umanità, affronta i varchi dell’esistenza memoriale e affettiva. Sono varchi che pochi osano assaltare, perché questo gravarsi immane porta ad allontanarsi dalla realtà desiderata, preveduta (e quasi mai indovinata) da giovani. Cesare Viviani ha dedicato l’intera sua ricerca poetica (quindi “pensiero” e tempo) alla minima differenza fra ciò che si salva e ciò che si perde: l’anima innanzitutto, così come leggiamo (in una straordinaria nudità assertiva di parola) nella seconda poesia di Dimenticato sul prato. Se l’anima è un fiume e la poesia il lago accogliente, ogni idioma cercato e trovato si stabilisce per sempre dentro una vita. Da quell’idioma “straniero”, veloce e avventuroso, che si poteva leggere nel decennio cruciale per molti di noi (gli anni Settanta del Novecento), allo scavalcamento dell’Amore delle parti: per Viviani il pieno del magma messo a terra dagli uomini.
Il fungo atomico nel pensiero dominante si assopiva, ma nell’involucro mondiale era sempre lì, pronto a materializzarsi in forme inedite, mai viste o immaginate. Ma qualcosa procedeva ad alta velocità e la massa di fuoco (digitale e missilistica) ha avvolto la macchina mondiale. Chi invecchiava in questa rete, guardando dritto negli occhi la funzione attiva della poesia, non poteva che stabilire distanze fra conoscenza e le idiozie dell’attualità. Base irriducibile per Cesare, credere all’esistenza dell’invisibile. Senza mezzi termini, dunque, una stretta relazione fra due esistenze: la poesia e Dio.
 Stiamo lontani dalla cronologia, l’assillo del tempo non porta a nulla di buono, e le ultime raccolte di Viviani ne testimoniano verità affrancandosi dal peso di piaceri e dolori. Sottrarsi al peso della parola senza rinunciare al luminoso scaturente, è uno sforzo che si accompagna al susseguirsi del sonno e del risveglio, del giorno e della notte. Nell’istante del passaggio permangono le poesie, ora, di Dimenticato sul prato: non c’è carenza nella concentrazione, si resta fuori dalla gravità che incolla al terreno. Scampare al confuso, almeno, fin che si può. E dunque versi brevi, segni, una sorta di “avvistamenti” per gli ultimi abitanti di questo secolo. Non certo “commenti” ma la traduzione massima che oggi Viviani riesce a guardare e “scrivere”.
Stiamo lontani dalla cronologia, l’assillo del tempo non porta a nulla di buono, e le ultime raccolte di Viviani ne testimoniano verità affrancandosi dal peso di piaceri e dolori. Sottrarsi al peso della parola senza rinunciare al luminoso scaturente, è uno sforzo che si accompagna al susseguirsi del sonno e del risveglio, del giorno e della notte. Nell’istante del passaggio permangono le poesie, ora, di Dimenticato sul prato: non c’è carenza nella concentrazione, si resta fuori dalla gravità che incolla al terreno. Scampare al confuso, almeno, fin che si può. E dunque versi brevi, segni, una sorta di “avvistamenti” per gli ultimi abitanti di questo secolo. Non certo “commenti” ma la traduzione massima che oggi Viviani riesce a guardare e “scrivere”.
L’intenzione critica, vivida, continua a verificare i poteri in cui siamo crollati come materia umana, mette all’angolo i residui di intelletti ormai quasi spenti. Si scopre che costruirsi una vita cozzava contro la perdizione. In molte pagine di questo libro ci sono strumenti intenzionali: potremmo accorgerci che il sole è ancora splendido (ma per quanto?), ma assai simile al crollo è quanto si scorge dalle torri. Sul prato, le poesie sono gli oggetti verso cui possiamo andare, vicini pur essendoci “impressionanti distanze”. Parlano di vite del passato, portano luce lieve. L’anima è pur sempre domestica, si mette alla prova nei ricordi quando la poesia guarda dritto negli occhi un padre al limite della sofferenza e indaga l’animo degli eroi trovando la via che per ora non finisce – quasi una perfezione. Chi rinuncia è stato ridotto alle chiacchiere, insiste Viviani in qualunque parte egli sia, mentre la parola “è più di ogni governo”, cercando il bene nella storia che i molti hanno abbandonato.