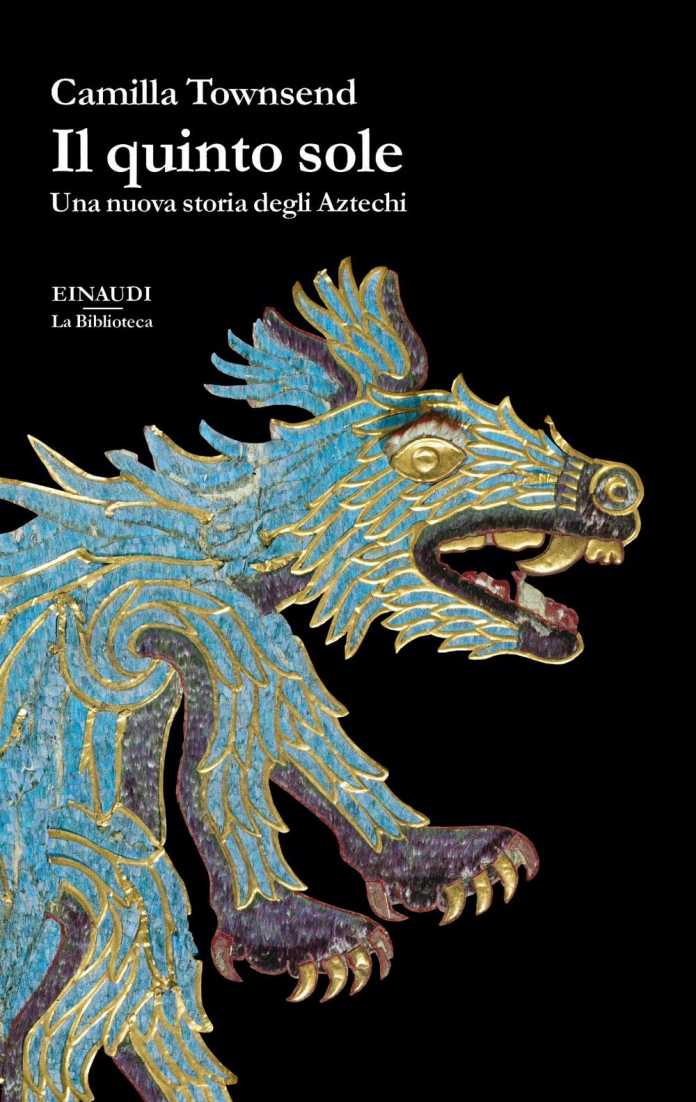Nel 1519 le navi spagnole approdarono a Potonchan, una città maya chontal situata lungo la costa orientale dell’attuale Messico meridionale. I Chontal fecero sapere che avrebbero ucciso chiunque fosse entrato nella loro terra ma il capo degli stranieri, un uomo sui trent’anni di nome Hernando Cortés, non li ascoltò, divise i suoi uomini in due gruppi e li fece avanzare spade in mano, armati di metallo da capo a piedi, con i cavalli (che gli indigeni non avevamo mai visto). Nella battaglia i Chontal persero più di 220 guerrieri in poche ore; sapendo che sarebbero arrivati altri stranieri, chiesero la pace e inviarono sulla spiaggia, in dono agli spagnoli, anche venti ragazze, immediatamente battezzate – un battesimo che, come in molti altri casi simili, fu preliminare allo stupro.
 Gli spagnoli avevano un traduttore, Jerónimo de Aguilar: un soldato che, 8 anni prima, a seguito di un naufragio, era stato fatto prigioniero dai Maya e aveva imparato a parlare un po’ la lingua. Cortés lo riscattò. Jerónimo non parlava chontal ma le donne sapevano un poco il maya e quindi riuscivano a capirsi. I Chontal spinsero gli spagnoli verso i Mexica, che vivevano più ad ovest, convincendoli che erano il popolo giusto per dare loro ricchezze e tributi. Ma quando gli uomini di Cortés arrivarono nella zona dei Mexica, Jerónimo non capiva più la lingua, che non era più il maya ma il nahuatl. È qui, a questo punto della storia, che si fece avanti una delle ragazze schiave, quella battezzata con il nome di Marina e che sarà chiamata Malintzin (a volte percepito come Malinchi o Malinche) e dagli spagnoli doňa Marina. Figlia di un nobile nahua che viveva vicino all’odierna Veracruz, la ragazza era stata fatta prigioniera dai Mexica e venduta come schiava ai Chontal. In pochi mesi imparò lo spagnolo e divenne la principale traduttrice di Cortés (nonché sua amante) e quindi ebbe un ruolo importante nella conquista spagnola del Messico. Cortés la cita poco nelle lettere che scrive al re di Spagna – l’unica fonte scritta contemporanea agli eventi – ne parla molto invece il segretario di Cortés, López de Gómara, nella biografia del suo datore di lavoro. Oggi Malintzin è considerata dalla maggior parte dei messicani una traditrice, ma allora i Mexica (quelli che noi occidentali conosciamo come Aztechi) erano nemici del suo popolo, l’avevano strappata alla famiglia e venduta.
Gli spagnoli avevano un traduttore, Jerónimo de Aguilar: un soldato che, 8 anni prima, a seguito di un naufragio, era stato fatto prigioniero dai Maya e aveva imparato a parlare un po’ la lingua. Cortés lo riscattò. Jerónimo non parlava chontal ma le donne sapevano un poco il maya e quindi riuscivano a capirsi. I Chontal spinsero gli spagnoli verso i Mexica, che vivevano più ad ovest, convincendoli che erano il popolo giusto per dare loro ricchezze e tributi. Ma quando gli uomini di Cortés arrivarono nella zona dei Mexica, Jerónimo non capiva più la lingua, che non era più il maya ma il nahuatl. È qui, a questo punto della storia, che si fece avanti una delle ragazze schiave, quella battezzata con il nome di Marina e che sarà chiamata Malintzin (a volte percepito come Malinchi o Malinche) e dagli spagnoli doňa Marina. Figlia di un nobile nahua che viveva vicino all’odierna Veracruz, la ragazza era stata fatta prigioniera dai Mexica e venduta come schiava ai Chontal. In pochi mesi imparò lo spagnolo e divenne la principale traduttrice di Cortés (nonché sua amante) e quindi ebbe un ruolo importante nella conquista spagnola del Messico. Cortés la cita poco nelle lettere che scrive al re di Spagna – l’unica fonte scritta contemporanea agli eventi – ne parla molto invece il segretario di Cortés, López de Gómara, nella biografia del suo datore di lavoro. Oggi Malintzin è considerata dalla maggior parte dei messicani una traditrice, ma allora i Mexica (quelli che noi occidentali conosciamo come Aztechi) erano nemici del suo popolo, l’avevano strappata alla famiglia e venduta.
Quella di Malintzin è una delle vicende individuali raccontate, con dovizia di dettagli e una forte attenzione alla complessità del contesto socio-politico di riferimento, nella storia degli Aztechi di Camilla Townsend, basata principalmente sulle fonti in nahuatl, scritte con alfabeto latino. Prima della conquista spagnola i locali non avevano una scrittura alfabetica ma pittografica, molto difficile da imparare e conosciuta principalmente dai sacerdoti. Furono i frati spagnoli a insegnare ai giovani a trascrivere la loro lingua usando l’alfabeto latino, con lo scopo di renderli in grado di leggere la Bibbia e tradurla. Ma i futuri messicani usarono l’alfabeto anche per trascrivere storie e racconti sino a quel momento tramandati oralmente e in particolare dei testi storici simili agli annali: gli xiuhpohualli (“resoconto degli anni”). Sono stati scritti soprattutto da figure che lavoravano nelle chiese, come don Domingo Chimalpahin e don Hernando de Alvarado Tezozomoc, un nipote di Montezuma, che si posero il problema di conservare memoria di tutto ciò che fino a quel momento era stato tramandato oralmente o tramite la scrittura pittografica e rischiava quindi di essere dimenticato. Ignorati per molti anni, questi testi sono stati riscoperti a partire dagli anni ’50/’60 del XX secolo. La loro lettura permette di ricostruire una storia dei popoli che abitavano l’attuale Messico molto più sfaccettata, articolata e meno stereotipata di quella ricostruita sulla base dei resoconti europei e delle fonti archeologiche. Permette, inoltre, di raccontare la storia anche del periodo successivo alla conquista spagnola, superando o quantomeno sfumando l’idea della morte e caduta delle civiltà precolombiane.
 La liberazione dagli stereotipi inizia a partire dai nomi. Non è mai esistito un popolo di nome Aztechi: la parola ha iniziato a essere usata nel XVIII secolo per descrivere la popolazione egemone nel Messico all’arrivo degli spagnoli, ma in realtà le popolazioni indigene si facevano chiamare Nahua. Mexica era il gruppo etnico che dominava il Messico centrale quando arrivarono gli spagnoli. A inizio XVI secolo la situazione politica era molto complessa e il territorio diviso in varie città-stato e piccoli staterelli indipendenti, alcuni dei quali si allearono subito con gli spagnoli, in particolare quello dei Tlascaltechi. L’ipotesi di un popolo che sarebbe crollato di fronte agli europei ignora e trascura la realtà sociopolitica al tempo della conquista, tanto quanto la narrazione di genti in preda a fatalismo e irrazionalità, esemplificata nella figura di Montezuma, descritto a lungo come un sovrano inetto. Un altro mito da sfatare è quello secondo cui i Nahua avrebbero scambiato gli spagnoli per delle divinità arrivate per compiere un’antica profezia. Neppure Cortés, nelle sue lettere, accenna alla cosa; l’idea appare dalla metà del XVI secolo in avanti, dapprima nelle fonti europee, e fu in seguito assimilata dai nativi delle seconde e terze generazioni dopo la conquista che avevano probabilmente bisogno di dare una giustificazione all’enormità della sconfitta.
La liberazione dagli stereotipi inizia a partire dai nomi. Non è mai esistito un popolo di nome Aztechi: la parola ha iniziato a essere usata nel XVIII secolo per descrivere la popolazione egemone nel Messico all’arrivo degli spagnoli, ma in realtà le popolazioni indigene si facevano chiamare Nahua. Mexica era il gruppo etnico che dominava il Messico centrale quando arrivarono gli spagnoli. A inizio XVI secolo la situazione politica era molto complessa e il territorio diviso in varie città-stato e piccoli staterelli indipendenti, alcuni dei quali si allearono subito con gli spagnoli, in particolare quello dei Tlascaltechi. L’ipotesi di un popolo che sarebbe crollato di fronte agli europei ignora e trascura la realtà sociopolitica al tempo della conquista, tanto quanto la narrazione di genti in preda a fatalismo e irrazionalità, esemplificata nella figura di Montezuma, descritto a lungo come un sovrano inetto. Un altro mito da sfatare è quello secondo cui i Nahua avrebbero scambiato gli spagnoli per delle divinità arrivate per compiere un’antica profezia. Neppure Cortés, nelle sue lettere, accenna alla cosa; l’idea appare dalla metà del XVI secolo in avanti, dapprima nelle fonti europee, e fu in seguito assimilata dai nativi delle seconde e terze generazioni dopo la conquista che avevano probabilmente bisogno di dare una giustificazione all’enormità della sconfitta.
Oltre che per l’utilizzo delle fonti nahua, il libro della Townsend si distingue anche per la scelta stilistica di iniziare ogni capitolo con una sequenza narrativa, ispirata a un personaggio storico. Un modo per entrare nella storia dei grandi eventi passando attraverso una stanza privata, un aneddoto: un atto immaginativo, insomma, posto alla base del fare storia. Si tratta anche di un tentativo di dialogo: “Non diventiamo forse più saggi e più forti” – scrive l’autrice – “ogni volta che cogliamo la prospettiva di persone che un tempo abbiamo ignorato?”.
 Dal primo capitolo che racconta gli eventi prima del 1299 all’ultimo relativo agli anni 1570-1620 (con un’appendice molto utile, “Gli Aztechi secondo gli studiosi”, che elenca tutte le fonti disponibili) il racconto è molto dettagliato e a tratti travolgente, come nei capitoli centrali relativi agli avvenimenti compresi tra il 1518 e il 1522. Tra questi, il periodo di occupazione spagnola della capitale Tenochtitlan, fondata dai Mexica su un’isola del lago Texcoco (la futura Città del Messico), in un crescendo di tensione con la popolazione locale che culminò negli 80 giorni in cui il re Montezuma fu tenuto in ostaggio da Cortés. L’8 novembre 1519 il risentimento degli abitanti contro gli spagnoli fu tale da costringere Cortés a una rovinosa ritirata. In questo frangente si situa il messaggio di Montezuma, lanciato sui tetti attraverso la voce di un uomo più giovane che gli faceva da portavoce. Il re invitò i sudditi a scegliere la pace; disse loro che non erano all’altezza degli stranieri e dovevano smettere di combattere. La discrepanza di forze dipendeva dal fatto che gli spagnoli avevano armi di metallo, balestre, cannoni, polvere da sparo; una grande abilità nella navigazione (non solo navi ma anche bussole, mappe tecniche, apparecchiature di orientamento) e strumenti di comunicazione che permettevano loro di far arrivare nuove forze in tempi brevi. Montezuma e i Nahua conoscevano la tecnologia degli stranieri solo in parte ma tanto quanto bastava per essere consapevoli di disporre di una potenza militare nettamente inferiore. Eppure gli abitanti di Tenochtitlan continuarono a combattere, costrinsero gli spagnoli alla fuga attraverso l’unica strada rialzata che connetteva l’isola alla terraferma, già distrutta in più segmenti. Prima della ritirata Montezuma fu ucciso. Due terzi degli spagnoli morirono. Ma nei giorni successivi un’epidemia di vaiolo si diffuse nella città e di lì a qualche mese gli spagnoli tornarono e la conquistarono definitivamente.
Dal primo capitolo che racconta gli eventi prima del 1299 all’ultimo relativo agli anni 1570-1620 (con un’appendice molto utile, “Gli Aztechi secondo gli studiosi”, che elenca tutte le fonti disponibili) il racconto è molto dettagliato e a tratti travolgente, come nei capitoli centrali relativi agli avvenimenti compresi tra il 1518 e il 1522. Tra questi, il periodo di occupazione spagnola della capitale Tenochtitlan, fondata dai Mexica su un’isola del lago Texcoco (la futura Città del Messico), in un crescendo di tensione con la popolazione locale che culminò negli 80 giorni in cui il re Montezuma fu tenuto in ostaggio da Cortés. L’8 novembre 1519 il risentimento degli abitanti contro gli spagnoli fu tale da costringere Cortés a una rovinosa ritirata. In questo frangente si situa il messaggio di Montezuma, lanciato sui tetti attraverso la voce di un uomo più giovane che gli faceva da portavoce. Il re invitò i sudditi a scegliere la pace; disse loro che non erano all’altezza degli stranieri e dovevano smettere di combattere. La discrepanza di forze dipendeva dal fatto che gli spagnoli avevano armi di metallo, balestre, cannoni, polvere da sparo; una grande abilità nella navigazione (non solo navi ma anche bussole, mappe tecniche, apparecchiature di orientamento) e strumenti di comunicazione che permettevano loro di far arrivare nuove forze in tempi brevi. Montezuma e i Nahua conoscevano la tecnologia degli stranieri solo in parte ma tanto quanto bastava per essere consapevoli di disporre di una potenza militare nettamente inferiore. Eppure gli abitanti di Tenochtitlan continuarono a combattere, costrinsero gli spagnoli alla fuga attraverso l’unica strada rialzata che connetteva l’isola alla terraferma, già distrutta in più segmenti. Prima della ritirata Montezuma fu ucciso. Due terzi degli spagnoli morirono. Ma nei giorni successivi un’epidemia di vaiolo si diffuse nella città e di lì a qualche mese gli spagnoli tornarono e la conquistarono definitivamente.
Gli Aztechi, però, non sono spariti da un giorno all’altro. Quelli che sopravvissero alla guerra e scamparono alle molte epidemie si adattarono alla nuova situazione politica, mantenendo una propria identità, nonostante le discriminazioni razziali, la cristianizzazione forzata, le politiche economiche schiavistiche introdotte dagli spagnoli: intorno al 1570, cinquant’anni dopo la conquista, c’erano in Messico tanti africani quanto spagnoli, circa 8000 per entrambe le parti, mentre la popolazione indigena era molto diminuita. Gli annali nahua raccontano una storia di sopravvivenza, adattamento, continuità. Oggi la lingua nahua è parlata da circa 1,5 milioni di persone. La sconfitta militare, quindi, non è stata anche spirituale, come era invece nei desiderata delle narrazioni, tutte occidentali, sul collasso della civiltà azteca.