PARTE PRIMA / QUI LA SECONDA PARTE
Tutto inizia e tutto finisce con un cavallo, animale che è simbolo di intelligenza e di saggezza, sia per la cultura orientale che per quella occidentale, fin dalla notte dei tempi. Nell’induismo la testa di cavallo parlante è un simbolo della conoscenza, ma anche di vigore fisico e sessuale, come nell’immagine dello stallone. La figura del cavallo dunque ha radici profonde nell’inconscio collettivo, come nella rappresentazione degli unicorni di Salvador Dalì, simboli della frustrazione dell’artista per la perdita della potenza sessuale, oppure nel «Caso Clinico del Piccolo Hans» (1908) raccontato da Sigmund Freud, che individua nell’episodio del cavallo caduto l’insorgere del disturbo mentale nel piccolo Hans, contemporaneo alla scoperta della sessualità.
Ma nel Novecento l’immagine del cavallo, da simbolo di forza e intelligenza, si trasforma in simbolo di morte e di spossatezza fisica. Andiamo a rileggere quello straordinario racconto di Franz Kafka, «Un medico di campagna», con la sua potente immagine dei cavalli sfiniti, oppure la storia del cavallo-senatore Bucefalo, quello di Alessandro Magno, nel racconto «Il Nuovo Avvocato», che dimostra quanto possa essere sterile la conoscenza se non è accompagnata dalla speranza.
In Germania Anno Zero di Rossellini il protagonista, Edward Koheler, assiste allo smembramento di un cavallo morto per le strade di una Berlino devastata dalle bombe. Quel cavallo morto smembrato diventa un simbolo del tracollo della Germania annientata e smembrata dalle Potenze Alleate. Un cavallo morto appare nel Nosferatu di Herzog, quando si scatena la peste portata dal Conte Dracula e gli abitanti del paese, ormai contagiati, si abbandonano ad una vera e propria festa orgiastica, in una scena che ricorda l’ultima festa che si svolse nel Bunker della Cancelleria, nell’aprile del 1945, dove Hitler e i suoi fedelissimi trascorsero gli ultimi giorni del Terzo Reich. Ed è sempre un cavallo l’animale che Friedrich Nietzsche abbracciò in lacrime quel famoso 3 Gennaio 1889 a Torino, all’insorgere della sua pazzia. È sintomo di pazzia anche il cavallo di Kaspar Hauser nell’altro film di Herzog, L’enigma di Kaspar Hauser, la parola che il piccolo Kaspar continua a ripetere in modo ossessivo, tenendo in mano un piccolo cavalluccio-giocattolo che muove freneticamente, forse in un disperato tentativo di sfuggire alla solitudine e alla follia. Per non parlare della terribile scena della testa di cavallo utilizzata come esca per le anguille nel Tamburo di latta di Grass, da cui fuoriescono, man mano che si prosegue nella lettura, viscide anguille sempre più grandi, quasi a simboleggiare il passato oscuro e inafferrabile della Germania, il «passato che non passa» del Nazionalsocialismo, quel male oscuro che si è nascosto e si è annidato in una nazione progredita e istruita come la Germania.

Anche in questa sede parleremo di un cavallo, o meglio di un uomo-cavallo; si tratta di Hans Fallada, pseudonimo scelto dallo scrittore Rudolph Wilhelm Friedrich Ditzen (Greifswald, 1893 – Berlino 1947), tratto da due famose fiabe dei Fratelli Grimm, «La Fortuna di Hans» e «La guardiana delle oche». In quest’ultima si narra di una serva che si spaccia per una principessa e fa decapitare il cavallo magico Falada, l’unico testimone dell’usurpazione. Ma la vera principessa, che intanto è stata messa a far la guardia alle oche del Re, chiede che la testa del suo cavallo parlante venga inchiodata all’ingresso della città, così che ogni volta che lei ci passa sotto la testa di Falada possa raccontare la verità. Ecco dunque come nacque lo pseudonimo di Fallada, uno scrittore che ha molto in comune con Kafka, non solo per l’immagine dei cavalli, ma perché anche in Fallada la scrittura si configura come un estremo tentativo di mantenere la propria identità e integrità di fronte alla spaventosa macchina della Burocrazia che cerca di stritolare gli uomini, di mantenere un barlume di speranza malgrado tutto, una teologia negativa, in cui non c’è alcun Dio, eppure è rimasta la speranza. Sotto il Nazismo, Fallada si aggrappò disperatamente alla sua scrittura, per non impazzire definitivamente, per mantenere la sua dignità, per poter continuare a esprimere i suoi pensieri e le sue opinioni, nonostante fosse internato in un enorme manicomio, la Germania hitleriana.
La figura del cavallo ha a che fare con questo straordinario scrittore tedesco anche sotto un altro punto di vista, che prescinde dalle filiazioni letterarie e dal folklore tedesco. Dietro la scelta di questo pseudonimo, come nella storia del Piccolo Hans e l’anno dopo la sua pubblicazione, si nasconde infatti anche uno di quegli incidenti che segnano in modo indelebile la vita di una persona. Quando aveva sedici anni il piccolo Rudolph Ditzen andò a sbattere con la bicicletta contro un carro trainato da cavalli, e uno di questi lo calpestò e gli dette un calcio alla testa che per poco non lo uccise. I postumi dell’incidente provocarono nel piccolo Rudolph mal di testa fortissimi, che i medici cominciarono a curare somministrando al ragazzino della morfina, come si faceva di solito all’epoca. Dopo questo incidente il giovane Rudolph comincerà anche a bere, diventando a poco a poco un alcolista, un vizio che lo accompagnerà per tutta la vita
Dunque la carriera letteraria di Ditzen/Fallada, nato in una famiglia borghese benestante, uno degli scrittori tedeschi più conosciuti del XX secolo, comincia all’insegna di una idea fissa, continuare a scrivere nonostante tutto e dire sempre la verità, conficcatagli in testa dal micidiale calcio di un cavallo. Quest’idea è all’origine della sua ricerca compulsiva della verità, anche a costo della propria autodistruzione. Nel 1910, l’anno dopo l’incidente con il cavallo, Fallada tentò il suicidio ingerendo del veleno. Nel 1911 si verificò un secondo tentativo di suicidio, questa volta con una pistola in un finto duello, dal quale scampò miracolosamente, tentativo che comportò il suo ricovero in un sanatorio che era in realtà una vera e propria clinica psichiatrica. Ne seguì tutta una serie di ricoveri in vari istituti psichiatrici, che contrassegnarono tutta la vita di Ditzen/Fallada.
 Nel 1917-19 Fallada ricomincia ad assumere morfina e a bere, ed è ben presto costretto a sottoporsi a una cura disintossicante. La sua esperienza di tossicodipendente la racconta in un testo straordinario, Sulla buona sorte del morfinomane. Una relazione circostanziata (SE, 2018), il resoconto dettagliato della disperata ricerca di una dose di morfina in tutte le farmacie di Berlino con l’amico Wolfgang, ricerca antesignana delle peregrinazioni in tutte le farmacie di Manhattan – sempre alla ricerca della morfina – descritte da William Burroughs. Questo racconto rimase a lungo inedito, anche dopo la morte di Fallada (nel 1947), fino al 1997. Inutile dire che lo scritto di Fallada va ad inserirsi a buon diritto tra quei resoconti sull’esperienza della droga che vantano titoli molto più celebri come le Lettere dello Yage di Burroughs, Conoscenza dagli abissi di Henri Michaux o Le porte della percezione di Aldous Huxley. Il vizio del bere invece ispirerà un altro suo racconto, «Tre anni senza essere un uomo», anch’esso incluso nel volumetto di SE. In quest’ultimo resoconto Fallada narra la sua reclusione in carcere, nel periodo che va dal 1924 al 1928, esperienza che almeno gli consentì, per un certo periodo, di allontanarsi dall’alcool e dalla morfina.
Nel 1917-19 Fallada ricomincia ad assumere morfina e a bere, ed è ben presto costretto a sottoporsi a una cura disintossicante. La sua esperienza di tossicodipendente la racconta in un testo straordinario, Sulla buona sorte del morfinomane. Una relazione circostanziata (SE, 2018), il resoconto dettagliato della disperata ricerca di una dose di morfina in tutte le farmacie di Berlino con l’amico Wolfgang, ricerca antesignana delle peregrinazioni in tutte le farmacie di Manhattan – sempre alla ricerca della morfina – descritte da William Burroughs. Questo racconto rimase a lungo inedito, anche dopo la morte di Fallada (nel 1947), fino al 1997. Inutile dire che lo scritto di Fallada va ad inserirsi a buon diritto tra quei resoconti sull’esperienza della droga che vantano titoli molto più celebri come le Lettere dello Yage di Burroughs, Conoscenza dagli abissi di Henri Michaux o Le porte della percezione di Aldous Huxley. Il vizio del bere invece ispirerà un altro suo racconto, «Tre anni senza essere un uomo», anch’esso incluso nel volumetto di SE. In quest’ultimo resoconto Fallada narra la sua reclusione in carcere, nel periodo che va dal 1924 al 1928, esperienza che almeno gli consentì, per un certo periodo, di allontanarsi dall’alcool e dalla morfina.
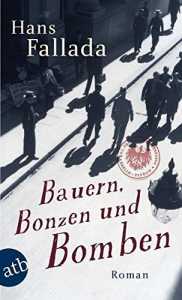 Nel 1929, finalmente libero dalla prigione e disintossicato, Fallada si sposa con Anne Margrete Issel, detta Suse, e pubblica il suo primo libro di successo: Contadini, Bonzi e Bombe, (tr. Luciano Inga Pin, Baldini e Castoldi, 1956), sulla rivolta popolare dei contadini della Pomerania ai tempi della Repubblica di Weimar, romanzo che ebbe un notevole successo anche in Italia, tanto che lo si può trovare nelle più sperdute biblioteche di paese. Tale romanzo è decisivo nello sviluppo della poetica di Fallada, ma purtroppo è quasi introvabile sul mercato librario, a causa probabilmente della sua accesa polemica contro i «rossi», e in particolare contro i cosiddetti «bonzi», cioè i pezzi grossi, i dirigenti del Partito Social-Democratico (SPD) e del Partito Comunista (KPD), che all’epoca amministravano numerose città tedesche, apertamente accusati nel libro di aver brutalmente represso la pacifica protesta dei contadini nel paesino immaginario di Altholm, in realtà Neumunster; Fallada seguì come giornalista il cosiddetto «processo dei contadini» che cercò di chiarire le circostanze degli scontri che si verificarono tra i coltivatori e la polizia.
Nel 1929, finalmente libero dalla prigione e disintossicato, Fallada si sposa con Anne Margrete Issel, detta Suse, e pubblica il suo primo libro di successo: Contadini, Bonzi e Bombe, (tr. Luciano Inga Pin, Baldini e Castoldi, 1956), sulla rivolta popolare dei contadini della Pomerania ai tempi della Repubblica di Weimar, romanzo che ebbe un notevole successo anche in Italia, tanto che lo si può trovare nelle più sperdute biblioteche di paese. Tale romanzo è decisivo nello sviluppo della poetica di Fallada, ma purtroppo è quasi introvabile sul mercato librario, a causa probabilmente della sua accesa polemica contro i «rossi», e in particolare contro i cosiddetti «bonzi», cioè i pezzi grossi, i dirigenti del Partito Social-Democratico (SPD) e del Partito Comunista (KPD), che all’epoca amministravano numerose città tedesche, apertamente accusati nel libro di aver brutalmente represso la pacifica protesta dei contadini nel paesino immaginario di Altholm, in realtà Neumunster; Fallada seguì come giornalista il cosiddetto «processo dei contadini» che cercò di chiarire le circostanze degli scontri che si verificarono tra i coltivatori e la polizia.
 Il grande successo di Fallada comincia dunque in Germania, ma diventa internazionale a partire dal 1932, quando viene pubblicato il suo romanzo più celebre, E adesso, pover’uomo? (Mondadori, 1933; ristampato da Sellerio nel 2008). Il romanzo ebbe un tale successo che fu subito tradotto in diverse lingue e attirò l’attenzione dell’industria del cinema di Hollywood, che ne ricavò nel 1934 il film Little Man, What Now?, con Douglass Montgomery e Margaret Sullavan, diretto da quel Frank Borzage che due anni prima era stato il regista dell’adattamento cinematografico di Addio alle armi di Hemingway. E adesso, pover’uomo è la spietata descrizione della società tedesca tra le due guerre, secondo i canoni della Nuova Oggettività (Neue Sachlickheit), un movimento che intendeva reagire agli eccessi dell’Espressionismo. Il libro narra le vicende di un giovane contabile tedesco, Johannes Pinneberg, rappresentante della piccola borghesia, coinvolto nella grave crisi economica degli anni ’20 sotto la Repubblica di Weimar. Johannes e la sua giovane moglie, Emma Morschel, detta Lammchen (agnellino), vanno a vivere all’inizio nella Germania rurale, poi si trasferiscono a Berlino in cerca di fortuna. Johannes scopre che la sua matrigna gestisce un bordello, e che il suo amante, Jachmann, ha posato gli occhi su sua moglie.
Il grande successo di Fallada comincia dunque in Germania, ma diventa internazionale a partire dal 1932, quando viene pubblicato il suo romanzo più celebre, E adesso, pover’uomo? (Mondadori, 1933; ristampato da Sellerio nel 2008). Il romanzo ebbe un tale successo che fu subito tradotto in diverse lingue e attirò l’attenzione dell’industria del cinema di Hollywood, che ne ricavò nel 1934 il film Little Man, What Now?, con Douglass Montgomery e Margaret Sullavan, diretto da quel Frank Borzage che due anni prima era stato il regista dell’adattamento cinematografico di Addio alle armi di Hemingway. E adesso, pover’uomo è la spietata descrizione della società tedesca tra le due guerre, secondo i canoni della Nuova Oggettività (Neue Sachlickheit), un movimento che intendeva reagire agli eccessi dell’Espressionismo. Il libro narra le vicende di un giovane contabile tedesco, Johannes Pinneberg, rappresentante della piccola borghesia, coinvolto nella grave crisi economica degli anni ’20 sotto la Repubblica di Weimar. Johannes e la sua giovane moglie, Emma Morschel, detta Lammchen (agnellino), vanno a vivere all’inizio nella Germania rurale, poi si trasferiscono a Berlino in cerca di fortuna. Johannes scopre che la sua matrigna gestisce un bordello, e che il suo amante, Jachmann, ha posato gli occhi su sua moglie.
Insomma, questo scrittore che oggi (nonostante gli sforzi della casa editrice Sellerio che ne sta ripubblicando i migliori romanzi) rimane ancora un oggetto sconosciuto al grande pubblico dei lettori italiani, negli anni Trenta e Quaranta era un autore di bestseller anche da noi, nonostante la censura fascista. Sebbene non fosse propriamente uno scrittore di regime, gli editor della Mondadori e i censori del regime fascista non percepirono la pericolosità dei testi di Fallada, anche se qualche taglio nell’edizione italiana effettivamente ci fu. La propaganda del regime, anche di quello nazista, ritenne che le vicende del pover’uomo di Fallada, che a causa della crisi della Repubblica di Weimar progressivamente sprofonda in una condizione di sottoproletario, fossero perfette per intrattenere e svagare i lettori che potevano in questo modo ritenersi fortunati rispetto al pover’uomo. Inoltre, nella rabbia mista a frustrazione del povero impiegato Pinneberg, il ceto medio dell’epoca vedeva riflessa quella stessa rabbia e frustrazione che l’aveva spinto a votare in massa per il Partito Fascista e successivamente per il Partito Nazista. Del resto il primo romanzo di Fallada sulla rivolta dei contadini, classe sociale tradizionalmente di destra, avversaria dei rossi e tendenzialmente antisemita (non mancano le battute antisemite nel romanzo, non si sa quanto condivise dall’autore), aveva convinto i nazisti che Fallada fosse uno dei loro.
 La fortuna di Fallada in Italia continuerà per qualche tempo anche nel secondo dopoguerra, dopo la sua morte nel 1947, tanto che da uno dei suoi romanzi della serie del pover’uomo, Tutto da rifare, pover’uomo (dove si immagina il pover’uomo che eredita un’immensa fortuna, ma non per questo cessa di essere uno sfigato), pubblicato in Italia da Mondadori nel 1940, fu anche tratto uno sceneggiato per la TV nei primi anni sessanta, con Laura Betti, Paolo Poli e Luigi Vannucchi.
La fortuna di Fallada in Italia continuerà per qualche tempo anche nel secondo dopoguerra, dopo la sua morte nel 1947, tanto che da uno dei suoi romanzi della serie del pover’uomo, Tutto da rifare, pover’uomo (dove si immagina il pover’uomo che eredita un’immensa fortuna, ma non per questo cessa di essere uno sfigato), pubblicato in Italia da Mondadori nel 1940, fu anche tratto uno sceneggiato per la TV nei primi anni sessanta, con Laura Betti, Paolo Poli e Luigi Vannucchi.
Un discorso a parte meriterebbe l’analisi della fortuna di Fallada in America: la sua fama iniziò in modo trionfale nel 1934 con il film di Borzage, poi finì sottotraccia per diversi decenni, riaffiorando solo in epoca recente con tutta una serie di nuove edizioni, anche delle opere minori o meno ispirate, che cercavano di soddisfare i desiderata dei gerarchi nazisti. Recentemente, nel 2018, è uscito anche un film, Lettere da Berlino, tratto dal romanzo Ognuno Muore Solo (1947), con Emma Thompson e Brendan Gillison, per la regia di Vincent Perez.
L’unico che in America, già negli anni Sessanta, sembrava aver compreso la grandezza di Fallada era uno scrittore di fantascienza apparentemente lontanissimo da lui, Philip K. Dick (ne raccomanda la lettura in alcune lettere), che forse intravedeva nel pover’uomo di Fallada l’antenato dei suoi personaggi, apparentemente insignificanti, umili repairman o commessi in un negozio di dischi, ma portatori di un messaggio da cui potrebbe dipendere il destino del mondo. Del resto, curiosamente, lo stesso Dick teneva molto a sottolineare il fatto che il suo nome, Philip, in greco antico significava «amante dei cavalli», tanto da chiamare uno dei suoi personaggi-alter ego Horselover Fat, traduzione letterale del suo nome in inglese. Inoltre era lui stesso, come Fallada, uno scrittore emarginato, bistrattato, considerato pazzo e costantemente impegnato in una dura lotta per la sopravvivenza. Anche Dick, come Fallada, ricorreva spesso alle droghe per «reggere» a sessioni di scrittura disumane, che a volte duravano per giorni e giorni di seguito (l’ultimo romanzo di Fallada, Ognuno Muore Solo, più di 700 pagine nell’edizione italiana, fu scritto in soli 24 giorni). Guarda caso, quelle stesse droghe – come il Pervitin, una potente amfetamina – che utilizzarono i carristi dell’esercito tedesco per portare a termine la conquista della Francia in meno di due mesi, guidando i loro carri armati giorno e notte, senza dormire quasi mai. Come hanno dimostrato gli studi di Norman Ohler, e in particolare il saggio Tossici. L’arma segreta del Reich. La droga nella Germania Nazista (Milano, Rizzoli, 2016), l’intera Germania era diventata, negli anni Trenta, una nazione di tossici, e il capo dei tossici era proprio lui, Adolf Hitler, cui il suo dottore personale, il Dottor Morrell, somministrava numerose iniezioni dei più svariati oppiacei nel corso della giornata per tenerlo su, soprattutto quando le sorti della guerra cominciarono a volgere a sfavore della Germania. L’alcolismo e la tossicodipendenza coinvolgevano tutti i tedeschi, sia le vittime che i carnefici; le prime per sopportare le vessazioni e le umiliazioni dei secondi, questi ultimi per ottundere il loro senso morale quando si abbandonavano ai più efferati massacri.
(continua)
La seconda parte di questo Speciale Fallada verrà pubblicata il 15 dicembre.



