Vernon Subutex, protagonista del romanzo omonimo di Virginie Despentes, è un uomo che ha per nome lo pseudonimo di Boris Vian quando questi scriveva, più di sessant’anni fa, il pulp Sputerò sulle vostre tombe; il cognome, Subutex, è invece il nome commerciale di un farmaco che cura la dipendenza da oppiacei. Vernon ha quasi cinquant’anni, aveva un negozio di dischi, “Il Revolver”, che Napster (la prima piattaforma per scaricare musica gratis) ha mandato in rovina. Il mondo gli è poi precipitato addosso alla velocità inaspettata della torsione fra gli anni ’90 e il nuovo secolo che tutto ha cambiato. Per lungo tempo ha avuto “la sensazione che il suo lavoro consistesse nel vagare su internet” vendendo pezzo per pezzo tutto il vendibile; fino a quando la morte improvvisa di Alex Bleach, l’amico musicista superstar che lo aiutava a pagare l’affitto, lo porta rapidamente a perdere la casa e a vivere sulla strada. “Passata la quarantina, Parigi accetta solo i figli dei proprietari di immobili, il resto della popolazione prosegue la propria strada altrove”.
Il romanzo si svolge tutto nelle poche settimane in cui Vernon si fa ospitare sui divani e nei letti di amici e amiche legati a lui dai tempi de “Il Revolver” e dalla passione per la musica.
È questo il semplice plot dello straordinario romanzo definito da molti – a ragione – una nuova Commedia Umana, al tempo della precarietà e delle migliori serie tv (infatti la sta producendo Canal+).
 Vernon Subutex 1, va via liscio come un feuilleton, si legge d’un fiato, ma ogni volta che pensi di esserti assestato su qualcosa, l’intelligenza analitica e lucidissima della scrittrice ti toglie la terra sotto i piedi e ti fa riconsiderare personaggi, caratteri, situazioni, relazioni che sono sempre sul punto di sfaldarsi. La Despentes ha voluto indagare toutes les classes sociales, compresi gli immigrati di seconda e terza generazione, scrivendo così un romanzo profondamente politico che è una radiografia della società francese vista “dai due lati della barricata”. E le parole, notoriamente, a seconda del lato in cui stai e ti poni, cambiano di significato.
Vernon Subutex 1, va via liscio come un feuilleton, si legge d’un fiato, ma ogni volta che pensi di esserti assestato su qualcosa, l’intelligenza analitica e lucidissima della scrittrice ti toglie la terra sotto i piedi e ti fa riconsiderare personaggi, caratteri, situazioni, relazioni che sono sempre sul punto di sfaldarsi. La Despentes ha voluto indagare toutes les classes sociales, compresi gli immigrati di seconda e terza generazione, scrivendo così un romanzo profondamente politico che è una radiografia della società francese vista “dai due lati della barricata”. E le parole, notoriamente, a seconda del lato in cui stai e ti poni, cambiano di significato.
Le vite dei moltissimi personaggi sono precarie e le determinazioni di classe, razza e genere le informano; il risultato è reso poi ancora più articolato dai lunghi flashback in cui l’autrice rievoca con dolcezza il tempo della giovinezza rock che ha originariamente legato fra loro i personaggi. E qui sembra che la Despentes abbia imparato da Proust e dai suoi personaggi che si moltiplicano secondo l’ambiente e le relazioni che intrattengono, perché “nessuno è quello che crede per gli altri”. Così Vernon a qualcuno sembra un uomo meraviglioso, l’amico che non lo vede da tanto tempo dice che ha un cervello come un pisello, un altro è invece incantato dalla sua capacità di DJ e lo considera un genio; lui stesso non sembra avere molta coscienza di sé mentre si lascia andare a una deriva confusa come “uno spettatore, uno scroccone della propria stessa vita, un clandestino”. Gli altri personaggi partecipano della stessa indefinibilità. In sovrappiù Vernon ci dà un indizio, quando, arrivato al punto più basso della sua parabola discendente, incontra dei tipi modello Casa Pound, rendendosi conto che “ha parlato troppo in fretta, avrebbe dovuto dare il suo nome registrato all’anagrafe, la sua identità francese”. Vedremo nei prossimi volumi…
 Apocalypse Baby (2010) ha lo stesso “montaggio” di Vernon Subutex, una pletora di personaggi e situazioni (ruotanti attorno a una ragazzina “meticcia” destinata a diventare una terrorista) che si intrecciano, illuminano e definiscono a vicenda; ma pur essendo notevole, tagliente e radicale sembra sottostare all’”obbligo” di mostrare tutte le diversità, le identità, le soggettività; i personaggi risultano quindi un po’ artificiali e funzionano quasi da “avatar” di una condizione, razziale o di genere. Anche la Iena, l’indimenticabile protagonista spregiudicata e cattivissima, che tutte le donne vorrebbero portarsi a letto, risulta leggermente caricaturale. Giustamente (come faceva Balzac) l’autrice le assegna un posto per ora liminale in Vernon Subutex dove si occupa di Internet e costruisce fake news…
Apocalypse Baby (2010) ha lo stesso “montaggio” di Vernon Subutex, una pletora di personaggi e situazioni (ruotanti attorno a una ragazzina “meticcia” destinata a diventare una terrorista) che si intrecciano, illuminano e definiscono a vicenda; ma pur essendo notevole, tagliente e radicale sembra sottostare all’”obbligo” di mostrare tutte le diversità, le identità, le soggettività; i personaggi risultano quindi un po’ artificiali e funzionano quasi da “avatar” di una condizione, razziale o di genere. Anche la Iena, l’indimenticabile protagonista spregiudicata e cattivissima, che tutte le donne vorrebbero portarsi a letto, risulta leggermente caricaturale. Giustamente (come faceva Balzac) l’autrice le assegna un posto per ora liminale in Vernon Subutex dove si occupa di Internet e costruisce fake news…
In Vernon Subutex 1, invece, i personaggi, più fluidi e smussati, sono davvero potenti e credibili, e la scrittura della Despentes ha un senso del ritmo stupefacente. Ma si sa, Virginie viene fuori dalla cultura punk e il romanzo più di tutti gli altri è intessuto di musica punk, pop, techno, grunge…
In attesa di leggere la seconda e terza parte della trilogia per scoprire l’altra identità di Vernon e cosa farà la Iena ascoltiamo la play list del romanzo.
Virginie Despentes è così brava a descrivere la guerra di classe perché sceglie un punto di vista, sceglie di collocarsi dalla parte dei perdenti; e non perché è una “buonista” (secondo l’orribile ingiuria che va per la maggiore), ma perché “l’umorismo e l’inventiva si collocano piuttosto dalla nostra parte”.
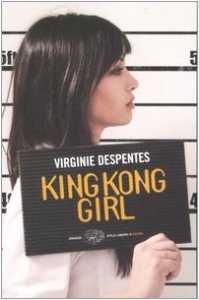 Il manifesto della scrittura di Virginie Despentes sta fra la celebre apertura di “parte” di King Kong Girl (2006) e la chiusura fraterna e condivisa di Vernon Subutex 1.
Il manifesto della scrittura di Virginie Despentes sta fra la celebre apertura di “parte” di King Kong Girl (2006) e la chiusura fraterna e condivisa di Vernon Subutex 1.
In King Kong Girl, Despentes dice:
Scrivo dalla parte delle racchie, per le racchie, le vecchie, le camioniste, le frigide, le mal scopate, le inscopabili, le isteriche, le tarate, tutte le escluse dal gran mercato della bella donna (…) Perché la donna bianca ideale, seducente ma non puttana, bene accasata ma non cancellata, che lavora ma senza riuscire troppo, per non schiacciare il suo uomo, magra ma non maniaca della dieta, che rimane giovane a tempo indeterminato senza farsi sfigurare dai chirurghi estetici, madre realizzata ma non totalmente assorbita da pannolini e compiti per la scuola, buona padrona di casa ma non casalinga tradizionale, colta ma meno di un uomo, questa donna bianca felice che ci viene costantemente brandita sotto il naso, quella a cui ci si dovrebbe sforzare di assomigliare, a parte il fatto che ha l’aria di rompersi le scatole per poco, a ogni modo non l’ho mai incontrata, da nessuna parte. Credo proprio non esista.
Da parte sua, Vernon Subutex 1, finisce con la più bella, dolente, creativa, piena di vita, sfilata di persone ai margini – ma anche animali e vegetali – mai scritta, con cui si identifica il protagonista, abbandonato su una panchina nel delirio della febbre, che vale la pena riportare per intero.
Sono un uomo solo, ho cinquant’anni, ho la gola bucata per il cancro e fumo il sigaro guidando il taxi, finestrino aperto, senza preoccuparmi della faccia che fanno i clienti.
Sono Diana e sono una di quelle ragazze che ridono sempre e si scusano di tutto, le braccia sono macchiate dai segni dei tagli.
Sono Marc, prendo il sussidio ed è mia moglie che lavora per farmi campare, io mi occupo tutti i giorni della nostra bambina e oggi per la prima volta le ho insegnato ad andare in bicicletta e ho pensato a mio padre, a quando ero piccolo ed era riuscito a togliere le rotelle alla mia bici.
Sono Elèonore, la tipa che mi piace mi fotografa ai giardini di Luxembourg, so che succederà qualcosa, e che sarà difficile perché siamo entrambe con qualcuno ma vale la pena provare.
Sono a letto quando so della morte di Daniel Darc, penso al suo numero nel mio cellulare, vorrei comporre quel numero e l’idea che ormai sia impossibile mi provoca una lunga vertigine, in fondo alla schiena.
Sono un adolescente ossessionato dall’idea di farmi sverginare e la rossa per cui spasimo da mesi mi ha appena fatto capire che potremmo andare al cinema insieme, credo non mi prenda in giro e guardandomi allo specchio mi accorgo che non ho più nessuna traccia d’acne, lo Roaccutan ha funzionato e una nuova vita mi si apre davanti.
Sono una giovane violinista virtuosa.
Sono la puttana arrogante e scorticata viva, sono l’adolescente solidale con la sua sedia a rotelle, sono la giovane donna che cena con suo padre che adora e che è fiero di lei, sono il clandestino che scavalcato il filo spinato di Melilla risalgo lungo gli Champs-Elysées e so che questa città mi darà quello che sono venuto a cercare, sono la vacca al mattatoio, sono l’infermiera diventata sorda alle urla dei malati a forza d’impotenza, sono l’immigrato senza documenti che prende dieci euro di crack ogni sera per fare le pulizie in nero in un ristorante a Château Rouge, sono il disoccupato da tempo che ha appena trovato lavoro, sono il contrabbandiere di droghe che si piscia dalla paura dieci metri prima della dogana, sono la puttana di sessantacinque anni incantata nel vedere arrivare il suo cliente vecchio.
Sono l’albero dai rami spogli maltrattato dalla pioggia, il bambino che urla nel passeggino, la cagna che tira il guinzaglio, la guardia carceraria invidiosa della noncuranza delle detenute, sono una nuvola nera, una fontana, la fidanzata lasciata che fa scorrere le foto della sua vita precedente, sono un barbone su una panchina abbarbicata su un poggio a Parigi.
Torniamo a King Kong Girl. La Despentes usa la figura di King Kong, metà umana metà animale, primitiva ma capace di emozioni e affetti, come possibile modello per pensarci fluidi e “ritirarci” dalla rappresentazione rigida e “naturalizzata” per generi sessuali; il diritto di pensarsi né come maschi né come donne.
King Kong Girl è un libro che non ha, per l’appunto, un genere ben definito; un po’ memoir, un po’ saggio, un po’ invettiva, un po’ – nelle parole di Despentes – da “petite blanche” nel senso che in esso non trova posto quell’intreccio fra genere classe e razza che è invece presente nelle altre opere sia cinematografiche che testuali. Parla di stupro, di pornografia e di prostituzione (il cuore dell’esperienza femminile se tiriamo i fili all’estremo) della dominazione dei corpi, storicamente costruita e riperpetuata. Tre livelli che la Despentes ha attraversato in prima persona e che indaga senza remore.
Lo stupro è ciò che ogni donna (compresa la allora giovanissima scrittrice) ha vissuto in prima persona (o nella persona di un’amica, una conoscente, una sorella…), o evitato di striscio, o ci è andata vicina. Mentre non è evidentemente una cosa che riguarda gli uomini, perché a parte i casi clamorosi di pedofilia e di psicopatici, tutti gli altri non stanno mai facendo uno stupro: hanno forzato la situazione, erano un po’ ubriachi, lei in fondo ci stava… (Bisogna dire che cominciano a comparire, anche in Italia, uomini che riflettono sulla violenza.)
Orbene la Despentes rifiuta in toto la retorica della vittima, angolo riservato alle donne violentate. Rifiuta la necessità del trauma, la “serie di segnali visibili che bisogna rispettare: paura degli uomini, della notte, dell’autonomia, disgusto per il sesso e altre amenità”. Tira fuori lo stupro dal non-detto e dal silenzio ma anche dall’incubo assoluto, dal “che orrore” e “povere ragazze”. Corre il rischio dello stupro pur di avventurarsi all’esterno, non si vergogna di essere “rimasta viva” e cerca di riprendersi nel miglior modo possibile. È la libertà della sdrammatizzazione che evita la strada dell’unico comportamento violento tollerato dopo lo stupro: rivolgere la violenza contro se stesse. Ad esempio: aumentare venti chili, sottrarsi al desiderio, sentirsi in colpa per non aver resistito fino alla morte o peggio corresponsabili dello stupro perché nelle proprie fantasie sessuali e masturbatorie si immagina di essere presa con la forza.
 In ogni caso lo stupro per la Despentes è fondante, è “ciò che mi sfigura, e ciò che mi costituisce”. Ed è anche ciò che la determina come scrittrice. Non è un caso che il primo libro sia Scopami, (1996) la storia di due ragazze che escono dalla marginalità e dall’invisibilità soggettiva, sociale e politica, in un’esplosione di violenza assolutamente distruttiva ma che lo dice chiaro agli uomini: fra le mie gambe ci entri se lo voglio io. Scopami ha l’estremismo della giovinezza, è super-provocatorio, molto liberatorio e già mostra l’attenzione politica della Despentes nei confronti di donne che vivono una triplice condizione di sottomissione: donne, povere, e straniere di terza generazione. Scopami, che è anche un film (si può vedere a questo indirizzo) vendica simbolicamente tutte le stuprate e maltrattate del mondo!
In ogni caso lo stupro per la Despentes è fondante, è “ciò che mi sfigura, e ciò che mi costituisce”. Ed è anche ciò che la determina come scrittrice. Non è un caso che il primo libro sia Scopami, (1996) la storia di due ragazze che escono dalla marginalità e dall’invisibilità soggettiva, sociale e politica, in un’esplosione di violenza assolutamente distruttiva ma che lo dice chiaro agli uomini: fra le mie gambe ci entri se lo voglio io. Scopami ha l’estremismo della giovinezza, è super-provocatorio, molto liberatorio e già mostra l’attenzione politica della Despentes nei confronti di donne che vivono una triplice condizione di sottomissione: donne, povere, e straniere di terza generazione. Scopami, che è anche un film (si può vedere a questo indirizzo) vendica simbolicamente tutte le stuprate e maltrattate del mondo!
Le ragazze di Scopami assomigliano alla scrittrice: una è stata violentata e l’altra fa la prostituta, come la Despentes che è stata una sex worker occasionale e che ha avuto modo di riflettere sulle analogie fra l’atto del prostituirsi e il lato promozionale del lavoro di scrittrice famosa. L’unica differenza, scrive spiritosamente, è che se dici «sono una puttana» tutti ti vogliono salvare, se invece dici: «vado in televisione», tutti sono invidiosi! “Ma la sensazione di disporre interamente di sé, di vendere quel che è intimo, di mostrare quel che è privato, è esattamente la stessa”.
La prostituzione notoriamente divide le posizioni femministe fra chi pensa che il lavoro sessuale per le donne sia sempre degradante e chi – come la nostra autrice – no. Senza ripercorrere una querelle che anche in Italia non smette di scomparire dalle prime pagine dei giornali, fra dibattiti sulla tratta, interdizioni ai centri cittadini, multe ai clienti, vale la pena soffermarsi sulle argomentazioni chiare e amorali della Despentes, che si chiede perché quello del lavoro sessuale sia l’unico spicchio di proletariato che turba tanto i benpensanti, i politici e le donne “rispettabili”. Puoi essere barbone, povero, avere un miserabile salario senza che nessuno abbia da ridire sulla degradazione e la dignità di chi ci è costretto, ma nessuno si esime dal sentenziare che la prostituzione qualunque sia le forme in cui avviene (anche se fra adulti consenzienti) sia per definizione degradante e che le prostitute se potessero ne farebbero a meno. Come se la maggior parte delle persone non facesse a meno di lavorare se solo potesse. Togliendo la prostituzione dall’enfasi moralista in cui è confinata, sempre identificata con i suoi aspetti più sordidi di sfruttamento e della tratta, la Despentes afferma che quel che si ha paura di ammettere è scoprire che per moltissime persone che lo fanno, la prostituzione non è poi un lavoro così terribile, che non è vero che tutte le prostitute sono delle vittime. Ad esempio Louise protagonista di Le dotte puttane (1999), sorta di noir ambientato nell’industria del sesso, appaga – attraverso la prostituzione – anche le proprie fantasie e piacere sessuale; di se stessa la Despentes dice che quel che la metteva in difficoltà era piuttosto confrontarsi con la vulnerabilità di molti dei suoi clienti; infatti rendere la prostituzione difficile e controllata significa anche controllare la sessualità dei clienti visti sempre come dei predatori, il tutto in un mondo dove i confini fra la seduzione e la prostituzione sono francamente confusi e la sessualità è continuamente esibita, medium per la vendita di qualsiasi merce La dicotomia madre/puttana non è “naturale”, ma corrisponde a una volontà politica che traccia sul corpo delle donne i confini con lo stesso criterio con cui si sono tracciati i confini in Africa: secondo gli interessi degli occupanti.
La Despentes scrive: “La prostituzione è stata una tappa cruciale, nel mio caso, di ricostruzione dopo lo stupro. Un’operazione di risarcimento, banconota dopo banconota, di ciò che mi era stato tolto con brutalità. (…) Quel sesso apparteneva solo a me, non perdeva di valore a mano a mano che veniva utilizzato, e poteva essere redditizio.”
Una ventata di impudente aria fresca la Despentes la mette anche nella sua riflessione e attraversamento della pornografia, argomento che per definizione sembra sottrarsi a qualsiasi rivisitazione critica che non sia la condanna o la “diminuzione del danno”. Scioccante, ad esempio, che in un film che non viene classificato come pornografico (nonostante le forti polemiche che lo hanno accompagnato) come Scopami (ma anche nel libro) una ragazza guardi apertamente (non nel chiuso della sua cameretta) film pornografici e si masturbi. Anche in questo caso la Despentes ci pone delle domande che sono per lo più confinate nel non detto. La forza della pornografia sta nel fatto che “va a colpire la zona morta della ragione. Punta dritto ai fantasmi, senza passare per la parola, né per la riflessione. Prima si ha l’erezione e ci si bagna, poi ce ne si può chiedere il perché”. Un film hard è fatto per masturbarsi, punto. Non solo: ciò che eccita è spesso imbarazzante socialmente e non sempre quel che fa piacere quadra con quel che si vorrebbe essere. Pensiamo solo a quanto scritto sopra, sul senso di colpa indotto in donne con fantasie masochiste in caso di violenza sessuale. La Despentes (e con lei il movimento pro sesso oggetto di indagine in Mutantes: porn, punk, feminism (2009) ) pensa che anche la pornografia possa essere sottratta allo sguardo maschile e patriarcale che la caratterizza e diventare uno strumento per liberare gli uomini dalla posizione di aggressori e le donne da quella di vittime “dolorosamente riconoscenti o gioiosamente importunate” secondo le parole del filosofo Paul B. Preciado, in precedenza noto come Beatriz, già compagna/o della scrittrice.



