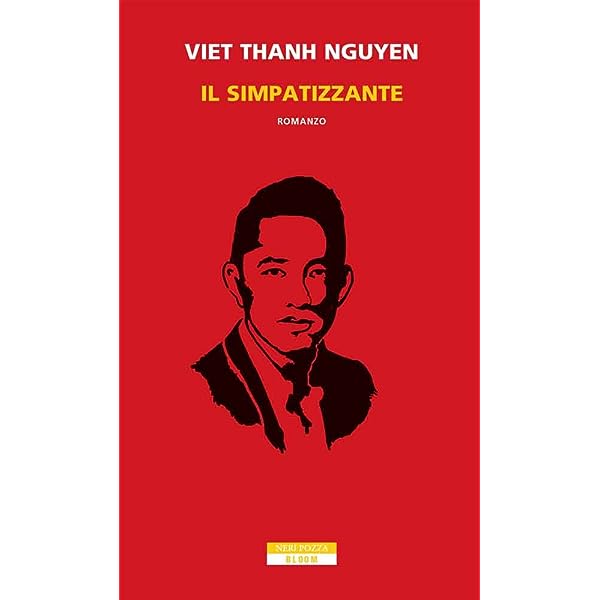Se dico Carver, sicuramente penserete all’autore di “Cattedrale” e altri ben noti racconti. Be’, no, non mi riferisco a quel Carver lì, non a Raymond, ma a James. James Carver è un ex-pilota civile in pensione. Da giovane non pilotava innocui aerei di linea, ma un B-52, uno di quegli enormi bombardieri che scaricavano fino a trenta tonnellate di bombe alla volta su Hanoi e altre città nordvietnamite. Ora che è in pensione, rieccolo in estremo oriente, più precisamente in Cambogia, però non più ai comandi della sua Stratofortezza (anche perché ormai troppo vecchio); è venuto a visitare sua figlia Claire, che ha lasciato gli Stati Uniti per fare volontariato internazionale. Non siamo più nei favolosi anni Sessanta, ma nel 2010. Ormai il nemico dell’America è in Medio Oriente, non in Indocina. Al limite nella buona vecchia Russia dello zar Vladimir.
Se dico Carver, sicuramente penserete all’autore di “Cattedrale” e altri ben noti racconti. Be’, no, non mi riferisco a quel Carver lì, non a Raymond, ma a James. James Carver è un ex-pilota civile in pensione. Da giovane non pilotava innocui aerei di linea, ma un B-52, uno di quegli enormi bombardieri che scaricavano fino a trenta tonnellate di bombe alla volta su Hanoi e altre città nordvietnamite. Ora che è in pensione, rieccolo in estremo oriente, più precisamente in Cambogia, però non più ai comandi della sua Stratofortezza (anche perché ormai troppo vecchio); è venuto a visitare sua figlia Claire, che ha lasciato gli Stati Uniti per fare volontariato internazionale. Non siamo più nei favolosi anni Sessanta, ma nel 2010. Ormai il nemico dell’America è in Medio Oriente, non in Indocina. Al limite nella buona vecchia Russia dello zar Vladimir.
Però qualcosa del passato è rimasto: il paese è infestato di mine antiuomo e anticarro, e il fidanzato di Claire, che si chiama Khoi Legaspi, sta studiando proprio una tecnologia economica per sminare campi e foreste cambogiane. Khoi è un giovane asiatico adottato da bambino da una coppia di americani; e per complicare il quadro etnico, James è un afro-americano che ha fatto strada proprio grazie all’addestramento ricevuto dall’aeronautica americana, e ha sposato una giapponese, quindi alla fine della fiera Claire è – come si diceva un tempo – mulatta, o come diremmo oggi… già, cosa dovremmo dire? Forse niente, perché ovviamente l’argomento “meticciato” è alquanto delicato, coi tempi che corrono. In ogni caso, quali che siano il colore della loro pelle e i loro tratti somatici, i Carver sono una famiglia con le sue tensioni, i suoi affetti, le sue incomprensioni; come quella che separa padre e figlia, con lui che disapprova la scelta di lei di andarsene in un paese del terzo mondo perché che “crede di essere una vietnamita”.
Ecco, questo (e altro) troverete in “Gli americani”, uno dei racconti raccolti in questo volume, e uscito nel 2010 sul Chicago Tribune. Sì, proprio così: su un quotidiano, non una rivista letteraria. Poi però come tutti sanno gli americani sono un popolo di barbari ignoranti; noi italiani invece… (noi che già è tanto se leggiamo Corriere e/o Gazzetta dello Sport). E mi si perdonerà se mi abbandono un attimo alla fustigazione degli stereotipi nazionali, ma non mi sto affatto discostando dall’argomento principale di questa recensione. In effetti il professor Viet Thanh Nguyen è alquanto sensibile agli stereotipi nazionali e all’abuso che se ne fa.
Nato in Vietnam nel 1971, quando io vedevo al TG1 (in bianco e nero) gli F-5 americani scaricare napalm sulla giungla del delta del Mekong (e prima di Apocalypse Now), emigrato, o meglio scappato negli Stati Uniti con la famiglia nel 1975 (si noti bene che i suoi genitori già avevano alle spalle un’altra fuga, quella che nel 1954 li aveva condotti dal Vietnam del Nord a quello del Sud), prima di darsi alla narrativa ha pubblicato due solide monografie accademiche, Race and Resistance: Literature and Politics in Asian America nel 2002 e Niente muore mai nel 2016 – pubblicate rispettivamente da Oxford University Press e Harvard University Press, non proprio bruscolini [la seconda successivamente pubblicata in Italia da Neri Pozza]. Solo di recente questo docente universitario (che insegna alla University of Southern California) si è dedicato alla narrativa, colla sua opera d’esordio, il romanzo Il simpatizzante (vincitore del Premio Pulitzer nel 2016 e uscito da noi per i tipi di Neri Pozza l’anno scorso). Orbene, dato tutto quel che ho appena scritto, capirete che la questione dell’appartenenza nazionale, dell’identità etnica, del chiedersi se si è americani o vietnamiti o che cosa, l’autore di I rifugiati la conosce bene, l’ha appresa sulla sua pelle, e non a caso la si ritrova in tutte le pagine di questi racconti nonché in quelle del suo voluminoso romanzo.
Beninteso: le storie raccontate ne I rifugiati, da questo punto di vista, non sono originalissime. Sono storie che tanti emigrati potrebbero raccontare e hanno raccontato. Il senso di vivere in due luoghi contemporaneamente, quello ricordato e quello vissuto nel presente; il senso di non sentirsi completamente a casa né qui né là; il senso di essere a metà tra due mondi e per questo di poterli vedere in un modo che non è concesso a chi non ha compiuto quel passaggio; il fatto di districarsi tra due lingue, due cucine, due mentalità, due mappe mentali, due universi di riferimento. Questa è esperienza comune ai vietnamiti espatriati negli Stati Uniti come agli italo-americani o a chiunque altro per qualsivoglia motivo abbia lasciato il proprio paese di nascita e si sia trovato alle prese con un mondo diverso. Gli studi sulla letteratura della migrazione ci hanno insegnato che, pur tenendo conto di tutte le differenze storiche e geografiche, l’esperienza del migrante ha comunque alcune fondamentali costanti psicologiche, antropologiche, simboliche, che ormai sono state ben individuate.
Però quella di Viet Thanh Nguyen e dei suoi personaggi è una migrazione affatto speciale. Sì, tanti hanno lasciato casa per trovare lavoro altrove; tanti sono stati fatti sloggiare da una guerra o da persecuzioni; tanti hanno faticato a inserirsi, come la Vivian di “La terra del padre” (nonostante le apparenze) o la signora Hoa di “Anni di guerra”, che ancora s’illude, raccogliendo soldi tra gli espatriati, di poter contribuire ad abbattere il regime comunista che ormai governa in tutto il Vietnam. Ma Saigon è un’altra cosa. Citando il capitano Willard di Apocalypse Now: “Saigon. Cazzo. Sono ancora soltanto a Saigon. Ogni volta penso che mi risveglierò di nuovo nella giungla… Quand’ero qui volevo essere in America. Quand’ero là, pensavo solo a tornare nella giungla.”
Insomma, Saigon metonimia del Vietnam, e il Vietnam un paese leggendario, attorno al quale orbita un autentico mito mediatico e culturale. Un mito forse un po’ affievolito ultimamente, anche se i fallimenti americani in Medio Oriente hanno fatto dire subito: “è un altro Vietnam”. Insomma, l’emigrazione vietnamita (oggetto anche del film Gran Torino diretto da Clint Eastwood) è come tutte le altre, ma al tempo stesso ha qualcosa di diverso, qualcosa di intrinsecamente mitico. Questa qualità leggendaria, e Nguyen ne è ben consapevole, ha molto a che fare con alcune celebri pellicole hollywoodiane, prima tra tutte ovviamente quella di Francis Ford Coppola che ha ispirato il film alla cui realizzazione collabora il protagonista/narratore de Il simpatizzante. Ha anche a che fare con la storia degli anni Sessanta e Settanta, quando il Vietnam era sulla bocca di tutti, quando la tragica storia della sua decolonizzazione a metà, della sua divisione, della sua occupazione strisciante da parte degli americani e di tutto il resto contribuirono ad accendere le proteste del Sessantotto. Ed è interessante sentir raccontare di nuovo quella storia da un vietnamita, anche se, si badi bene, uno che all’epoca della guerra era un bambino, e che l’evacuazione di Saigon e la caduta del Vietnam del Sud l’ha ricostruita con gli strumenti dello storico, non attraverso una memoria personale (per quanto non escludo che qualche ricordo dell’autore sia entrato nei racconti come nel romanzo).
E dovendo scegliere preferisco i racconti al romanzo. Sulla misura breve un esordiente alla narrativa come Nguyen se la cava egregiamente, raccontando storie di stralunata ma credibilissima quotidianità spesso tagliate bruscamente, quasi senza un vero epilogo (come in “Qualcun altro oltre te”), talvolta con una chiusa che ti lascia li a farti parecchie domande (come in “Donne dagli occhi neri” oppure “L’altro uomo”). Mentre Il simpatizzante dimostra che è assai difficile per un autore alle prime armi riesca a gestire un romanzo di cinquecento pagine senza mai sbandare o andare a sbattere da qualche parte. Beninteso, ci sono pagine dell’opus magnus di Nguyen decisamente ammirevoli, e comunque i discorsi che porta avanti sono estremamente interessanti, ma l’impressione che se ne ricava è che lo scrittore viet-americano abbia voluto comprimere in una sola vicenda il materiale per quattro romanzi e quattro personaggi, e ne sia uscito fuori qualcosa che non si tiene insieme; e che inoltre ogni tanto lo scholar, lo studioso di stampo accademico, prenda il sopravvento sul narratore, sull’ufficiale dell’esercito sud-vietnamita, sull’infiltrato, sul simpatizzante, insomma. Ogni tanto hai la sensazione di stare ascoltando una lezione, interessantissima, intelligentissima, però pur sempre una lezione.
Non ce lo dimentichiamo: siamo in un’epoca in cui spesso capita di leggere romanzi americani gonfiati, in modo certo più abile di quanto non si faccia da noi, ma pur sempre ingranditi oltre misura, oltre la capacità delle idee che li animano di farli muovere e respirare; non escludo che ciò si debba a una pressione da parte delle case editrici d’oltreoceano tesa a far scrivere il great American novel, col risultato di ritrovarsi con un libro che di great ha solo il numero delle pagine, com’è per esempio il caso delle Fantastiche avventure di Kavalier e Clay, di Michael Chabon (dove comunque il rigonfiamento infastidisce assai più di quanto non accada nelle pagine del Simpatizzante, sia ben chiaro).
Sulla misura del racconto, invece, Nguyen convince: nessuno dei suoi personaggi, inclusi i narratori, pare un aggregato ai limiti dell’inverosimile come il protagonista de Il simpatizzante. La ghostwriter del primo racconto è quel che deve essere, come pure il profugo Liem in “L’altro uomo”; e anche i personaggi non vietnamiti (ma sempre appartenenti a quelle che negli Stati Uniti sono minoranze emarginate), come l’ispanico Arthur Arellano de “Il trapianto” o l’afroamericano Carver ne “Gli americani” risultano persuasivi, gente che potresti conoscere, non assemblaggi letterari un po’ pericolanti.
Una nota ora vorrei farla sul titolo italiano della raccolta, I rifugiati; mi sono chiesto, perché non tradurre The Refugees con I profughi? Riflettendoci su mi sono detto che la scelta è azzeccata, in quanto “rifugiato” suggerisce un profugo che comunque gode della protezione di qualche organizzazione umanitaria, sia l’ONU o qualche ONG. I vietnamiti in questi racconti sono stati “salvati” dalla caduta di Saigon, portati in salvo in America. Hanno uno sponsor che ha garantito per loro (quello che invece cerca inutilmente Phuong, la ragazza che vorrebbe scappare dal Vietnam di oggi in “La terra del padre”). Però, e in questo sta la terribile ironia del titolo, l’arrivo in America non li mette in salvo dai meccanismi stritolanti dell’economia e della società americana, dalla discriminazione, dalla marginalità, dall’incomprensione, e pure dalla voglia di tanta parte della società americana di dimenticare Vietnam e vietnamiti dopo essersi scottata con quella guerra lunga, sporca e feroce. L’America, pare dire Nguyen, è un rifugio non proprio sicuro, anzi, spesso non è affatto un rifugio. Per cui traduttore e casa editrice hanno scelto bene, conservando l’ironia amara dell’originale.
Infine, considerate un attimo questo fatto: a Viet Thanh Nguyen è andata sicuramente meglio che a certi suoi personaggi. Non solo negli Stati Uniti è diventato un professore universitario che pubblica i suoi saggi con le più prestigiose case editrici accademiche del pianeta. Ha anche inaugurato una carriera sfolgorante come scrittore conquistando il Pulitzer al primo romanzo, e venendo tradotto in diverse lingue. Ora chiedetevi: un cinquantenne nato – poniamo – in Etiopia, Somalia o Libia da genitori del posto, emigrato coi suoi in Italia nel 1975, ha mai vinto un concorso da professore ordinario in uno dei nostri atenei, per poi vincere anche di recente il Premio Strega? Ve la immaginate una success story come questa in Italia? Lasciate stare, ci vorrebbe la fantasia di qualche scrittore di fantascienza o di fantasy. Da noi c’è lo ius sanguinis per tutto; inclusi i premi letterari.