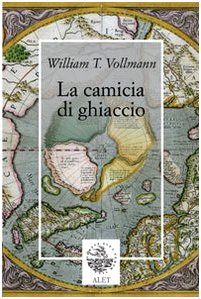Data la recente ripubblicazione del romanzo di Vollmann da parte di minimum fax, abbiamo pensato di riproporre questo pezzo uscito su PULP Libri numero 73, (maggio/giugno 2008, pp. 10-14) per la nostra rubrica PULP Vintage.
Prima di cominciare, vediamo di evitare la propagazione di leggende metropolitane: William T. Vollmann ci vede abbastanza bene – nonostante gli occhiali spessi dalla montatura decisamente demodé. Altrimenti non potrebbe alternare alla sua attività di narratore quella di reporter internazionale. Se si fa chiamare “William il Cieco”, nell’ultimo romanzo pubblicato in Italia, La camicia di ghiaccio (Alet, pp. 475, euro 21,00, solida traduzione di Nazzareno Mataldi), è perché gioca su un topos antichissimo, quello di Omero non vedente, che però scruta con l’occhio interiore del narratore.
Non si può difatti negare l’ambizione epica dello scrittore statunitense in questo romanzo, nuovo per noi ma in realtà uscito negli Stati Uniti 18 anni fa. La camicia di ghiaccio apre un ciclo di sette opere chiamato “Sette sogni”, che si ripromette di raccontare in altrettante tappe la storia complicatissima, atroce e ancora non del tutto chiara di come gli europei sono entrati in contatto coi nativi americani; ciò equivale necessariamente a riflettere anche sul risultato di quell’incontro, gli Stati Uniti per l’appunto. Non è una cosa da poco, e ci voleva il coraggio di Vollmann anche solo per concepirla. Non a caso dopo diciott’anni il progetto è ancora lontano dal completamento: l’autore ha ultimato finora quattro volumi, e cioè, oltre alla Camicia di ghiaccio, Fathers and Crows (sui gesuiti francesi nel Quebec e le loro lotte con gli irochesi), Argall (la storia di Pocahontas e del capitano John Smith) e The Rifles (sulla disperata ricerca del passaggio a Nord-Ovest e i difficili rapporti tra bianchi e inuit nel grande Nord canadese).
Si sa già, comunque, che altri tre romanzi dovranno completare il magnum opus: due ancora da scrivere, The Poison-Shirt (sulla guerra tra i puritani del New England e gli indiani nel Seicento) e The Dying Grass (sulla distruzione degli indiani nelle grandi pianure nell’Ottocento), e uno che si annuncia parzialmente completato, ovvero The Cloud-Shirt (sulle lotte tra Navajo e Hopi e compagnie petrolifere nell’Arizona del secolo scorso). Tenendo conto che i volumi dovrebbero essere tutti sulle 400 pagine, per un totale di quasi tremila, non so se restare sbalordito più dal coraggio dello scrittore, o della casa editrice Alet che pare seriamente intenzionata a tradurre e pubblicare l’intero ciclo (non che di coraggio editoriale non vi sia bisogno, dalle nostre parti).
Ovviamente quantità non vuol sempre dire qualità; ma in questo caso, decisamente sì. La camicia di ghiaccio, pur tenendo conto di ciò che può perdersi in traduzione nella resa di uno stilista sbalorditivo, è di una bellezza abbagliante come i ghiacci della Groenlandia che incombono su tutta la cupa vicenda raccontata. Del resto, è da qualche tempo che negli Stati Uniti e da noi gli addetti ai lavori continuano a sussurrare con reverente ammirazione il nome di Vollmann come (perdonate l’inglese) The Next Big Thing nella letteratura d’oltreoceano. Prova ne è il National Book Award conferitogli nel 2005 per il suo poderoso romanzo Europe Central, ambientato nel nostro continente durante la seconda guerra mondiale.
Prenderò spunto proprio da una recensione americana di Europe Central (che mi auguro venga presto tradotto) per spiegare cosa sia La camicia di ghiaccio e perché meriti attenzione. Sostiene il New York Times Book Review che Europe Central è “in parte romanzo in parte racconti, una virtuosistica rimemorazione storica e un attento studio della violenza”. Ebbene, questo si può dire tranquillamente anche della Camicia di ghiaccio. Aggiungerei che oltre a questo, nelle quattrocento e passa pagine dell’edizione Alet, troverete anche un brillante libro di viaggio.
È la molteplicità della scrittura di Vollmann, alias William il Cieco, a stupire. Nel primo romanzo dei Sette sogni ci racconta la storia della colonizzazione vichinga della Groenlandia alla fine del primo millennio, partendo dal tempo mitologico di re che si trasformavano in orsi (ispirandosi allo stile dell’antico poeta Snorri Sturlusson), e giungendo alla vicenda affatto terrena del nobile ma sfigato Eirik il rosso, uomo di maniere spicce, che a furia di essere bandito dalle varie terre conquistate dai norvegesi se ne deve andare ai confini del mondo conosciuto, a insediarsi nei fiordi di quell’isola in gran parte ghiacciata che per i vichinghi era una penisola della Russia (non sapevano che sotto i ghiacci del Polo Nord, nella loro lingua Jötunheim, c’era il mare).
All’epoca il clima era più mite (più o meno come oggi, che i ghiacci della Groenlandia si stanno squagliando a ritmo forsennato), e fu possibile per qualche secolo vivere sui bordi meridionali, scoperti e coltivabili, della grande isola nordica; ma nel Quattrocento il clima s’irrigidì, spazzando via gli insediamenti vichinghi. Quando Colombo arrivò in America nel 1492 dell’impresa dei nordici s’era quasi perso il ricordo. Eppure in quell’arco di secoli, dal 980 al 1400 circa, c’erano europei sul continente americano, che giunsero a sbarcare e a insediarsi per un breve periodo sulle coste della Terranova, oggi parte del Canada. Quella terra la chiamarono Vinland, la landa del vino, e gli strani personaggi che incontrarono li definirono nella loro lingua skraeling. Il termine, ovviamente, copriva sia gli inuit (quelli che ci ostiniamo a chiamare eschimesi) che i nativi americani (quelli che continuiamo a chiamare indiani), probabilmente appartenenti alla tribù micmac.
Ed è proprio l’incontro tra nativi americani e vichinghi che interessa Vollmann. Ma oltre a ripercorrere quell’antico scontro tra civiltà (tanto per cambiare discretamente sanguinario, come si vedrà), basandosi sui testi delle antiche epiche norrene (puntigliosamente citati in un ricco apparato di note, e brillantemente riscritti inventando un inglese da vichinghi), Vollmann, come negli altri volumi dei Sette sogni, viaggia (nel 1987) nelle terre dove quell’incontro ebbe luogo, va a visitare la Groenlandia, va a conoscere i groenlandesi di ceppo danese e quelli di sangue inuit o misto, e va a verificare come ancora oggi i rapporti tra i due mondi siano tutt’altro che idillici. Ed è qui il fascino pressoché sublime del libro: nel cortocircuito tra il passato antichissimo dell’epica e il presente attualissimo della cronaca di viaggio; tra l’antichità vichinga e la tarda modernità degradata. Lasciando che i due tempi si aprano l’un l’altro, e miracolosamente si complementino e si spieghino a vicenda.
Le visite di Vollmann in Groenlandia e nelle isole a nord del Canada (esperienze che emergono ancor più drammaticamente in The Rifles) consentono allo scrittore americano di operare quella sorta di atto magico che è la ragion d’essere del romanzo storico: l’evocazione dei defunti. Ai groenlandesi di ceppo vichingo protagonisti del suo romanzo Vollmann risale da un lato attraverso una lettura attenta dell’epica scandinava; dall’altro attraverso un’immersione totale nel paesaggio naturale del grande Nord. È recandosi e vivendo nei luoghi dove presumibilmente avvenne l’incontro tra scandinavi e inuit e/o indiani micmac, che Vollmann riesce a dare a quest’episodio, descritto dall’epica norrena in modo unilaterale e con tutte le licenze della poesia altomedievale, una concretezza e una vita che sono segno del grande narratore. Nonostante la sua maniera di strutturare il romanzo sia tutt’altro che classica; nonostante l’intenso e visionario lirismo che pervade il libro. E nonostante una violazione delle regole fondamentali e non scritte dell’epica.
Se vi aspettate infatti una vicenda al cui centro ci sia qualche eroe virile stile Achille o Enea, lasciate perdere. Il palcoscenico della Camicia di ghiaccio è occupato da due donne, due personaggi femminili che escono dalla pagina e impongono una presenza pressoché carnale: la bella e fascinosa Gudrid Thorbjornsdottir, a metà tra regina e santa; e la demonica Freydis Eiriksdottir, dominatrice e strega, votata alla spaventosa divinità groenlandese Amortortak. La parte più brutale e affascinante del romanzo, ovvero il tentativo dei vichinghi di colonizzare Wineland la Buona (cioè il continente americano), ruota attorno alle personalità poderose di queste due donne, al confronto delle quali gli uomini della vicenda, pur armati d’ascia e di scudo, sono sempre e solo comprimari. Sulla loro competizione, sulle loro diverse forme di avidità, sulle loro reciproche incomprensioni che sfociano in puro odio, si gioca l’incontro tra gli europei e i nativi americani: il sanguinoso fallimento del quale rivela molto dei fantasmi che ossessionano gli uni e gli altri.
Vollmann infatti non gioca la sua partita solo su questa terra. Lo scontro di civiltà (a colpi d’ascia e di fionda) si duplica infatti nell’incontro tra due mondi immaginari: la cupa e tragica religione pagana scandinava (le cui torve divinità non a caso hanno alimentato tanto immaginario fumettistico, dal mitico Thor della Marvel al Sandman di Neil Gaiman), la visionaria e spiazzante religione animistica di inuit e micmac. Il cristianesimo, su questi nordici dell’anno Mille, è solo una leggera verniciatura; nelle loro menti ribollono poderose le mitologie ferine della preistoria germanica, e soprattutto la serie delle camicie (di ghiaccio ma anche d’altre materie), non semplici vestimenti ma stati mentali, immagini archetipe, simboli esistenziali. Eppure, nonostante i due paganesimi (quello dei vichinghi e quello degli amerindi) siano tutto sommato concettualmente imparentati, essi esprimono diverse e difficilmente compatibili visioni del mondo.
I coloni groenlandesi e islandesi portano infatti in sé la cultura della guerra in senso europeo, scontro di annientamento e asservimento. Uno scontro tante volte scatenato tra i popoli europei, nel quale i vichinghi erano allora maestri insuperati; sono infatti questi gli anni della grande espansione di quei guerrieri, mercanti e navigatori che da Svezia, Norvegia e Danimarca s’irradieranno in tutto il Nordeuropa, giungendo poi fino nel nostro sud. Questo Vollmann lo ha ben chiaro in mente, e lo incarna nell’ascia dalla lama d’acciaio, l’arma per eccellenza dei vichinghi, l’arma che gli skraeling brameranno ma poi rifiuteranno in una delle scene più potenti del romanzo.
Ci sarebbe molto altro da dire. Non è uno di quei libri che si lasciano congedare con qualche discorsetto preconfezionato. Non è una di quelle narrazioni che si lasciano dimenticare. E tanto per rendere omaggio a uno dei maestri di Vollmann, non è un paese per vecchi. Si tratta di una storia cupa e cruenta, di bastardi assetati di sangue e ricchezza, contro altri bastardi assetati di potere e gloria. Eppure è anche una sorta di magico, ipnotico, allucinatorio poema in prosa, nella quale la lingua inglese (cui Vollmann fa rammentare la parentela con quelle dei vichinghi) subisce uno strano processo di imbarbarimento epico nelle mani di uno dei suoi più grandi artefici (non solo negli Stati Uniti). E alla magia di questa lingua ci si deve arrendere; e indossare anche noi la camicia di ghiaccio.