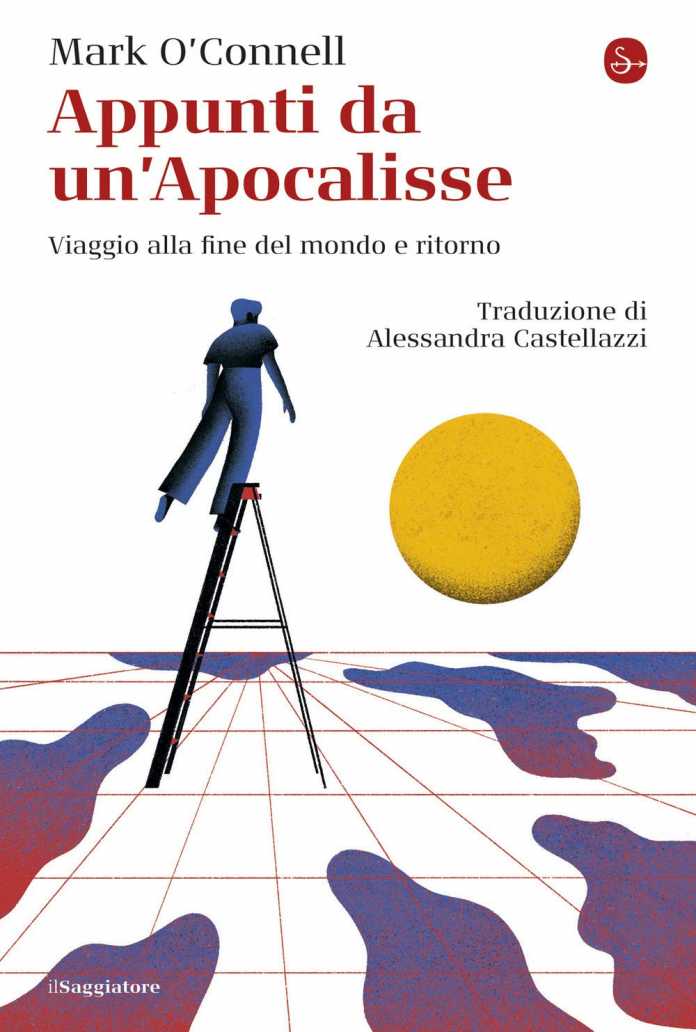“Era la fine del mondo e io ero sul divano a guardare i cartoni animati con mio figlio.” In Tv il cartoon racconta di un orso carino e buffo e di una bambina, sullo smartphone arriva invece il video “straziante”, “che spezza l’anima” di un orso polare emaciato e reale, cioè in ossa e pochissima carne, che si trascina tra i rifiuti. Spoiler: l’Iphone che informa Mark sugli effetti del riscaldamento climatico appartiene alla stessa tecnologia che contribuisce a produrlo, il cortocircuito gli monta all’istante “un’ondata di vergogna e tristezza per il mondo in cui mio figlio sarebbe stato costretto a vivere”. Ma l’ansia per questa apocalisse sistemica, che lo insegue e lo colpevolizza anche nell’intimità domestico-familiare, è “troppo lenta”, molto diversa – osserva – dal terrore per l’apocalisse atomica con cui è cresciuto da bambino nei ruggenti anni Ottanta, in mezzo a miliardi di umani inchiodati come spettatori davanti alla telenovela del Final Countdown. Qui la convinzione che genitorialità fornisca anche un surplus di responsabilità – uno dei leitmotiv del libro – completa gli ultimi tasselli del quadro motivazionale, insomma deve fare qualcosa. E “qualcosa” sarà un viaggio (“pellegrinaggio”) dell’eroe riluttante – bianco, maschio e mediamente progressista – alle radici della sua e della nostra angoscia ecologica ed esistenziale. E se non siete convinti, pazienza. Lui si scusa per la sua esagerata impronta di carbonio (“ampia, profonda e indelebile come la mia colpa”) destinata ad allargarsi anche in seguito a questa peregrinazione, poi saluta e parte.
Mark O’Connell, giornalista, scrittore di reportage, aggiorna in Appunti da un’apocalisse la formula collaudata di Essere una macchina (Adelphi, 2018): se là incontrava scienziati technogeek e sette transumaniste accomunate dalla fede nella futura sopravvivenza postumana, qui si parla tanto per cominciare di miliardari annoiati e di una classe media americana inquadrata nelle fila (e nel fiorente mercato) del movimento survivalista. Sono i Preppers, gente che si prepara con zelo paramilitare degno di miglior fine a “quando la merda arriverà al ventilatore”. In pratica a sopravvivere alla Catastrofe – del welfare state, climatica o semplicemente biblica, quella che verrà prima – da molti di loro spasmodicamente attesa più che temuta come un vento che spazzerà via assieme alle infrastrutture vitali tasse, governo, femministe e politicamente corretto, portando indietro nel tempo gerarchie e lancette dell’orologio, per i pochi sopravvissuti che si impegneranno nella futura lotta per la sopravvivenza. Una cartina al tornasole, certo, delle paure e dei veri sogni bagnati di una fetta consistente della società bianca in questo momento, un modo per riconoscersi tra simili in una visione che non interroga tanto l’angoscia del futuro quanto del presente, sfogata nello shopping compulsivo di coltelli, maglieria tattica, cibi liofilizzati e zaini per la fuga.
 Il “pellegrinaggio” porta Mark – che in caso di Apocalisse, ci assicura, preferirebbe soccombere con la prima ondata – in South Dakota, tra i bunker sotterranei riconvertiti in abitazioni sicure e soprattutto a prova di incursioni, per la classe media, mentre un ex pubblicitario destrorso riconvertito ad agente Tecnocasa gli fa da Virgilio. Di lì atterra in Nuova Zelanda, il nuovo paradiso degli anarco-capitalisti di ventura, paperoni super libertari come Peter Thiel, (315º uomo più ricco al mondo con un patrimonio di 2,5 miliardi di dollari), transitato da Paypal (pagamenti digitali) a Palantir (dati) e SpaceX (voli spaziali). La Nuova Zelanda è la terra promessa per chi può comprarsi oggi la cittadinanza per sperare di assistere, un giorno all’Apocalisse degli altri divorando popcorn e contando bitcoins. Perché, insomma pochi si salveranno e gli anarco capitalisti e i fan di Ayn Rand, del resto, non hanno mai nascosto di pensarlo anche nei loro testi sacri, come il seminale The Sovereign Individual: How to Survive and Thrive During the Collapse of the Welfare State (1997) di James Dale Davidson e William Rees-Mogg, di cui Mark giura di aver comprato solo una copia usata e bisunta per non regalare soldi al nemico.
Il “pellegrinaggio” porta Mark – che in caso di Apocalisse, ci assicura, preferirebbe soccombere con la prima ondata – in South Dakota, tra i bunker sotterranei riconvertiti in abitazioni sicure e soprattutto a prova di incursioni, per la classe media, mentre un ex pubblicitario destrorso riconvertito ad agente Tecnocasa gli fa da Virgilio. Di lì atterra in Nuova Zelanda, il nuovo paradiso degli anarco-capitalisti di ventura, paperoni super libertari come Peter Thiel, (315º uomo più ricco al mondo con un patrimonio di 2,5 miliardi di dollari), transitato da Paypal (pagamenti digitali) a Palantir (dati) e SpaceX (voli spaziali). La Nuova Zelanda è la terra promessa per chi può comprarsi oggi la cittadinanza per sperare di assistere, un giorno all’Apocalisse degli altri divorando popcorn e contando bitcoins. Perché, insomma pochi si salveranno e gli anarco capitalisti e i fan di Ayn Rand, del resto, non hanno mai nascosto di pensarlo anche nei loro testi sacri, come il seminale The Sovereign Individual: How to Survive and Thrive During the Collapse of the Welfare State (1997) di James Dale Davidson e William Rees-Mogg, di cui Mark giura di aver comprato solo una copia usata e bisunta per non regalare soldi al nemico.
Ma la Nuova Zelanda, ultimo avamposto della civilizzazione anglosassone con retrogusto di natura incontaminata, è pur sempre un rifugio temporaneo in attesa di spiccare il volo verso la “vera libertà” su Marte, il pianeta di backup della fantascienza distopica, nuova ed esclusiva frontiera del lusso survivalista. È il sogno di Bezos, Richard Branson e ovviamente di Elon Musk, che O’Connell definisce senza andare troppo per il sottile “un perfetto idiota che per qualche imperscrutabile capriccio divino aveva ricevuto dagli dei il triplice dono dell’intelligenza, dell’ingegno e del denaro: doni che ha adoperato esattamente da idiota”, riferendosi alla sua trovata di lanciare una Tesla nell’orbita solare. Una dubbia reclame per un messaggio comunque chiarissimo: spazio ultima frontiera. “Gli esseri umani non possono più andare ad ovest” come scrivono Charles Wohlforth e Amanda R. Hendrix in Beyond Earth: Our Path to a New Home in the Planets (Pantheon, 2016). E Stephen Hawking, che dava agli umani suppergiù un secolo per trovarsi una seconda casa, sarebbe stato d’accordo.
Nella seconda parte del libro si moltiplicano gli spunti di sapore intimista, scoperchiando il racconto ai moti dell’anima. Dopo un flashback genitoriale (“diventare genitore aveva illuminato quell’oscurità invadente”), a base di Dr. Seuss (“Leggere il Lorax a un bambino era divertente, ma anche un rito doloroso”), Mark incontra i survivalisti green del Dark Mountain Project e si imbarca in “un’esperienza di immersione nella natura” delle Highlands scozzesi. Affronta in solitudine i suoi demoni e le sue paure, non solo i serpenti ma le falene (“cos’è che in queste creaturine indifese che mi travolge di disgusto e di un terrore così forte?… Parlai di questa fobia dopo più di un anno che andavo dall’analista”) ma dopo qualche pagina le razionalizza, capisce dove sbagliava (“il mio far nulla, riflettevo sull’erba soffice, significava sempre fare qualcosa”) e poco dopo comincia a vedere la luce in fondo al tunnel.
L’ultima tappa del viaggio o’connelliano è naturalmente a Chernobyl, la Zona dove la natura nel frattempo si è presa la sua rivincita. In una gita organizzata di turismo estremo esistenziale a Pripyat, tra cani randagi dal pelo ancora potenzialmente latore di particelle radioattive e i quaderni tristemente abbandonati nell’atrio di una scuola, qui finalmente il climax raggiunge il suo culmine (“il mio disagio non aveva tanto a che fare con il rischio di essere contaminato ma di essere contaminante”). È tempo di tornare a casa, dove suo figlio gli spiega che la vita rimane comunque “una cosa interessante”.
Mark è il protagonista totale della sua storia, anche perché dall’inizio è, in tutti i sensi, la storia di Mark. Gli altri personaggi sono assenti o bidimensionali, cattivi da film serie Z come Thiel o comparse con la battuta segnata come gli amici che incontra o che lo accompagnano per un breve tratto del suo pellegrinaggio. Le rare figure femminili tutte dispensatrici di una saggezza naturale, terranea cioè poi irrilevante. Sua moglie una donna con “capacità di ripresa insondabile e saggezza pratica” alla quale le sue crisi di panico sono “essenzialmente estranee”. “Mark” è il dispositivo narrativo attraverso cui tutte le nostre aspettative culturali, variamente derivate dalla fiction letteraria, cinematografica, televisiva, vengono visualizzate e ricevono puntuale conferma emozionale (“come un film di Terrence Malick”, “Conosci James Ballard?”, “Pensai al racconto di Borges.”, “la poesia di Czesław Miłosz…”). E la ricevono in presa diretta, nel qui e ora della scena “reale”, cioè dai “fatti”, che Mark ci usa la compiacenza di far sempre combaciare con il nostro immaginario e le nostre attese intellettuali (“Cazzo, proprio come quel film”). I suoi pensieri sono i nostri come intonazione poiché vengono presentati nel momento stesso dell’azione, non sono mai ripescati un anno dopo dal taccuino né nascono da una successiva riflessione come succederebbe a me o a voi.
Uscito sul mercato anglosassone in piena pandemia, Appunti per un’Apocalisse, è stato salutato come un libro particolarmente precorritore dei tempi, se non proprio profetico, benché il rischio pandemico non figuri in realtà in cima alle paure dei Prepers né del suo autore. Ci sono viaggi, e relativi reportage, che censiscono la complessità riportandone al lettore uno spicchio sufficientemente ampio per mettere in moto l’anello virtuoso della ricerca e della conoscenza. Altri che, come questo ultimo di O’Connell, offrono solo un biglietto di andata e ritorno tra i pensieri dell’autore, e confermano più o meno piacevolmente le nostre convinzioni di partenza. Mark O’Connell alla fine è un Michele Serra che ce l’ha fatta ad alzarsi dalla sua amaca, per poi tornarci con animo sollevato e pronto per fare la differenziata.