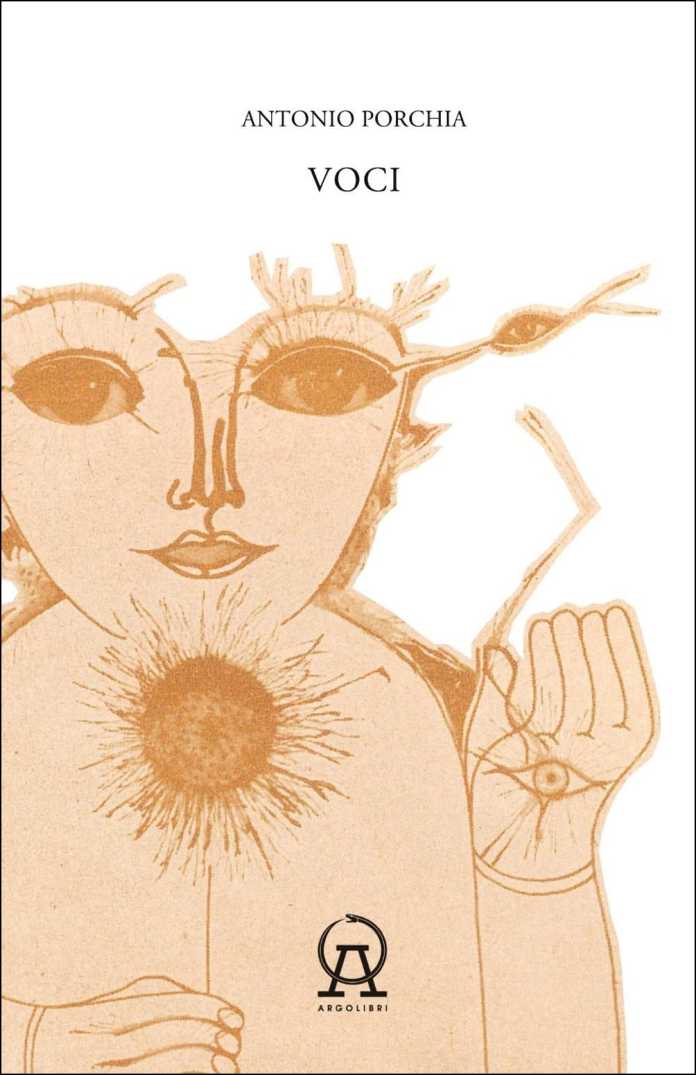Le voci di Antonio Porchia non sono soltanto nella sua testa. Si potrebbe iniziare così, deviando dalla solita battuta di cattivo gusto, e di sostanza ancora peggiore, per poi arrivare a quello che c’è, effettivamente, nella testa dell’autore italiano naturalizzato argentino Antonio Porchia (1885-1968). Tutto un mondo – si potrebbe continuare, per dare ancora spazio ai cliché – e decisamente accogliente, peraltro, come ha sottolineato anche Alejandra Pizarnik, usando parole molto migliori di queste, in una lettera indirizzata a Porchia e inclusa nel volume a titolo di introduzione: “il suo libro è il più solitario, il più profondamente solo che sia mai stato scritto al mondo e nonostante ciò, rileggendolo a mezzanotte, mi sono sentita accompagnata o, meglio ancora, protetta”.
La lettera, peraltro, era già stata pubblicata tre anni fa nel volume che raccoglieva le corrispondenze epistolari della poetessa argentina, L’altra voce. Lettere 1955-1972 (Giometti & Antonello, 2019), con traduzione di Andrea Franzoni, il quale – in qualità di curatore, insieme a Fabio Orecchini, della collana Talee di Argo Libri – si è ora imbarcato nella traduzione di Voci. Come spesso accade, una traduzione ne richiama un’altra: a questo proposito, è opportuno ricordare, en passant, come nella stessa lettera Pizarnik accenni a un comune amico dei due, il poeta argentino Roberto Juarroz (1925-1995), che – pur citato variamente anche da Roberto Bolaño, nelle sue opere – resta ancora relativamente a secco di traduzioni italiane.
 Tornando al presente volume, Franzoni lo chiude con una paginetta di nota del traduttore che sarebbe da manuale, se un manuale per chi traduce poesia potesse, di fatto, esistere: in essa ricorre con maestria al mistico persiano Rumi per presentare la traduzione come “intuizione”, ancor prima che come progetto babelico che affonda in tutte le lingue esistenti o possibili. A questo importante passaggio, Franzoni aggiunge anche una considerazione basata sull’aneddotica della vita di Porchia che conviene riportare per intero, per avvicinarci al nucleo fondamentale del libro: “Ciò che resta anche se non resta, è propriamente la ‘voce’, motivo per cui Porchia ebbe a chiamarle così, rifiutando nettamente l’appellativo di aforismi, o poesie. A chi gli chiese il motivo per cui le avesse chiamate Voci, l’autore rispose: ‘È difficile dirlo. Tutto si ascolta. E si ascolta di tutto’”.
Tornando al presente volume, Franzoni lo chiude con una paginetta di nota del traduttore che sarebbe da manuale, se un manuale per chi traduce poesia potesse, di fatto, esistere: in essa ricorre con maestria al mistico persiano Rumi per presentare la traduzione come “intuizione”, ancor prima che come progetto babelico che affonda in tutte le lingue esistenti o possibili. A questo importante passaggio, Franzoni aggiunge anche una considerazione basata sull’aneddotica della vita di Porchia che conviene riportare per intero, per avvicinarci al nucleo fondamentale del libro: “Ciò che resta anche se non resta, è propriamente la ‘voce’, motivo per cui Porchia ebbe a chiamarle così, rifiutando nettamente l’appellativo di aforismi, o poesie. A chi gli chiese il motivo per cui le avesse chiamate Voci, l’autore rispose: ‘È difficile dirlo. Tutto si ascolta. E si ascolta di tutto’”.
Le Voci in effetti sembrano attestarsi sempre sulla soglia tra aforismatico e poetico, ma le qualità dell’aforisma ottengono di trasformare dall’interno quella che potrebbe apparire come poesia, e viceversa. Da questo andirivieni nasce qualcosa di fondamentalmente diverso e, per dirne una, ogni possibile relazione con un altro grande aforista latinoamericano, il colombiano Nicolás Gómez Davila (pubblicato in italiano da Adelphi: In margine a un testo implicito, 2001, e Tra poche parole, 2007, entrambi per la traduzione di Lucio Sessa e la cura di Franco Volpi) per poi passare ad altre sigle editoriali) viene a sgretolarsi. Alla quadratura non di rado violenta di un pensatore antimoderno come Gómez Dávila, per il quale “il reazionario è colui che si trova ad essere contro tutto quando non esiste più nulla che meriti di essere conservato”, Porchia può contrapporre una vociferazione continua, plurale, proliferante.
La sua opera è giocosa nella malinconia e abnorme nella brevità – del resto, Voci fu il progetto di tutta una vita –, e ancora: folle nella sua lucidità, ma universale nelle pur frequenti idiosincrasie. Il paradosso, generato dall’incontro alchemico di aforisma e poesia, è di casa, trasformando una superficie apparentemente semplice – di contro alla complessità filosofica e culturale esibita da un Gómez Dávila – in un territorio magmatico al quale è sempre utile tornare, scoprendo nuovi risvolti e pieghe. Basterà prendere a titolo di esempio qualche “voce” per darne conto: “Prima di trovare la mia strada, ero io la mia strada”; “Tutto è come i fiumi, opera delle pendenze”; “Sì, è entrando dentro ogni cosa che ne esco”; “Il non saper fare ha saputo fare Dio”; “Non sono soddisfatto di te. Ma neanche tu sei soddisfatto di te, allora sono soddisfatto di te”; “Ti racconti continuamente un sogno. E quando lo sogni?”; “Ho perso due volte, perché ho anche vinto”.
Come spesso accade, davanti a questa antologia è sempre possibile aprire il libro a caso, come una sorta di I Ching, e meditare e sorridere davanti a una di queste illuminazioni; si lascerà, dunque, tale scoperta per intero a chi vorrà leggere questo che, a conti fatti, è un complemento necessario per indagare un’intera costellazione letteraria, nell’Argentina del ventesimo secolo. Con ogni probabilità, chi lo vorrà fare si troverà di nuovo smarrito nel labirinto borgesiano, ma con un’eco delle Voci che ogni tanto riecheggia dietro l’angolo, inaspettata e vitale.