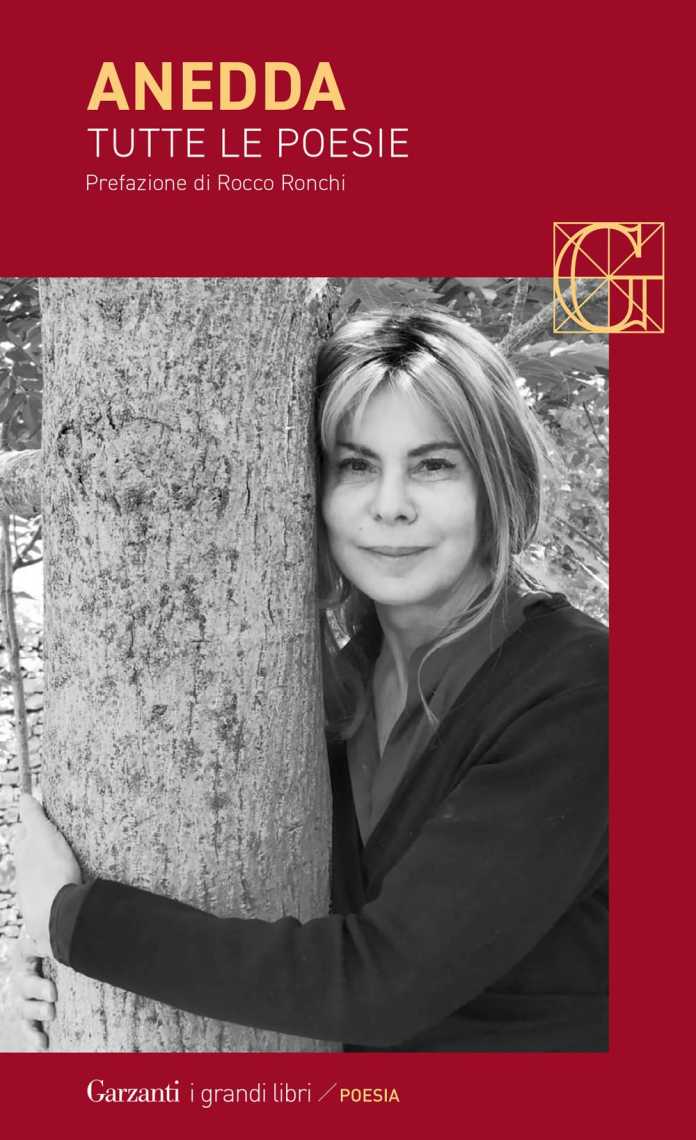I nomi, i dettagli, la vita piena e combattuta, avuta e trasformata, hanno da sempre e incessantemente intessuto i libri di Antonella Anedda, fin dall’esordio fulminante di Residenze invernali (Crocetti, 1992). In un continuo sostenere, nella sua dimensione umana, la spinta conoscitiva della lingua, le rasure talvolta necessarie dei termini terrestri, fino al nodo cruciale: la riconoscenza verso il respiro che detta la poesia, che arriva dalla terra d’origine, principio stesso di umanità nel senso più concreto. Con il volume che raccoglie l’opera in versi, in parte rivisitata per l’occasione, ci accorgiamo in maggior misura come i destini ci giungano attraverso la parola, che, tra le forme incise sui corpi e nella geografia, diventa necessaria come un golfo battuto dal vento all’isola della Maddalena, come una figlia ricevente in dono un libro, come tutte le madri che sanno aspettare scrutando l’arrivo del cattivo tempo e da che parte se ne va il bello.
 In ogni libro di Anedda gli anni stanno di fronte l’uno all’altro, rincantucciati dentro versi che sporgono improvvisi come balconate sul povero impero decadente del Mediterraneo. I versi si raccolgono in una lunga lettera, confortati da figure che offrono condizioni mirabili per il viaggio successivo alla partenza. È un lascito, dunque, che richiama a sé gli inverni, gli scontenti, le piaghe, le sabbie e il sale avuti dal passato fino all’epoca attuale. E che comprende le voci dentro la voce che non smette di darsi al mondo, quella di una poetessa coniugata alle cose, in cui sostenersi anche se esse sembrano svanire lontano, anche se i messaggi d’esistenza in vita sono sempre più deboli, come stessero varcando i confini del Sistema terrestre che ci siamo – brutalmente – dati. Le poesie che Anedda ha seminato in questo nostro attuale deserto conservano una forza condotta verso chi si presenta alla lettura con qualche briciola di fiducia. Nel tempo della fine la morte produce poderosi linguaggi, e dunque si fa primato una lirica che contrasti il buio e si rivolga ai sottili frammenti quotidiani e agli eventi spesso oscuri che stanno dentro i nostri contemporanei calendari. In queste poesie c’è tutto questo e qualcosa di più: la dimostrazione di come si possa sfuggire al peso del corpo e del sangue senza recidere al contempo la persuasione alla poesia: “In nessun luogo c’è bisogno di noi / tra un mese l’anno / avrà una cifra baltica, bianca”.
In ogni libro di Anedda gli anni stanno di fronte l’uno all’altro, rincantucciati dentro versi che sporgono improvvisi come balconate sul povero impero decadente del Mediterraneo. I versi si raccolgono in una lunga lettera, confortati da figure che offrono condizioni mirabili per il viaggio successivo alla partenza. È un lascito, dunque, che richiama a sé gli inverni, gli scontenti, le piaghe, le sabbie e il sale avuti dal passato fino all’epoca attuale. E che comprende le voci dentro la voce che non smette di darsi al mondo, quella di una poetessa coniugata alle cose, in cui sostenersi anche se esse sembrano svanire lontano, anche se i messaggi d’esistenza in vita sono sempre più deboli, come stessero varcando i confini del Sistema terrestre che ci siamo – brutalmente – dati. Le poesie che Anedda ha seminato in questo nostro attuale deserto conservano una forza condotta verso chi si presenta alla lettura con qualche briciola di fiducia. Nel tempo della fine la morte produce poderosi linguaggi, e dunque si fa primato una lirica che contrasti il buio e si rivolga ai sottili frammenti quotidiani e agli eventi spesso oscuri che stanno dentro i nostri contemporanei calendari. In queste poesie c’è tutto questo e qualcosa di più: la dimostrazione di come si possa sfuggire al peso del corpo e del sangue senza recidere al contempo la persuasione alla poesia: “In nessun luogo c’è bisogno di noi / tra un mese l’anno / avrà una cifra baltica, bianca”.
In ogni pagina scritta dalla mano vibrante di Anedda, nelle prose che invitiamo a rileggere (Cosa sono gli anni, Fazi, La vita dei dettagli, Donzelli) tutto questo è offerto in un nitore fermo e deciso, dove non può esistere un’ombra, un’indifferenza. Nei biglietti conservati fra i libri ritroviamo quanto resta (molto) di letture e scritture che Anedda ha tradotto da altre lingue. Cosa sono gli anni, se non le tappe di un viaggio che va di isola in isola, partendo dall’immensa città-madre? Poi, improvvisamente, scopriamo che fra Roma e La Maddalena si stendono le pianure letterarie orientali fin dentro le occidentali. E tutto si fa chiaro. C’è un racconto che sfila dalle bocche di Cvetaeva, Achmatova, Mandel’štam, fino a Beckett, Weil, Dickinson, Celan, Zach, Rosselli – un racconto giunto sulle coste del Mediterraneo.
Pagine che sostano, in una lingua che si fa carico del mutare del mondo, nei luoghi delle madri, dentro a paesaggi che talvolta si ha la spudoratezza di abbandonare. C’è un pensiero teso e continuo verso i discendenti, i figli con tutto il loro carico di presagi. Scrivere (“narrare”), per Anedda, è far sostare i momenti necessari in uno spazio accogliente: una tazzina di caffè in mano, l’aria tesa del mare davanti, un coro alle spalle che chiama, rendono preciso il corpo per quel momento. La grande varietà della sua poesia, costeggiando Jaccottet e Cvetaeva, tenta di spostarsi dove esiste e resiste una geografia, prima di tutto reale e “isolana”, dove l’isola a un certo punto sia culla dell’anima. Trent’anni dall’esordio luminoso di Residenze invernali, e giunti a Historiae (Einaudi, 2018) la poesia di Anedda resta la dimostrazione di come la vita poetica possa farsi carico delle cose del mondo. Un mandato resistentissimo, consola non appena ci viene in mente quanta fragilità sta per inghiottirci. L’oscillazione fra il proprio canto, che a fatica emerge dal mutismo a cui tutti siamo esposti, e “la parte di mondo che ci sembra estranea”, a cui sempre dobbiamo guardare. Antonella non sta bene al buio, dunque da sempre si rivolge alla porta spalancata a Oriente, verso i raggi che sono il rovescio della notte. È il suo pane, è parte di quelle cose che la chiamano “fin da bambina”: “Da allora cerco, provo a decifrare / a contare gli abeti / ma sento solo il mondo andare avanti e indietro”.