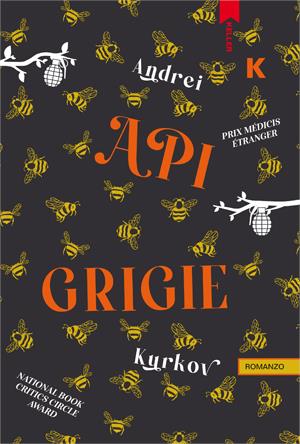Generalmente un romanzo può definirsi incompiuto se il suo autore lo sottrae, volontariamente o meno, alla massima ampiezza dei significati che l’intreccio potrebbe dispiegare. In questo caso il lettore percepisce una mancanza, abbastanza netta, che potrà estendere la sua ombra fino a intaccare la dimensione storica nella quale sono immersi i protagonisti del romanzo stesso. È questa la ragione per cui Meursault, il protagonista de Lo Straniero di Albert Camus, dopo l’omicidio del ragazzo arabo non ci appare come una metafora del colonialismo francese in Algeria, ma soltanto come una fragile maschera esistenzialista, succube delle circostanze. Un romanzo, però, si può rivelare come incompiuto anche quando è calato in un momento storico ancora non totalmente dispiegatosi, del quale finirà per rappresentare a posteriori la premessa, l’annuncio, l’incipit.
Dopo il 24 febbraio 2022, la narrativa contemporanea ucraina ha subito questo strano riassestamento retrospettivo: i romanzi pubblicati negli otto anni precedenti l’inizio dell’invasione su larga scala si sono fatalmente caricati di scenari premonitori e sinistri, che ora, nelle loro traduzioni occidentali, emergono come innumerevoli capi d’accusa contro chi avrebbe volentieri continuato a ignorare una “guerra a bassa intensità” silenziosa e invisibile, circoscritta al Donbass.
 Api Grigie di Andrei Kurkov rappresenta uno dei massimi esempi di questa “letteratura ante quem”, non soltanto per il focus narrativo puntato direttamente sul Donbass, ma soprattutto perché l’autore è oggi forse il maggiore scrittore ucraino vivente di lingua russa. Celebre per le sue posizioni di netta condanna dell’espansionismo putiniano quanto per la permanenza e la continuità del suo lavoro intellettuale nell’odierna Ucraina, Kurkov è scrittore poliedrico, un camaleonte stilistico capace di coniugare senza artificiosità le influenze culturali della natìa San Pietroburgo con le suggestioni storiche ucraine, presenti e passate.
Api Grigie di Andrei Kurkov rappresenta uno dei massimi esempi di questa “letteratura ante quem”, non soltanto per il focus narrativo puntato direttamente sul Donbass, ma soprattutto perché l’autore è oggi forse il maggiore scrittore ucraino vivente di lingua russa. Celebre per le sue posizioni di netta condanna dell’espansionismo putiniano quanto per la permanenza e la continuità del suo lavoro intellettuale nell’odierna Ucraina, Kurkov è scrittore poliedrico, un camaleonte stilistico capace di coniugare senza artificiosità le influenze culturali della natìa San Pietroburgo con le suggestioni storiche ucraine, presenti e passate.
Api Grigie è un romanzo interamente strutturato sulla capacità di vivere e violare le Colonne d’Ercole imposte da un conflitto. È una stand by novel che inaspettatamente si sblocca, diventando on the road, e lo fa proprio quando il nostro spirito di lettori è ormai persuaso di aver colto il significato esistenziale profondo dell’ostinata permanenza di due uomini in una “terra di nessuno” contesa. Sergeič e Paška vivono nella zona grigia del fronte, in un villaggio chiamato Malaja Starogradovka: un puntino geografico abbandonato da tutti gli abitanti (tranne loro due) perchè stretto tra le linee degli eserciti – quello ucraino e quello dei separatisti. I due unici residenti del villaggio vengono presentati come nemici atavici, eppure sul loro rapporto non grava alcuna specifica ferita passata: l’antipatia è solo un mero retaggio provinciale, esattamente lo stesso che li porta a vivere nelle due strade opposte del villaggio – non a caso dedicate a Taras Ševčenko (padre della lingua e della letteratura ucraina) e a Lenin (padre dell’Unione Sovietica).
La vita quotidiana in assenza di ogni struttura comunitaria, sociale ed economica si riduce a una serie di abitudini da sopravvivenza: il carbone nella stufa, l’alcol, i ricordi, il cibo miserrimo, le visite sporadiche che i due si fanno per vincere la solitudine. Anche i diversivi non sono molto originali e consistono nel ritorno occasionale dell’elettricità, oppure in un soldato morto da seppellire e uno vivo dell’esercito nemico con cui fare conoscenza. Il tutto tra crescenti sospetti reciproci, diffidenze e qualche momento di tensione – smorzato dai bombardamenti che il caso rende occasionalmente vicini o lontani. Questo tempo congelato (è il quarto inverno di guerra) Sergeič lo misura attraverso gli orologi, per i quali ha una predilezione maniacale, mentre per Paška il tempo è lo scorrere dei giorni sul calendario. Entrambi hanno quarantanove anni, ma proprio per effetto del limbo in cui si trovano a vivere, Kurkov ce li fa immaginare per l’intera durata del romanzo come due veri anziani nei loro comportamenti. A differenza di Paška, però, Sergeič dispone di una via di fuga: è da sempre un apicoltore esperto ed esattamente come i suoi animali sa riconoscere le stagioni. Perciò quando il rigore invernale viene meno, la sedentarietà che aveva dominato i giorni e le notti a Malaja Starogradovka inizia a cedere all’idea dello sconfinamento.
Recatosi a barattare il miele con delle uova in un villaggio vicino, Sergeič scopre non solo che lì gli abitanti dispongono costantemente dell’elettricità, ma anche che questa alimenta dei televisori sempre accesi sui canali russi, preferiti a quelli ucraini per la calma serafica con la quale nei dibattiti vengono diffuse le più paranoiche teorie complottiste. La resurrezione primaverile delle sue api spinge Sergeič a portarle al di fuori della zona grigia, verso l’Ucraina continentale. L’intento è banalmente imprenditoriale: aumentare la qualità del miele e quindi il suo prezzo di mercato. È sulle innumerevoli frontiere travestite da checkpoint che l’apicoltore scoprirà progressivamente la sua identità transeunte. La targa dell’auto ne fa immediatamente un “profugo di Doneck” per gli ucraini delle aree libere; la sua lingua, poi, lo rende per molti un potenziale filo-separatista, anche se uno dei segreti di Sergeič è l’amicizia perdurante con un soldato ucraino. La sua origine lo connota addirittura come un “fratello ortodosso” per i russi di Crimea. Ma proprio al confine d’uscita dalla penisola occupata queste contraddizioni raggiungono il parossismo: la polizia russa lo accusa di avere ancora una patente, un libretto e una targa automobilistica di epoca sovietica, quasi fosse un reato, mentre a Malaja Starogradovka per le persone è normale festeggiare ancora tutte le ricorrenze dell’ex SSSR.
Come un moderno Ulisse, anche Sergeič vive un viaggio influenzato da alcune figure femminili: la ex moglie Vitalina, la negoziante ucraina Galja, la tatara di Crimea Ajsylu. Se la prima rappresenta il sogno latente di ricostituire una normalità familiare lontano dal conflitto, la seconda incarna l’aspetto più affettivo di un Paese eroso dal sospetto, che dopo quattro anni vede i profughi del Donbass come dei parassiti scaltri e imboscati, insensibili al patriottismo dei caduti e alla condizione psicologica dei reduci dal fronte. È però nella straordinaria figura di Ajsylu che Kurkov rivela la sua fine maestria, rendendo la donna una sineddoche di quello che è l’aspetto più tragico dell’occupazione russa della Crimea: la repressione della popolazione tatara-musulmana, pianificata dai servizi segreti dell’FSB e condotta attraverso sparizioni, arresti, ricatti di ogni genere. Ajsylu è donna paziente e decisa, orgogliosa e fragile, che sta cercando da anni il marito scomparso e deve riscattare il figlio detenuto, prima che venga arruolato forzatamente nell’esercito russo. Sergeič, dapprima riottoso e sfiduciato, decide di aiutarla, ma non riuscirà ad assurgere al ruolo di eroe risolutivo: ogni tentativo di utilizzare le sue origini, il suo passato e la sua lingua per intercedere con le autorità russe sarà vano, e lo esporrà a sua volta al circuito della ritorsione. L’unico atto coraggioso l’apicoltore lo compirà conducendo in salvo la figlia di Ajsylu, Ajše, attraverso i confini che dalla Crimea portano in Ucraina, per poi affidare la ragazza alle cure della sua ex moglie.
Kurkov decide di concludere la parabola itinerante di Sergeič, e la sua presa di coscienza sulla situazione del Paese oltre Malaja Starogradovka, con toni cinematografici che ricordano lo stile del regista ucraino Serhij Loznycja. In preda a fobie da persecuzione, l’apicoltore fa esplodere con una granata l’arnia a suo dire “contaminata” dalla polizia russa e popolata di misteriose api dal colore grigio. Le api però sopravvivono all’esplosione, perdendo subito lo strano colore infetto agli occhi di Sergeič e ritornando istintivamente verso le compagne delle altre arnie. È questo strano evento che porta l’apicoltore a decidere di ritornare a casa dall’amico Paška, rinunciando a una vita migliore e priva di ristrettezze nel resto del Paese.
Letto con gli occhi della situazione contemporanea e del compimento narrativo di cui parlavamo all’inizio, questo finale appare come una degna rappresentazione ante litteram della condizione della popolazione russofona in Ucraina. Oggetto della massiccia propaganda “di liberazione” da parte di Putin negli ultimi dieci anni e guardata con sospetto dalle frange neofasciste del Paese e dell’esercito, la popolazione dei territori più orientali e meridionali dell’Ucraina allo scoppio della guerra non si è affatto rifugiata in una “zona grigia” di defeliciana memoria, ma ha saputo costruire – come ha ricordato lo stesso Kurkov durante la presentazione di questo libro al Festival di PordenoneLegge – reti di attivismo e solidarietà trasversali, basate su un concetto comunitario delle città e dei villaggi, senza per questo rinunciare a comunicare in una madrelingua divenuta nel frattempo idioma del nemico.