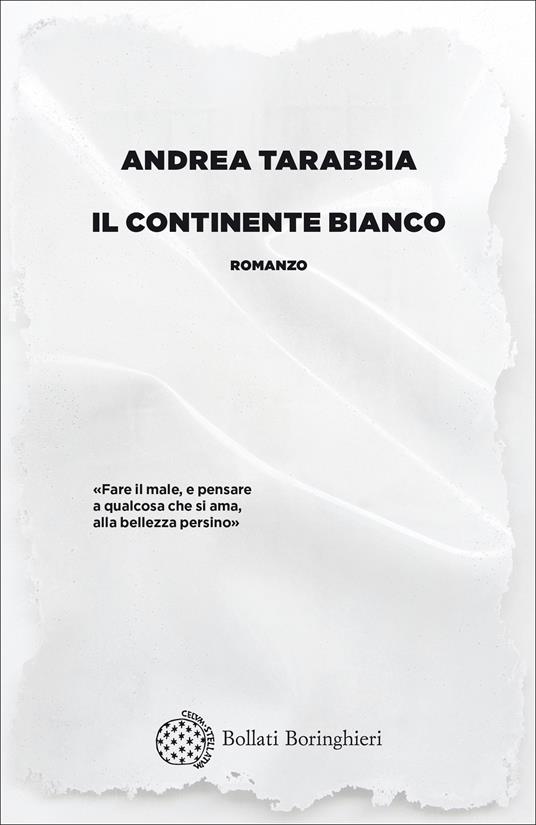Era l’odore della vita, l’odore più profondo essenziale ed unico della vita”: così si legge nell’Odore del sangue (1997), romanzo postumo di Goffredo Parise e riferimento intertestuale più che esplicito per il nuovo romanzo di Andrea Tarabbia. Le trame dei due romanzi, in effetti, hanno molti aspetti in comune, così come è un analogo “odore del sangue”, o anche “della vita”, a impregnare i due testi. “Odore del male”, anche, come forse specificherebbe Tarabbia, la cui scrittura si è andata affinando nel corso degli anni come indagine – sempre di alta qualità letteraria e mai di matrice semplicemente moralistica, o puramente speculativa – proprio sul male, con titoli come Il demone a Beslan (2011) e Madrigale senza suono (2019, vincitore del Premio Campiello).
 Rispetto alle opere precedenti di Tarabbia, Il continente bianco – come già l’Odore del sangue di Parise – sposta l’attenzione sul fascismo post-1945, assecondando quell’interpretazione continuista che, tra i suoi possibili esiti, può arrivare a coincidere con l’affermazione di uno dei personaggi: “l’Italia è uno Stato democratico imposto con la forza a una nazione intimamente fascista”. A dirlo, peraltro, è un personaggio dichiaratamente neofascista, generando con questo una notevole, e assai interessante, ambiguità.
Rispetto alle opere precedenti di Tarabbia, Il continente bianco – come già l’Odore del sangue di Parise – sposta l’attenzione sul fascismo post-1945, assecondando quell’interpretazione continuista che, tra i suoi possibili esiti, può arrivare a coincidere con l’affermazione di uno dei personaggi: “l’Italia è uno Stato democratico imposto con la forza a una nazione intimamente fascista”. A dirlo, peraltro, è un personaggio dichiaratamente neofascista, generando con questo una notevole, e assai interessante, ambiguità.
Il fulcro della narrazione, tuttavia, non è costituito tanto dal contenuto ideologico di questa tesi (variamente riemersa, nel dibattito pubblico, negli ultimi ottant’anni di storia italiana, fino a oggi) quanto dal suo potenziale – infinitamente ambiguo, appunto – di seduzione. In effetti, non sono le idee del fittizio movimento neofascista (“Il continente bianco”) ad attrarre il narratore (chiaramente, per quanto parzialmente, identificabile con l’autore per l’uso dello stesso cognome e per i riferimenti, puntuali, ai libri precedenti), quanto gli aderenti a tale movimento e il commercio che intrattengono, come si diceva, con il male, a più livelli.
Tale seduzione porta in un territorio che non ha a che fare con la perversione – almeno, non con i significati più comuni della parola – se non per l’ispirazione che, velatamente, trae da quell’intreccio tra fascismo e sadismo che si trovava già nel Salò pasoliniano e che viene qui infuso dentro, e ai margini, del più tipico dei menage à trois borghesi. È in quel territorio, al di là del più comune moralismo, che si arriva a lambire una consapevolezza agghiacciante: “che ci possa essere levità, e risa, e gioia, in chi compie qualcosa che per noi è orribile e violento – ecco una cosa che non è tollerabile, che fa più male del male stesso perché dice che la vita, la vita di chi compie il male è, in fondo, nella gioia e nel dolore, non dissimile dalla nostra. O dalla mia”.
Con questa consapevolezza bisogna fare i conti, e non tanto per arrendersi supinamente alla fascinazione del male o per farne motivo di qualunquismo o nichilismo, quanto per iniziare di nuovo, e con più convinzione, a muovere i propri passi, anche politici, decostruendo una particolare retorica che si è andata cristallizzando, nel corso dei decenni, a proposito della Resistenza. Non tanto l’antifascismo o la Resistenza in termini storici, o assoluti, ma quella particolare retorica antifascista e resistenziale post-1945 che si è posta al di fuori e al di sopra di quel conflitto che (giustamente, peraltro) presumeva essere ancora in atto. Al contrario, tra i doveri etici della scrittura, sembra di poter leggere tra le righe di questo libro, c’è quello di guardare il male negli occhi, di cogliere il suo radicamento nelle biografie di personaggi “non dissimili da noi”, e di provare a raccontarlo da una posizione che, pur con tutte le debolezze del caso, resta diversa e divergente.
Un simile impegno etico e politico, infatti, non mette necessariamente al riparo dalla complicità, più o meno desiderata, e tantomeno dal fallimento: il narratore, che è anche il più stereotipico degli scrittori in analisi, vive continuamente con questi spettri e ottiene, infine, di infonderne la paura in chi legge. Fallimento che si ritorce, infine, contro la stessa forma letteraria, arrivando a esibirsi in quanto tale: fallimento non in termini di giudizio di valore, dunque, ma come esito formale dell’opera, che il narratore-Tarabbia ci pone costantemente davanti (anche qui l’eco sembra essere più pasoliniana, ad esempio per la ricerca del cosiddetto “impoetico”, che non legata a Parise). E la domanda è costantemente raddoppiata: contro la continuazione del fascismo, in fondo, si è sempre fallito, o no?
Il fallimento si insinua, allora, nei gangli della narrazione, con un odore che è tanto persistente come quello del male, o della vita. In fondo, è la stessa scelta di campo ricorrendo a un determinato approccio narrativo e tematico a risultare, almeno parzialmente, fallimentare: una narrazione di questo tipo, basata in prima battuta sulla fascinazione del male (fascinazione che pure necessita di essere esplorata a fondo, come si diceva), evidenzia comunque la necessità di un approccio che sia anche, e opportunamente, dialettico rispetto alla questione ideologica che si è intesi lasciare in secondo piano.
In altre parole, il movimento del “Continente bianco” si struttura attraverso alcuni momenti salienti – un determinato discorso culturale e politico, la realizzazione di alcuni atti di violenza nelle periferie urbane, la progettazione di un pogrom, ec. – che riproducono alcuni fenomeni effettivamente importanti di certa storia fascista italiana post-1945. Tuttavia, nel fallimento ricercato dalla narrazione, che necessita costantemente di arrivare sul punto di autoavverarsi, per poi miracolosamente deviare, resta il dubbio che i fenomeni evocati, a partire dalla storia fascista d’Italia post-1945, non siano di per sé decisivi, e nemmeno granché specifici.
Quasi che dietro questa impalcatura narrativa, come una qualsiasi altra che si dia gli stessi obiettivi, si debba fare i conti non con una storia, una politica, una cultura, un’economia particolari, ma, anzi, con quel Fascismo eterno che Umberto Eco pubblicava nello stesso anno dell’Odore del sangue di Parise. All’insegna, quindi, di una critica culturale e politica che oggi non può apparire altro che depotenziata, se si guardano i venticinque anni che sono intercorsi, a partire da quel 1997. No: oggi bisogna muovere i passi indicati da Tarabbia, con inusitata forza espressiva e morale, in questo libro necessariamente impoetico, farlo annusando l’odore del fallimento, e farlo con una certa sollecitudine.