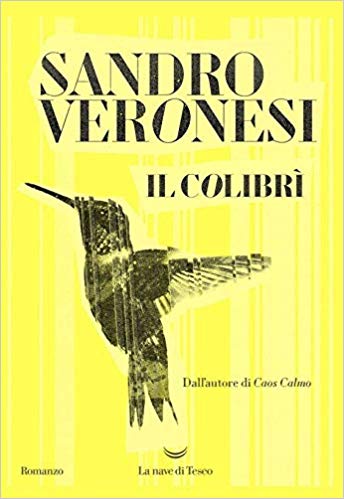Il tempo, con tutta la sua drammaturgica influenza, è al servizio della trama nell’andirivieni fra un anno e l’altro. Ma ripetizioni e digressioni sono opera dell’uomo. Sandro Veronesi forza il tempo ricordando quanto Beckett diceva a proposito di quel che non si può fare e che invece si fa, in opposizione alle più semplici regole della logica. Ma la mente umana è di gran lunga il più esteso mistero della dimensione che abitiamo. In mezzo a questi fenomeni, tanto ordinari quanto può esserlo il cubismo picassiano (quello delle Demoiselles d’Avignon, per intenderci – anno 1907), il protagonista Marco Carrera, il Colibrì del titolo, si veste dei colori adatti allo sfarfallio mirabolante di un uccelletto apiforme. Saldo in un punto, sospeso, in attesa che il senso della vita lo raggiunga nell’intrico di amori e dolori. Il suo stare immobile presuppone un grosso dispendio d’energia, con il conseguente smisurato bisogno di nutrirsi per ogni dove.
Roma e molti altri centri sono le sedi in cui Veronesi situa la schiera di spostamenti, lettere, insidie, fornicazioni (poche), elucubrazioni (tante), fughe e ritorni, a cui assistiamo come fossimo improvvisamente trasportati dentro la scena dalla rivoluzione digitale. Dunque, come si comprenderà, sono vietatissimi riepiloghi e spoiler.
Se in Caos calmo (Bompiani, 2014) la panchina si trasformava in dimora en plein air, nel Colibrì la casa non esiste proprio, ogni personaggio assume le dimensioni di un mondo chiuso in sé, capace di autoalimentarsi e restare integro anno dopo anno nonostante le cose intorno cambino radicalmente. È questo l’effetto del tempo che Veronesi ha avuto la capacità di raccontare incarnandolo in personaggi che eroi non sono, ma nemmeno marionette nelle mani di un Dio scrittore. L’autore non si aggira per le incrociate strade del romanzo, ma appare negli efficaci e attraenti titoli di coda (denominati debiti). Forse la genetica familiare, il DNA, hanno qui la loro influenza, in fondo l’autore dedica il libro al fratello (e sorella) regista.
Il ricordo di Beppe Fenoglio, del suo racconto “Il gorgo” (“il più bello che sia mai stato scritto in lingua italiana”, difficile non essere d’accordo), accresce la dose di simpatia e il sentimento di appartenenza in più di una generazione. Forse le stesse che collezionavano I Romanzi di Urania (curati da Giorgio Monicelli, e poi da Fruttero & Lucentini), inseriti fin da subito nell’epica del romanzo. Del resto lì dentro spira una colonna sonora ben udibile, più che altro pop e rock, e perciò ancora una volta la voce generazionale si fa sentire. Gli anni Settanta hanno ampia influenza nel sistema temporale del Colibrì, senza ombra di autoindulgenza, o di critica sommaria, ma con l’aggiunta di qualche lieve carezza a un “privato” non certo leggendario. La verbosità dei protagonisti di quegli anni qui viene dimensionata al giusto, Veronesi sa come far venire a galla il buono di un’epoca, evitando di occultare lo scadente e il malfatto. Il maldetto, come direbbe sempre il “precettore” Beckett. Se ci sono inferni adulti, e ci sono, non si affermano nei meccanismi della memoria, ma restano fissati ai fatti di un presente che sembra non finire mai. Nonostante l’indicazione di date molto precise, il tempo resta fluido come metallo liquido e velenoso al pari del mercurio. I distacchi e i ritorni intaccano la coscienza e nulla si muove al di là di rituali risaputi.
Il fine di Veronesi ha la struttura tipica del cubismo, s’è detto: in quel caso lo spazio e le forme umane si deformavano sotto l’influsso della materia. Nel romanzo, in più, sono le azioni dei personaggi a piegarsi e avvilupparsi come se Francis Bacon, con la complicità di Picasso, avesse deciso di sceneggiare le loro opere novecentesche. E in questo crogiolo sappiamo bene che, un secolo dopo, c’è ben poco da fare.