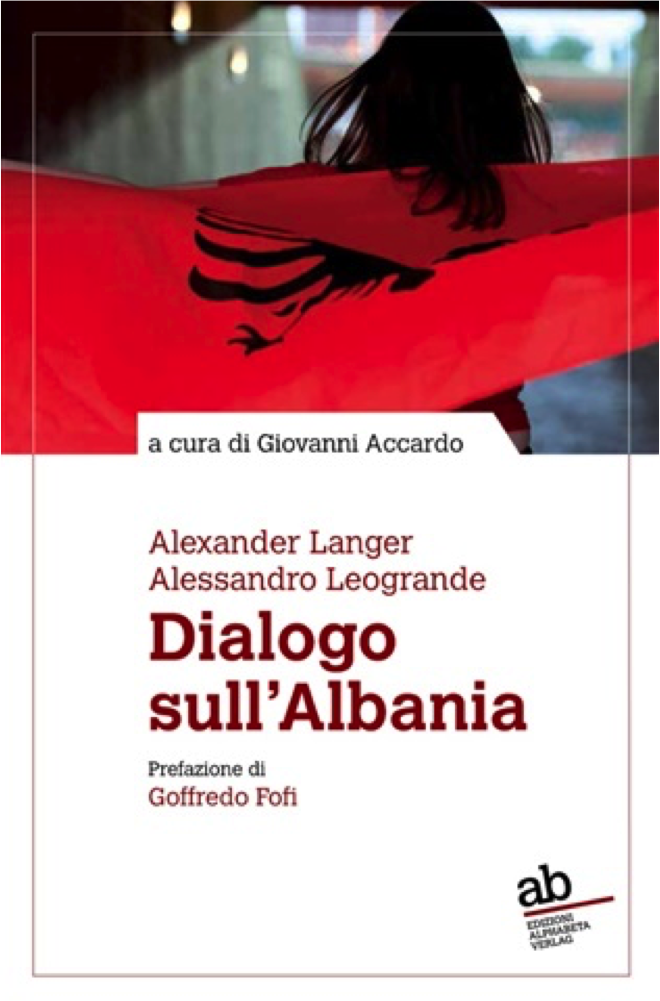Quando due intellettuali si trovano a condividere il nome di battesimo, l’omofonia allitterante dei loro cognomi e in ultimo purtroppo la prematura scomparsa, un riflesso pavloviano (pervaso di empatia) ci porterebbe a rilevarne forzatamente le somiglianze, il parallelismo dei percorsi esistenziali, quindi a tracciarne le affinità come fossero dettagli di un ritratto a matita, eseguito a lume di candela. E quella candela è il senso dell’incompiuto, la dimensione – cristiana troppo cristiana – nella quale siamo soliti collocare chi non può più aiutarci a comprendere l’attualità pulsante del presente, in media res.
Eppure nemmeno in un romanzo ottocentesco potremmo trovare due figure così reciprocamente distanti come quelle di Alexander Langer e di Alessandro Leogrande. Pur legati dal medesimo cordone ombelicale – la tenace volontà di “sporcarsi le mani” in epoche di differente cecità e inerzia del continente europeo – Alexander e Alessandro si pongono quasi agli antipodi intellettuali e narrativi della storia recente del nostro Paese.
Langer è figlio integrale del ’68, delle culture politiche transnazionali e della strenua lotta contro il retaggio dei fili spinati, sui quali fu battezzato il Secolo Breve. Solo un profilo di tale spessore avrebbe potuto – come Alexander ha fatto – coniugare in logica e coerenza il discorso autonomista delle sue terre natìe, con un ardente europeismo di stampo ecologista. Non è un caso, mi permetto di osservare, che la sua scelta suicida sia maturata in una delle estati più tragiche degli ultimi decenni, quella del 1995, quando la nascente Europa decise di abdicare definitivamente a ogni parvenza di diritto umano, accettando che la pax bosniaca fosse dettata dagli ultimi aberranti genocidi etnici.
Leogrande, invece, è cresciuto nel grembo di un capoluogo, Taranto, ostaggio dei veleni dell’Ilva e palcoscenico del fascismo populista meridionale. Ma come molti altri suoi coetanei pugliesi, anche Alessandro ha vissuto, nella prima giovinezza, l’impatto dell’evento che avrebbe fatto da archetipo per ogni migrazione marittima successiva, fino ai giorni nostri: lo sbarco di 20.000 cittadini albanesi nel porto di Bari, l’8 agosto 1991.
Non poteva che essere proprio l’Albania, quindi, il terreno comune di analisi e riflessione diacronica dei due intellettuali. In quello che non mi sento di definire un “dialogo a distanza” ma un vero e proprio confronto serrato.
A determinare questo reciproco interesse vi furono di certo gli innumerevoli legami che la storia millenaria del Paese delle Aquile ha consolidato con le nostre coste: legami che spingevano Alexander Langer, per esempio, a dire che l’Italia avrebbe dovuto considerarsi “l’Albania Occidentale” in misura paragonabile a quanto la Germania ovest fosse parte gemellare di quella dell’est.
Ma in primis pesò il fatto che l’Albania diventò subito e per molti anni – al netto delle comode amnesie e delle rimozioni odierne – la quintessenza stereotipata dell’Altro migrante: dapprima lo straccione, poi il delinquente, il violento, il malavitoso e infine per antonomasia il clandestino.
Quando Alex Langer giunge a Tirana, nel dicembre 1990, con una delegazione di europarlamentari, i suoi bollettini quotidiani per la stampa italiana si concentrano sulle proteste studentesche che stanno bloccando la capitale per sfidare gli ultimi dinosauri del regime di Enver Hoxha (“una rivoluzione generazionale, che è in pieno svolgimento nel Paese più giovane d’Europa” la definisce).
In quei giovani, Langer rivede l’autentica forza simbolica dei cambiamenti novecenteschi, quelli che vanno dalla Primavera di Praga alla sanguinosa protesta di Piazza Tien An Men – che allora era recentissima e vivida.
L’abbattimento delle statue della nomenklatura, la diffusa conoscenza dell’italiano e dell’inglese, il metodo assembleare confusionario, la riconquista dell’agorà e – non ultimo – la precisa volontà di chiedere supporto all’Europa sono gli elementi del movimento studentesco che fanno breccia nell’animo di Alexander.
Il quale, proprio perché immerso in una insurrezione in fieri, tende a sottovalutare la particolarità del suo punto di vista. Anzitutto, quanto sta avvenendo nelle città albanesi sembra non essere l’avanguardia di quanto stanno ruminando le ben più vaste e conservatrici zone rurali del Paese (“forse gli studenti e i giovani, nella loro comprensibile ansia di uscire da un lungo tunnel, hanno pensato più all’Italia e all’Europa che ai loro parenti nei villaggi” ammetterà Langer più in avanti).
In secondo luogo, come spesso accaduto nel passato, la spinta studentesca dei ragazzi trova, nel suo farsi controparte istituzionale, il proprio nemico interno: Langer cita e incontra più volte quel Sali Berisha che, da animoso oppositore del regime e leader del primo “Partito Democratico” in quei giorni di rivolta, diverrà poi il principale responsabile del tracollo economico del Paese sette anni dopo, a causa delle infinite società piramidali (un mix di tribalismo, corruzione e speculazione) da lui stesso patrocinate, proprio con i generosi fondi degli aiuti europei.
Il rapido tramonto di una democratizzazione dal basso e l’inizio delle migrazioni verso l’Italia generano una profonda crisi nelle speranze di Langer: “l’Occidente, dopo aver postulato per loro libertà di espatrio, ora finge di scandalizzarsi quando scopre che gli albanesi non pensavano al turismo quando chiedevano i passaporti… Paradossalmente, proprio ora che si sono conquistati le prime libertà, gli albanesi devono sperare che l’Albania resti così poco democratica da giustificare la loro richiesta [d’asilo politico]”.
Ora al giornalista ed europarlamentare, i cittadini di Tirana chiedono sempre più insistentemente perché l’Italia non mandi via gli immigrati africani per accogliere gli albanesi… Scomparse quindi le tensioni canoniche (studenti contro militari e polizia), l’ultimo decennio del Novecento presenta anche per l’Albania un quadro molto più contraddittorio e meno eroico.
Langer comincia a sentirsi come un Don Chisciotte la cui unica arma diventa l’eurocentrismo paternalistico, a volte ingenuo (“a proposito dei “rifugiati”, non c’è dubbio che la soluzione dei problemi dell’Albania non potrà essere cercata nella disordinata emigrazione di massa”) a volte ferocemente burocratico (“Perché non elaborare programmi di inserimenti organizzati e temporanei per giovani albanesi che in altri Paesi europei vogliano lavorare e studiare, per riportare poi in patria conoscenze e saperi oggi non disponibili?”).
All’inizio dell’estate del 1991, nei giorni in cui lungo le frontiere croate sta per iniziare una guerra immane, Alex Langer scrive l’articolo (profetico) che sarà il canto del cigno della sua visione cooperativa ed europeista nei confronti dell’Albania: una visione completamente schiacciata dal machiavellismo della realpolitik, non solo italiana.
“Di fronte ad alcune centinaia di albanesi che, con le loro zattere, tentano una fuga disperata verso condizioni di vita più accettabili, si reagisce come se ci si trovasse di fronte ad un’invasione nemica… il governo italiano sembra chiedere alle autorità albanesi ciò che sino a pochi mesi fa era considerato sintomo della ferocia di una dittatura: sparare su chi vuole lasciare il proprio Paese”.
Mi sembra davvero superfluo sottolineare l’incredibile, tragica attualità di queste parole.
Alessandro Leogrande ebbe modo di visitare, giovanissimo, l’Albania degli anni ’Novanta grazie ad alcuni progetti di volontariato che videro coinvolto il padre.
Ma il primo reportage vero, approfondito, lo pubblica allo scadere del secolo e del millennio, nel 2000, quando ha appena ventitré anni.
È una fotografia spietata – in bilico tra inchiesta giornalistica e ricerca sociologica – della città di Valona.
“Spietata” in particolare perché Alessandro rigetta completamente quello che fu l’approccio umanistico di Langer: la ricerca del “simile”, delle componenti fortemente simboliche e progressiste della società locale, lascia ora il posto ai dati, alle cifre, alle statistiche e soprattutto alla vera “parte maledetta” del Paese – la criminalità organizzata, esponenzialmente cresciuta nei nove anni di distanza che separano gli articoli dei due autori.
Così, le voci che emergono ora sono quelle degli scafisti che spiegano la logica capitalistica dell’indotto, sulla quale si fonda il loro business (“Con uno scafo mangiano cento persone, non solo chi guida”); le voci degli innumerevoli operai con accento veneto e nomi italianizzati, che non riescono più a bere l’acqua delle fontane dei loro quartieri originari; sono le voci di chi deve chiedere l’autorizzazione ai ras locali o ai clan familiari per usufruire di qualsiasi servizio pubblico, nell’assenza assoluta dello Stato.
“Tolta la cappa del regime, la voglia di ricchezza è diventata l’unica istanza emotiva elevata a religione”, con la felice complicità delle organizzazioni finanziarie come “la Banca Mondiale e il FMI [che] hanno imposto una drastica riduzione della spesa sociale”.
E per suggellare il quadro impietoso, la nuova generazione di giornalisti freelance albanesi , che al contrario dei “vecchi” studenti in rivolta, al giornalista italiano si rivolgono per dire: “voi italiani volete la semplicità: bianco o nero. L’ambiguità che qui permea tutto vi dà fastidio”.
Leogrande, negli scritti degli anni successivi, identifica questa ambiguità in ambito culturale con la figura di Ismail Kadare[1].
Contrariamente alla vulgata che lo aveva incensato per anni come strenuo oppositore del regime di Enver Hoxha, Alessandro dimostra – con prove d’archivio e testimonianze raccolte in loco – che il grande scrittore albanese conservò ogni sorta di privilegio artistico e accademico anche negli anni più feroci delle persecuzioni politiche, quando le prigioni traboccavano di intellettuali accusati di ogni inezia.
Nella sua analisi storico-letteraria, Leogrande riesce a tratteggiare la figura di un intellettuale cortigiano che, giocando abilmente su ogni mutamento di linea e su ogni paranoia del regime, riesce ad apparire “dissidente” agli occhi dei lettori esteri, quanto ortodosso – e anzi, eccessivamente servile – per i cittadini albanesi.
Tanto è vero che l’unico processo politico con abiura finale, Ismail Kadare lo subirà per aver scritto un poema apologetico nel quale Enver Hoxha si sentì però eccessivamente lodato, a scapito del Partito; mentre quella stessa opera, in Europa occidentale fu intesa come un severo attacco al regime dello stesso Hoxha.
“Mai le sue pagine raggiungono la radicalità, la profondità morale e intellettuale di altri scrittori che hanno avuto una biografia più tormentata e si sono maggiormente avvicinati alla narrazione dell’abisso del totalitarismo” – è il giudizio lapidario, netto, del critico e dello storico Leogrande sullo scrittore albanese.
Di straordinaria importanza, oltre che di stretta attualità, sono infine tutti gli articoli che Leogrande scrisse sulla tragedia della “Kater i Rades”, l’imbarcazione albanese affondata dalla corvetta Sibilla della Marina Militare italiana, il 28 marzo 1997 – quando il primo governo di centrosinistra, guidato da Romano Prodi, decise di assecondare le fobie xenofobe della destra istituendo il folle “blocco navale” nell’Adriatico, col fine illusorio di bloccare gli sbarchi.
Ottantuno furono i morti, molti dei quali (donne coi loro bambini) furono recuperati dalla stiva solo diversi mesi dopo.
Alessandro dedicò alla tragedia un intero libro Il Naufragio (Feltrinelli, 2011) e da esso trasse anche un’opera teatrale.

Negli scritti raccolti in questo volume, però, appare fortissimo, il senso di continuità esemplare che Leogrande attribuì a quell’affondamento di stampo bellico. Quasi quella tragedia avesse rappresentato non solo “l’innocenza perduta” del nostro Paese – e della nostra sinistra – ma addirittura un modello, da ripudiare retoricamente per meglio diffonderlo e attuarlo come nei “respingimenti informali” dei richiedenti asilo che in questi mesi arrivano a Trieste dalla Rotta Balcanica e vengono riammessi in Slovenia (e da lì attraverso una catena di violenze documentate riportati con la forza in Croazia e poi in Bosnia). Pratiche informali che ledono ogni diritto sulla protezione individuale e che neanche lo stesso Matteo Salvini aveva messo in opera.
“L’intreccio tra clamore mediatico per le vittime e volontà di continuare a praticare le politiche di respingimento nacque allora. Tale schizofrenia nazionale ci accompagna da oltre sedici anni… In un certo senso Frontex[2] è solo la raffinata evoluzione del brutale “blocco navale”… Nei confronti del caos nordafricano, l’Italia e l’Europa hanno riprodotto su scala più vasta la stessa formula.”
[1] Nato ad Argirocastro nel 1936, Kadare è unanimemente considerato il più grande scrittore albanese vivente. Nel 1990 ha chiesto e ottenuto asilo politico in Francia e ancor oggi vive tra Parigi e Tirana.
[2] Sigla indicante l’agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, cui è affidato il funzionamento del sistema di controllo e gestione delle frontiere esterne dell’UE.