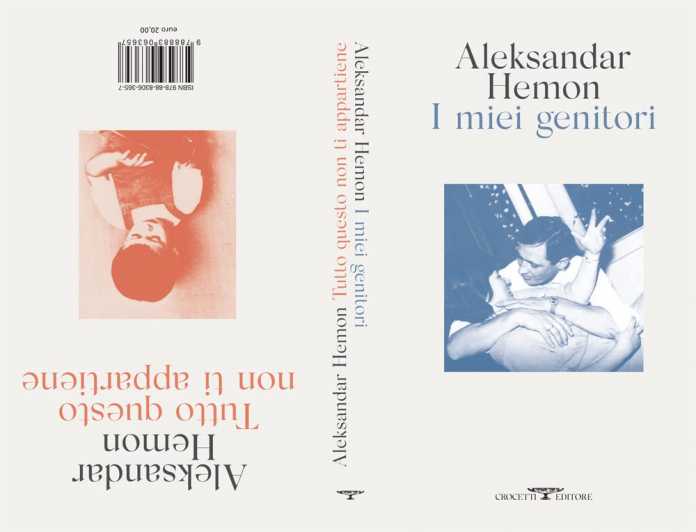Dos à dos già nella confezione editoriale – che ricalca la pubblicazione originale: My Parents. An Introduction / This Does Not Belong to You (2019) – la narrazione memoriale di Aleksandar Hemon si rivela pagina dopo pagina duplice, aperta al rovesciamento, se non anche plurale. C’è un passaggio fondamentale alla base di questo capovolgimento (katastrofa è parola dall’importanza preponderante, nella prima parte) e corrisponde all’attraversamento dell’oceano Atlantico da parte di Hemon e della sua famiglia, a partire da Sarajevo, agli albori della guerra civile jugoslava. Una frammentazione sociale e politica di un mondo già riccamente articolato e un susseguente tentativo di ricomposizione del mosaico che si riflette anche nella pluralità delle vie della memoria; del resto, come si legge ne I miei genitori: “La cultura jugoslava – che in sostanza era fatta di televisione e musica popolare – degli anni Sessanta e Settanta, fino alla morte di Tito, ritraeva persone come i miei genitori, a prescindere dalle origini etniche. Accendevano la tv e vedevano sé stessi, interpretati da attori famosi che si chiamavano tra loro compagni e facevano le stesse loro battute sulle donne che spettegolano, sugli uomini che non riescono a trovare i calzini e sulle suocere bifolche che arrivano in visita con enormi vasi di puzzolentissima verza in salamoia. La Jugoslavia era un universo discorsivo, se si vuole”.
Raccontare la propria storia famigliare diviene dunque l’occasione di inglobare quell’universo discorsivo in un altro, esplorando i limiti di ciascun “mondo”. E di limiti si legge varie volte in Tutto questo non ti appartiene, dove la disappartenenza segna, in primo luogo, i ricordi dell’adolescenza che l’autore ha passato a Sarajevo negli anni Settanta, e non soltanto – come si potrebbe prevedere in una lettura più superficiale – l’esperienza della migrazione e dei nuovi radicamenti oltreoceano.
Quest’ultima, tra l’altro, non è l’unica esperienza di migrazione della famiglia Hemon, come lo scrittore puntualizza mentre scava sempre più a fondo nella dimensione psichica e culturale – a lui nota, o da lui immaginata, dei suoi genitori – trovando “un’identità irriducibile e incredibilmente ricca radicata in patrie concentriche”. Nei cerchi concentrici disegnati dalla memoria paterna, Hemon trova l’eredità culturale della sua genealogia ucraina: nel melting pot che, prima che in Nordamerica, si trovava già in Bosnia, poi irrimediabilmente dilaniata dalla guerra civile jugoslava, era presente un nutrito gruppo di discendenza ucraina. E tale memoria si rende visibile, e soprattutto udibile, attraverso la pratica dei canti popolari, dei quali il padre si fa appassionato portatore. A ciò si giustappone il contraltare materno, con la sua formazione nel periodo del socialismo jugoslavo che la porta a “deplora[re] ogni sentimentalismo nazionalista, incluso quello ucraino”, senza però farne ragione di Stato in seno alla famiglia.
 Anche la memoria di Hemon, dunque, e la sua narrazione si fa concentrica, avendo a che fare con una dimensione più spaziale che temporale: d’altronde, è convinto che in ogni esilio, fuga o migrazione “il tempo non lo si recupera, ma lo spazio sì”, in una riacquisizione territoriale basata sulla “proprietà” – con evidente riferimento critico al portato della cultura socialista, della quale si nega dunque qualsiasi forma di nostalgia, oggi conosciuta anche come “jugo-nostalgia” – e sulla ridefinizione dei nuovi spazi nei quali ci si trova a vivere.
Anche la memoria di Hemon, dunque, e la sua narrazione si fa concentrica, avendo a che fare con una dimensione più spaziale che temporale: d’altronde, è convinto che in ogni esilio, fuga o migrazione “il tempo non lo si recupera, ma lo spazio sì”, in una riacquisizione territoriale basata sulla “proprietà” – con evidente riferimento critico al portato della cultura socialista, della quale si nega dunque qualsiasi forma di nostalgia, oggi conosciuta anche come “jugo-nostalgia” – e sulla ridefinizione dei nuovi spazi nei quali ci si trova a vivere.
La preminenza del dato spaziale su quello temporale collima con un altro dato fondamentale della scrittura di Hemon, ossia con il fatto che “la vera storia può dispiegarsi soltanto a livello personale”, vivendo continuamente la crisi e la conseguente katastrofa nella propria carne e nella propria psiche. Non c’è Storia, per meglio dire, nella narrazione, perennemente attenta a demistificare le appropriazioni ideologiche; tuttavia, occorre seguire fino in fondo il ragionamento, in questo caso, per non restare appiattiti su valori esclusivamente liberali dell’argomentazione. E dunque: “Niente, però, è inevitabile finché non accade. Il destino storico non esiste. Non c’è altro che lotta”.
Dalla lotta non bisogna desistere, così come non si può rinunciare all’occupazione di nuovi spazi, siano essi materiali o immaginari. Su un altro livello, ma inevitabilmente collegato, infatti, la limitazione degli spazi coincide con la morte: “La riduzione del campo della vita: ecco cos’è il morire. Un processo che si conclude quando il campo si restringe a una fossa”.
La prima e principale strategia messa in campo da Hemon per contrastare questa progressiva diminuzione del mondo è l’espansione in cerchi concentrici della narrazione, e ancor di più quella “complicazione” che già si leggeva nel Libro delle mie vite (2013): opera precedente che già giocava con i territori dell’autobiografia e dell’autofiction esplorandone i limiti, e con estrema utilità, in un’epoca di espansione ipertrofica dei due generi. Complicazione che l’approccio intellettuale complesso – però mai sofisticato o retorico – dell’autore rende in modo esatto, ma che la traduzione di Pannofino contribuisce a definire in modo ancora più incisivo, lasciando fra parentesi tutti quei lemmi e sintagmi della varietà bosniaca del serbo-croato, e ancor più precisamente dell’idioletto di casa Hemon, che, proprio come katastrofa, danno un’esatta percezione del posizionamento translinguistico del suo universo discorsivo. Una definizione che, come in molti casi di esilio, fuga o migrazione raccontati nella grande letteratura del Novecento e contemporanea, avviene per progressivo straniamento, rispetto alla memoria, e anche a tutto quello che, in fondo, non ci appartiene.