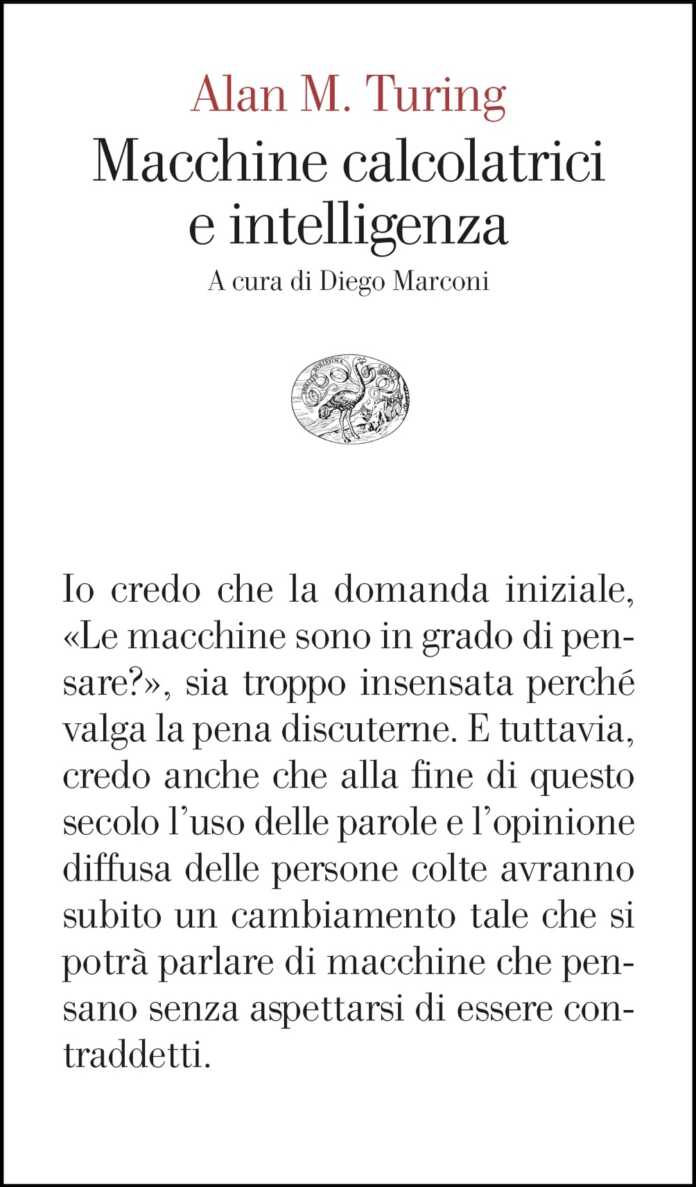Poi certo, se durante le trasmissioni culturali, dal primo sguardo di un sapiens (o chissà di quale altro progenitore) alle attuali incursioni di AI nel nostro quotidiano, qualche manciata di neuroni si inselvatichisse, potremmo provare a rispondere alla fatidica domanda di Alan Turing: “Le macchine sono in grado di pensare?”. Domanda che, con ironica nonchalance, il geniale matematico inglese butta lì all’inizio di questo saggio che venne pubblicato nel 1950 su una iconica rivista di filosofia britannica. Scelta fuorviante, ma d’altra parte il testo (splendidamente oggi curato da Diego Marconi) non tratta di logica e matematica in senso stretto. Intervenire nei campi battuti da Popper e Polanyi era un azzardo, questo è sicuro, ma perché una rivista come “Mind” accettò un articolo alquanto discorsivo, e diciamo ben poco “accademico”? Turing, ci spiega Marconi, era considerato – oltre che insigne logico matematico – una specie di eroe per aver contribuito alla decifrazione di Enigma, il codice utilizzato dai nazisti per inviare messaggi criptati. La sconfitta dell’Asse, unita alle montagne russe di esperimenti mentali dovuti a personaggi come Russell, Wittgenstein, Von Neumann, e lo stesso Turing, trasportava in un batter d’occhio l’intelligenza umana dalla manualità calcolatrice babilonese di 2000 anni prima alle speculazioni di Pascal e Leibniz, ai teoremi di Gödel. Le macchine “non fisiche” di Turing si espressero invece, seguendo sistemi strategici e necessità epocali, in urgenti sistemi difensivi della cosiddetta civiltà. Turing disse, nel 1946, che di lì a trent’anni forse sarebbe stato facile fare una domanda alla macchina come farla a una persona.
La quantità di notizie, dati, e ragionamenti, a cui si va incontro leggendo questo aureo libretto dovrebbe indurre promotori e avversari di AI a ricominciare da capo, a cercare soluzioni ben oltre gli attuali campi, senza sentirsi svaligiare la mente dalla svolta politica planetaria a cui stiamo assistendo. Le analogie fra la macchina di Turing universale, realizzata fisicamente, e il cervello umano, portano molto lontano, e s’intersecano con somme questioni di natura “sociale”, prova ne sia la catastrofe personale di Alan. Omosessualità: un reato nella Gran Bretagna del 1952. Conseguente trattamento “terapeutico” che ricorda quello a cui fu costretto Alex in A Clockwork Orange di Stanley Kubrick (Arancia meccanica, 1971), tratto dal romanzo scritto da Anthony Burgess nel 1962. Se oggi non fossimo piombati in una specie di distopia dickiana (al netto di quanto si possa pensare di questo scrittore morto e risorto varie volte nell’attenzione letteraria, e non solo, durante il cambio di millennio), la commistione tra vita privata e ricerca scientifica alimenterebbe soltanto il gossip di riviste scandalistiche. Attualmente però le distorsioni “social”, trumpiane, governative illiberali, e l’uso infantile (ma non troppo) di ChatGPT, fanno temere il peggio. Disciplina, iniziativa: alla definizione di questi termini si va incontro leggendo il saggio seminale di Turing, l’incapacità (o il suo contrario) di macchine e umani dipendono dal loro funzionamento come macchina di Turing universale. C’è qualcosa di misterioso e perturbante in un simile approccio. Il comportarsi dei dispositivi elettronici potrebbe essere rappresentato da comunicazioni di quasi impossibile accesso. Il “senso umano” su cui pone l’accento il curatore al termine di questo libro dovrebbe allargarsi al senso delle macchine: in fondo la teoria dell’aerodinamica spiega il volo degli uccelli e degli aeroplani. Ma ricordiamo sempre che Turing, dall’universo dei suoi scritti e delle sue realizzazioni, osserva e analizza quanto proprio in queste settimane accade sotto lo strato sottile dell’atmosfera terrestre. Umani che non si vedono dallo spazio si vedono fin troppo al suolo: e parte di essi non possono che preoccuparsi.