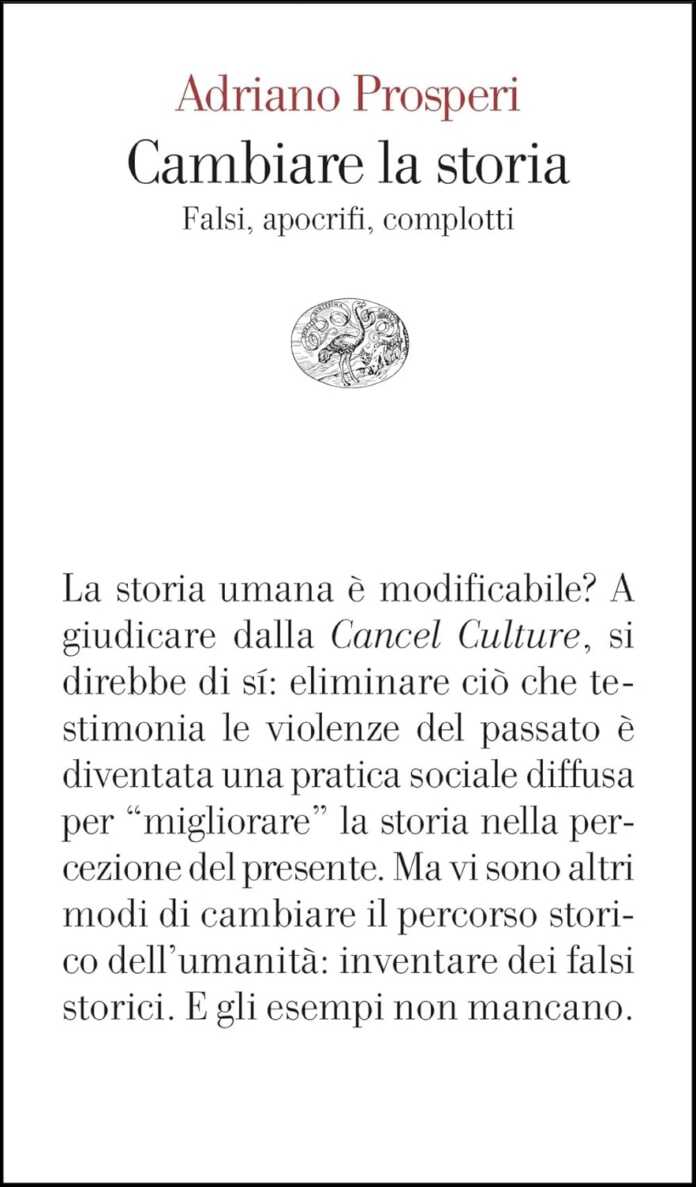“La storia umana è modificabile?”. Attorno a questa domanda ruota lo studio di Adriano Prosperi, Cambiare la storia. Falsi, apocrifi, complotti, edito da Einaudi. La premessa che funge da indicazione metodologica parte da una constatazione: a uno storico si chiede «la verità, nient’altro che la verità»; la quale, però, «deve fare i conti con la consapevolezza della soggettività di ogni conoscenza». L’itinerario teorico muove dal filosofo greco Pirrone, al poeta tragico Agatone, ad Aristotele, a Pierre Bayle, allo storicismo ottocentesco, sino ad approdare all’insegnamento ineludibile di Marc Bloch, che dedicò un fondamentale saggio alla falsificazione (Riflessioni d’uno storico sulle false notizie della guerra), dove codificò un concetto seguito dall’autore: ogni narrazione storica è influenzata da contesti socio-politici e culturali, e una notizia non vera «nasce sempre da rappresentazioni collettive che preesistono alla sua nascita».
In un’epoca come l’odierna, in cui il falso e il finto hanno assunto una dimensione drammaticamente ipertrofica, risuona imprescindibile il monito di Aristotele: «Non si delibera sul passato, ma sul futuro e sul contingente, mentre il passato non può non essere stato». Tuttavia, l’irrimediabilità di ciò che è stato – ci fa riflettere l’autore – si scontra con il desiderio di emendare il trascorso di vite individuali o di periodi storici, «un sentimento che attraversa senza sosta gli esseri umani sia come individui sia come testimoni e narratori del passato». Viene così a fuoco il bersaglio polemico: la cosiddetta cancel culture, per la quale l’immoralità, l’intollerabilità di alcuni eventi storici non è dicibile – va cancellata, letteralmente. Con perturbanti risultati: «Non siamo davanti al mutamento della storia intesa come lo scorrere del tempo umano, ma al tentativo di correggerne epoche intere e di modificare e censurarne eventi e protagonisti», in tal modo «modificando nelle menti il corso degli eventi». E il loro significato.
A interessare Prosperi è soprattutto il rapporto tra le intenzioni dei falsari e gli esiti delle loro creazioni, ciò che egli definisce «l’effetto risonanza della distorsione introdotta dal falso sulla percezione del passato». Su tale terreno cerca di “compiere una verifica”, selezionando, nei quattro densi capitoli di cui si compone il volume, altrettanti notissimi casi di contraffazioni, a cominciare dal “falso dei falsi, madre di tutti i falsi” (Germana Gandino), cioè la Donazione di Costantino. La domanda da porsi, in questo come negli altri esempi, è: «Fino a che punto il falso ha contribuito a modificare il processo storico?». Con dovizia bibliografica, se ne documenta nascita, fortuna e smascheramento, soffermandosi appunto sugli esiti, tra cui si segnala il passaggio dal diritto canonico e dalla teologia “all’esercizio della critica storica sulla base della filologia” nata con Lorenzo Valla e gli umanisti, che proposero un nuovo metodo per accertare l’autenticità di una fonte.
La seconda sezione analizza i falsi realizzati dal dotto frate domenicano Annio da Viterbo, definito dallo storico Paolo Preto “il più sfacciato falsario di epigrafi della prima età moderna” (ma a cui pure si deve la fondazione dell’etruscologia), che sul finire del Quattrocento confezionò reperti archeologici etruschi, iscrizioni greche e latine, in un disegno volto a esaltare il suo luogo natio al di sopra della stessa Roma. Anche qui si ricostruisce il contesto, la fame di “antiquitates” (narrazioni storiche che offrono una descrizione sistematica delle conoscenze sulla vita degli antichi) tipica del tempo, e l’aperta polemica con la storiografia umanistica che mosse Annio, nel tentativo di ricondurre in mani religiose la memoria scritta degli eventi passati.
Il terzo capitolo affronta i cosiddetti falsi del Sacromonte, fatti accaduti tra il marzo 1588 e il maggio 1599 in Spagna, alla periferia della città di Granada, dove vennero rinvenute strane e insolite testimonianze. I falsari produssero prove ingegnose di una originaria comunità di mori cristiani risalente alla prima predicazione evangelica, con tanto di protovescovo (San Cecilio), oggetti sacri, pergamene contenenti profezie e vite di santi, “un lavoro complesso dove è riconoscibile il modello anniano”. Con tali falsi i moriscos (mori convertiti al cristianesimo, rimasti nell’antico sultanato di Granada) cercavano di risollevare la propria condizione nella società spagnola del XVI secolo, dotandosi di un passato mitico che ne alleggerisse lo stato di inferiorità. Anche qui è illuminante il contesto: l’imposizione ai musulmani residenti in Spagna di convertirsi al cristianesimo o lasciare il paese, la Prammatica sanzione che nel 1567 soppresse le libertà religiose e culturali dei moreschi di Granada e la conseguente rivolta dell’Alpujarra, domata nel 1571. Ma gli esiti di tali artefatti tracimarono le intenzioni di chi li creò, poiché la scoperta di testi e reliquie di una primigenia cristianità araba in Spagna, in cui dominava la figura di una Vergine santa dalla purezza incontaminata, rinfocolò una questione teologica spinosissima che si protrasse per quasi un secolo, su cui guerreggiarono i due fronti tradizionalmente contrapposti sulla questione della dottrina dell’Immacolata Concezione: da un lato gli antichi oppositori, i domenicani, dall’altro i francescani e buona parte dei gesuiti. Nella vicenda si giocava una partita decisiva per il rapporto tra le autorità centrali della Chiesa romana e la monarchia di Spagna, tra l’Inquisizione romana e quella spagnola, tra il papato e i vescovi iberici. È un classico caso di eterogenesi dei fini: «La tempesta religiosa fece dimenticare il contenuto e l’origine dei reperti», l’esito di quei falsi fu l’esatto contrario delle intenzioni che ne avevano mosso la creazione, poiché tra il 1609 e il 1614 la quasi totalità dei moriscos (sui 350.000) furono caricati sulle navi ed espulsi dalla Spagna.
L’ultimo esempio affronta infine uno dei più noti casi di falsificazione documentaria, i Protocolli dei Savi anziani di Sion, che volevano attestare il programma di una fantomatica organizzazione ebraica mirante a sovvertire gli assetti sociali e politici esistenti per sostituirvi un potere ebraico. Stavolta il falso è un libro, che ha avuto un incalcolabile numero di edizioni, il contesto è quello dell’antisemitismo francese e russo di fine Ottocento, pregno di torbide speculazioni visionarie e millenaristiche, ma anche di quello “fiammeggiante” di cui dava prova la Chiesa di Roma, in particolare con la rivista dei gesuiti, “La Civiltà Cattolica”. È il periodo in cui «avvenne il passaggio dall’antigiudaismo cristiano all’antisemitismo come ideologia della differenza ebraica di sangue e di razza», e l’efficacia del falso «è stata del tutto indipendente dalla fede nella sua autenticità»: pur scoperto (piuttosto presto) ha seguitato a produrre effetti nefasti, creando il concetto di “veridico” (pur non autentico, verosimile), dimostrando “l’impermeabilità di una costruzione mitologica alle critiche razionali” (Pierre-André Taguieff) e chiamando in causa le psicopatologie collettive: nelle mani del nazismo e del clericofascismo italiano i Protocolli divennero micidiale strumento di morte.
Dunque, l’alterazione della storia non è un gioco, ma «cosa molto seria e dalle gravi conseguenze», alle sue origini c’è «quel terreno di coltura favorevole che bisogna cercare di cogliere e di interpretare». Ma la comprensione critica del passato, quindi del presente, non è compito agevole, e l’odierna tendenza della cancel culture impoverisce il nostro patrimonio culturale rischiando di creare una generazione priva di consapevolezza storica. Il vero e il falso sono intrecciati, e, nelle parole di Carlo Ginzburg qui citate, il mestiere dello storico è «qualcosa che è parte della vita di tutti: districare l’intreccio di vero, falso e finto che è la trama del nostro stare al mondo». È un appello alla responsabilità individuale e collettiva, alla capacità di decifrare subdole forme di dispotismo mascherate da democrazia, se non si vuole vivere in una società dell’oblio e precipitare in una barbarie senza ritorno.