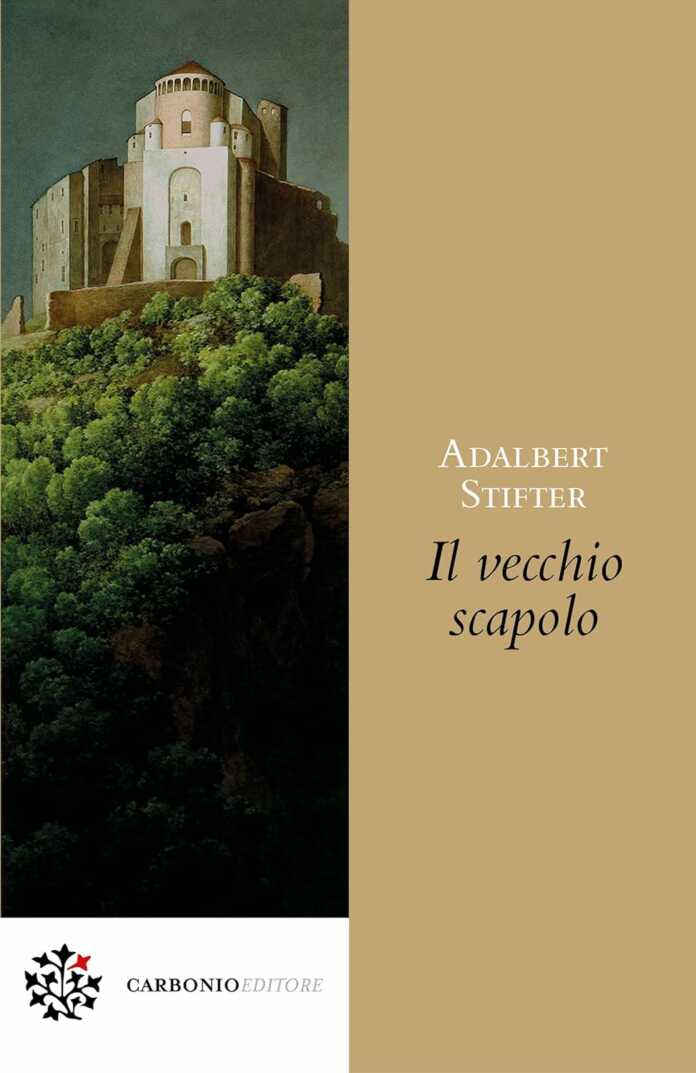Adalbert Stifter (1805-1868) fu ammirato da Nietzsche e Thomas Mann (quest’ultimo, in particolare, insiste sul senso demoniaco della scrittura stifteriana, sulla “inclinazione verso l’eccessivo, l’elementare-catastrofico, il patologico” della sua prosa), eppure lo fu in nome di ciò che sembrava nascondere più che di ciò che sembrava dire, e in effetti i riflessi enigmatici dell’opera dell’autore austriaco si insinuano sotto la superficie ostentatamente limpida e serena del mondo rappresentato, scavano sotto le sue certezze e lo minano nel profondo. Quando scriveva, Stifter era già inattuale. Un classico fuori tempo che, mentre il mondo intorno, l’Ottocento mediano, marciava a grandi passi verso i trionfi della scienza, della tecnica, della velocità e dell’incessante cambiamento, si arrestava alle soglie del progresso, guardava all’indietro, si soffermava sui particolari più minuziosi della natura e di un’anima umana considerata come immutabile, scavando nell’immobilità cristallina dei quarzi e delle pietre, nei paesaggi di natura dei quali l’autore austriaco era maestro, fatti di selve impenetrabili, popolati di ombre o congelati nei “boschi nevosi” e “gli alberi coperti di brina” di Cristallo di rocca, uno dei suoi racconti più famosi.
Sospeso nella dimensione mitica, quasi astratta delle sue storie, proprio per la sua inattualità Stifter non ha mai smesso di essere attuale. Ne è la prova questo Vecchio scapolo (1844 e 1850), riproposto da Carbonio nell’elegante traduzione di Margherita Carbonaro che ne rende al meglio la prosa raffinata, densa, arcaicizzante. Particolarmente memorabili sono gli incipit di Stifter, solenni sentenze tese a stabilire leggi ancestrali che con enigmatica inesorabilità si riverberano nella modernità, riflessioni di carattere universale desunte dai casi della vita e a essi riapplicate, tese a introdurre i motivi delle storie e a preannunciarne i significati, dalle quali derivano anticipazioni che sono autentiche conclusioni e suggelli, unico spazio del testo al quale l’autore delega la propria voce. Segue poi l’esecuzione narrativa vera e propria che si avvolge inesorabile e uniforme a quel primo postulato con lente spirali e attraverso i suoi accumuli dovrebbe trasformare il processo di scrittura in una dimostrazione matematica. Così è per la premessa che sancisce “la catena delle cause e degli effetti” in uno dei racconti più esemplari dell’autore austriaco, Abdias (1843 e 1847), così in un’altra celebre narrazione contenuta in Studien, Brigitta (1843 e 1846), in cui si ha la denuncia introduttiva e programmatica della drammatica scissione dell’animo umano tra regioni rischiarate dalla luce della consapevolezza e altre in cui la ragione non è capace di penetrare.
Non fa eccezione nemmeno questo Vecchio scapolo, in cui il richiamo a un’immagine naturale (ma dalla chiara origine evangelica) nutre una riflessione sull’apparente inutilità di certi destini umani che, tuttavia, per vie imperscrutabili, possono comunque germogliare e dare frutto, trovando in questo modo una ricompensa, per quanto impersonale e poco consolatoria:
«L’albero di fico che non dà frutto viene sradicato e gettato nel fuoco. Se il giardiniere però è benigno e gentile, ogni primavera attende che la chioma rinverdisca e la aiuta a rinverdire ogni primavera, finché le foglie diventano sempre più rade e alla fine solo i rami scarni si tendono verso il cielo. Allora l’albero viene rimosso ed ecco che il suo posto nel giardino è scomparso. Gli altri mille rami e i milioni di foglie continuano a verdeggiare e a esultare, e nessuno dice: “Sono germogliato dai suoi semi, e come lui porterò anch’io dolci frutti”. Il sole splende sempre amichevole, il cielo azzurro sorride da un millennio all’altro, la terra indossa il suo antico verde e le stirpi discendono la loro lunga catena fino alle più recenti; ma lui solo è davvero estirpato, perso per l’eternità; la sua esistenza non ha lasciato infatti alcuna immagine e le sue tracce non fluiscono insieme alla corrente del tempo».
Da tale premessa scaturisce una storia che in parte asseconda l’assunto iniziale, in parte lo contraddice, ed è questa dinamica interna a costituire il tratto portante di una narrazione che si sviluppa per movimenti minimali, per piccoli scarti che alludono a profondità insondabili, a forze oscure che la costruzione e l’articolazione della vita civile tentano di sospingere ai margini della coscienza e rivelano la fede in una legge segreta delle cose, riflesso di un’anima profonda che tutte le collega e contrasta con la loro prosaica immagine di superficie, l’unica che l’occhio è capace di cogliere. Ma la narrativa di Stifter va oltre l’occhio e in lui, che fu anche pittore, affiorano sì la selezione e la sublimazione che sono al centro della scuola figurativa realista, tesa alla ricerca dell’oggettività: ma nei suoi racconti tale procedimento è finalizzato a un progetto inverso, ovvero a un rifiuto della modernità che si realizza attraverso una calata nell’arcaico e nel simbolico, e che finisce per essere, quasi suo malgrado, una delle radiografie più significative della modernità stessa.
In tal senso, un ulteriore elemento di interesse di questo volume è la scelta di Carbonaro di offrire ai lettori italiani la prima versione del Vecchio scapolo: Stifter era solito ritornare più volte sui propri scritti, apportando cambiamenti talvolta radicali, in un perfezionismo alla Flaubert (e in fondo il suo romanzo Die Mappe meines Urgroßvaters, 1841, con le sue pagine piene di “cianfrusaglie” accostate l’una all’altra alla rinfusa, ricorda Bouvard et Pecuchet), ma nel caso di questo racconto, come ci informa la traduttrice nella sua nota introduttiva, l’edizione in volume del racconto, uscito nella raccolta Studien nel 1850, va in una direzione molto normalizzante (e molto stifteriana), sfrondando la prima stesura, che risale al 1844, dagli echi di una contemporaneità alla quale l’autore voleva sottrarsi, e che invece, nonostante tutti gli argini e le dighe, è implicita nella storia stessa, nel confronto generazionale che la anima. Significativa in tal senso è la presenza della ferrovia in questa prima versione, assente invece nella seconda e definitiva: sintomo della polarità intorno alla quale ruotano le costruzioni dell’autore austriaco, il gioco dell’immobile cui sembra consegnato il suo mondo e del mobile che lo segna sotto le apparenze. Su quei treni Stifter non salì con la propria opera: e tuttavia ne sentì il rombo e il fischio, e trovò nella scissione tra la tentazione di assecondare l’onda ruggente del progresso e il desiderio di sottrarsi a essa la sua particolare dimensione di scrittore, fondata sull’atemporalità della malinconia.