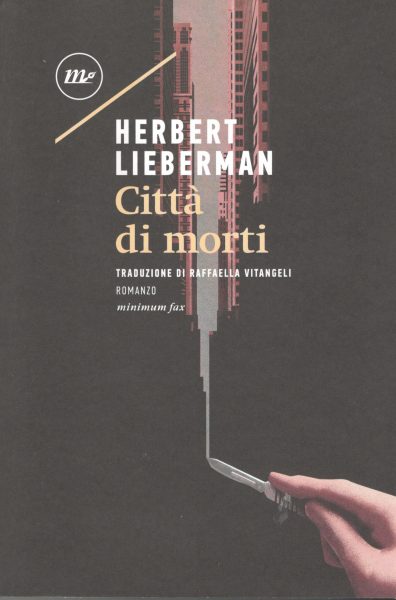Lo ammetto: mi è capitato spesso di biasimare l’editoria italiana per le sue incomprensibili distrazioni, per autori di lingua inglese (e non solo) tradotti tardi, o mai tradotti, fuori stampa, dimenticati, non valorizzati; per scrittori italiani inspiegabilmente finiti in soffitta o in cantina. Dietro queste sviste ci saranno anche politiche di marketing, la caccia al best-seller a tutti i costi, però uno spesso sospetta che ci sia semplicemente mancanza di professionalità – un male che affligge la nostra editoria non da ieri. Stavolta però, se dovessi lanciarmi nell’invettiva, dovrei prendermela anche con gli americani, e chiedergli: ma non vi siete accorti di Città di morti? Ma a cosa stavate pensando?
Il romanzo risale al 1976: quarantadue anni fa. In Italia non è stato mai tradotto. Negli Stati Uniti si trova solo in ebook, pubblicato da Open Road Media, che non è certo una major. E se non ve lo volete leggere su Kindle Kobo o altri dispositivi, vi dovrete comprare l’edizione originale a stampa di Simon & Schuster, ovviamente usata. In altri termini, questo massiccio thriller metropolitano, al confine con il puro horror (genere peraltro spesso praticato da Lieberman), a casa sua non ha avuto un gran successo – anzi, diciamo che non ne ha avuto affatto. Gli unici ad apprezzarlo sono stati i francesi, che gli assegnarono nientemeno che il Grand prix de littérature policière. Ma si sa che i nostri cugini hanno sempre fatto attenzione a quegli scrittori americani anomali che in patria non venivano compresi: vedi l’amore di Baudelaire per E.A. Poe, o l’apprezzamento di Baudrillard per Philip K. Dick.
Sgombriamo subito il campo da eventuali fraintendimenti: se Città di morti è stato ignorato non è per sue mancanze. Non mi considero un gran lettore di gialli, eppure questo corposo volume l’ho letto in meno di due giorni. Semplicemente, una volta che cominci non puoi smettere di leggere la triste vicenda dell’anatomo-patologo Paul Konig, impegnato in una difficile indagine e a combattere una guerra sporca nell’ufficio che dirige (un po’ troppi ambiscono alla sua carica di medico legale capo di New York City), proprio mentre un gruppo terroristico ha sequestrato sua figlia Lolly (la quale è oltre tutto in pessimi rapporti col padre, uomo dal carattere tutt’altro che facile).
Qualcuno si chiederà: ma come, un forensic thriller che non ha avuto successo? Ma se Patricia Cornwell è diventata ricca con le imprese della sua medical examiner Kay Scarpetta? Ma se in televisione c’è una folla di coroner che affettano cadaveri, analizzano tessuti, segano ossa, esaminano cellule al microscopio elettronico, campionano DNA e infallibilmente ricostruiscono delitti dalla meccanica bizantina e smascherano il colpevole senz’ombra di dubbio? Certo, la realtà (specie italiana) è un’altra faccenda, con tutto il DNA non si sgarbugliano sempre le matasse, però di fatto la gente sembra essere impazzita per queste storie in cui cadaveri in condizioni spaventose vengono smontati e rimontati, e alla fine si arriva alla verità, tra frattaglie e fluidi corporei un tempo innominabili.
Eppure è così. Quello di Lieberman è un solidissimo forensic thriller, ricco di dettagli ripugnanti (confesso che in certe pagine un po’ mi sono sentito a disagio), e l’indagine verte su una sfida pressoché impossibile, identificare dei cadaveri (non si capisce neanche bene quanti) fatti non a pezzi ma a pezzetti, e restati in acqua marina per ore, salme sulle quali l’assassino s’è metodicamente accanito proprio con la precisa intenzione di rendere il lavoro impossibile all’anatomo-patologo. Dovrebbe essere il romanzo che vende mezzo milione di copie tanto per cominciare.
Inoltre Lieberman scrive con grande tecnica e di tanto in tanto si lascia andare (anche solo per mezza pagina o poco più) a momenti genuinamente lirici, ben resi dalla solida traduzione di Raffaella Vitangeli (che deve aver faticato non poco con tutta la terminologia medico-legale, che costituisce una sorta di poesia della morte serpeggiante in tutto il testo). Il suo personaggio principale, Konig, è una sorta di ossesso del proprio lavoro, una specie di folle monarca del suo ufficio, nonché un tiranno insensibile in famiglia, però è anche il miglior anatomo-patologo in circolazione, e quindi da un lato ci sono gli echi del Re Lear shakespeariano (espliciti e insistiti), dall’altro non si può non pensare all’Achab di Melville (che comunque, per pazzo che fosse, era il miglior cacciatore di balene di tutti i tempi). Insomma, il romanzo ha un considerevole spessore letterario che lo avrebbe dovuto fare apprezzare anche ai lettori più sofisticati.
Diciamo pure che Konig è una figura talmente monumentale da occupare pienamente la scena. Al tempo stesso geniale e disumano, eppure a tratti troppo umano, del medico legale capo pian piano scopriamo tutta la storia, tutta la vita con grandi successi professionali e clamorosi disastri affettivi. Uomo rispettato e quasi temuto, Konig non è amato, anche se ispira una strana forma di masochistica fedeltà agli altri anatomo-patologi del suo ufficio (ma scatena anche la rivalità e la subdola rivolta di alcuni suoi sottoposti) e ai due poliziotti della vicenda, il proletario Flynn e l’intellettuale Haggard, nonostante li bistratti spesso e volentieri. Una figura greater than life, Konig ricorda un po’ certi personaggi dei film di Orson Welles, ma anche della storia americana: eroi alienati e solitari, alla fine emarginati dalla stessa società che hanno beneficiato.
Infine c’è New York. C’è poco da fare, con una città come quella come ambientazione, uno scrittore dotato come Lieberman non dovrebbe poter fallire. La grande mela, si sa, a momenti si racconta da sé: non è solo una megalopoli, è anche un enorme groviglio di narrazioni, dalla storia certo più breve di quella di Roma o di Londra, però già monumentale (andate a leggere Gotham e Greater Gotham, di Burrows & Wallace, che con due tomi dello spessore di un elenco telefonico si sono fermati al 1919). Lieberman naviga tra i cinque boroughs (più qualche scena extraurbana, sulle rive dell’Hudson) dimostrando di conoscere bene la città, e portandoci in luoghi nient’affatto scontati. Però attenzione: la sua ormai è una NYC vintage, prima della caduta delle torri e prima di Rudolph Giuliani, è la metropoli disperata, impoverita, spaventata degli anni Settanta, quella che ci hanno mostrato film come Il braccio violento della legge, Mean streets, Taxi driver… la New York cantata da Lou Reed, quella evocata da Jonathan Lethem nella prima parte de La fortezza della solitudine. Rivolte urbane, degrado metropolitano, eroina, prostituzione, rapine, stupri, paura. Lieberman ce la fa riapparire, grande, persa e maleodorante, in tutta la sua tragica maestosità – perché, ricordiamocelo, questo romanzo esce quasi a metà di quel decennio sventurato. A tutti gli effetti è un messaggio in bottiglia che noi lettori italiani apriamo solo oggi.
Ma allora come mai a questo autentico classico dimenticato (del giallo) non arrise allora il successo che ci si sarebbe potuto aspettare? Non conoscendo a sufficienza le vicissitudini editoriali del romanzo, mi azzardo a fare un’ipotesi: che fosse qualcosa di troppo disperato, troppo brutale, troppo cupo, troppo ripugnante, e forse troppo onesto per quei tempi. Che fosse un romanzo del XXI secolo pubblicato per sbaglio nel XX. Che fosse arrivato troppo presto, un po’ come Moby Dick – altro grande anacronismo letterario statunitense. E forse proprio adesso, così tanto tempo dopo, è arrivato il suo momento; proprio adesso che il suo autore compie ottantacinque anni (una lunga vita costellata di quattordici romanzi dei quali in Italia era uscito solamente Fiore della notte, nel lontano 1986). E proprio per questo vi esorto a leggerlo, questo romanzo di cadaveri e putrefazione (nei vari significati, anche metaforici, del termine); e spero che adesso arrivi il successo che Lieberman merita ampiamente, sia di pubblico che di critica. Una volta tanto, un successo non postumo; per favore.