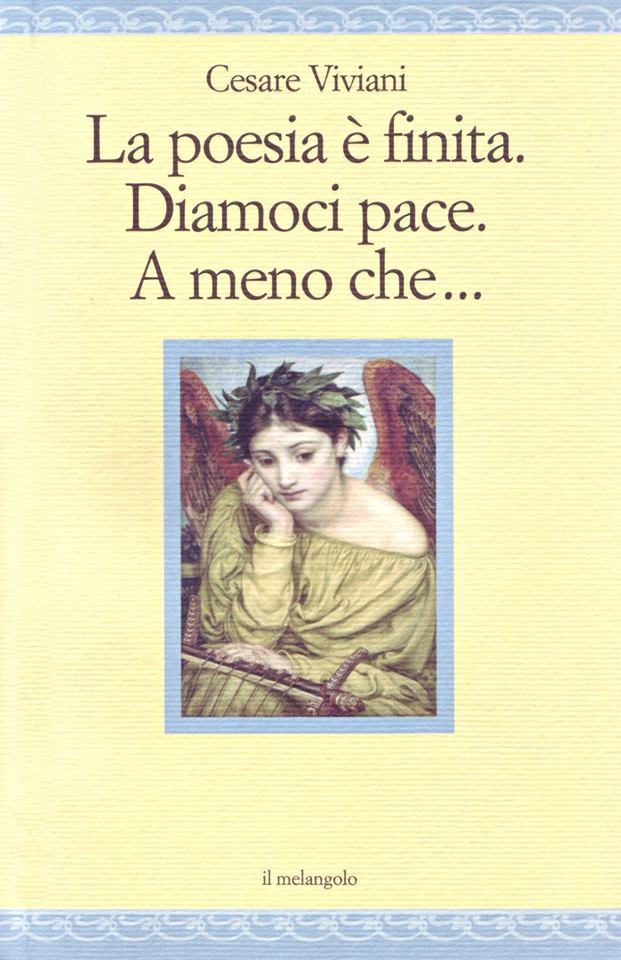Cesare Viviani, La poesia è finita. Diamoci pace. A meno che…, Il melangolo, pp. 80, euro 7,00 stampa
L’ultima raccolta poetica di Cesare Viviani, Osare dire, è del 2016. Un percorso poetico che scavalca i decenni, da quel lontano libro nella collana di poesia “gialla” Feltrinelli, messa su da Antonio Porta: L’ostrabismo cara (1973) non strappava la lingua (come allora si credeva) ma svelava l’intrusione di forme linguistiche di specie arcaica, dimenticate ma ancora presenti nei cromosomi umani.
Viviani le riportava alla luce con forte credo: in fondo erano confidenze di epoche che volevano oltrepassare l’oblio a cui erano state destinate dai poeti. A lui e Emilio Villa infondevano vocaboli e grammatiche capaci di far risuonare, dal folto dei tempi, nuove campane. E rifondare il pensiero (religioso per sua natura) sulla poesia, scrivendola e cercandola nei maestri senza più subire alcuna sosta.
È partendo dalla relatività del pensiero critico che questo libretto prende forma, mettendo nero su bianco quanto Cesare da tanti anni dice ai nuovi sordi che scrivono versi. Ma che non hanno poesia nei quaderni (o meglio, computer), nella loro quotidiana perdita di tempo. Se è vero, ed è vero, che la poesia non è definibile perché attraverso di essa ci si trova di fronte al vuoto, al silenzio, è proprio l’esperienza dello smarrimento “che provoca timore e vertigine” a testimoniare quanto il limite sia un luogo abbastanza simile a quel che si può definire poesia. Viviani dice chiaro, senza mezzi termini, che questo limite oggi (salvo rare eccezioni) non viene raggiunto. Nessuno è più disposto al sacrificio della lentezza, della lettura integrale dei maestri, abbandonando internet e antologie di dubbia efficacia. E i critici attuali confidano nel loro “quadrilatero” chiuso di informazioni, non dando scampo a quel che scrivono, attingendo miseramente a conoscenze acquisite.
Frasi durissime accompagnano il discorso di Viviani: egli accusa, ritengo a ragione, i poeti più giovani di non aver letto nemmeno Luzi o Zanzotto, Sereni o Giudici, Raboni, Porta o Pagliarani, se non nelle antologie o su internet. Colpevole la chiacchiera, inesausta e debordante ovunque, si tralascia lo studio approfondito dei maestri, dei classici italiani e stranieri: “Ancora sui giovani poeti: ne conosco trentenni e quarantenni, già pubblicati, che ancora non hanno letto Hölderlin e Rimbaud. Trentenni e ventenni che hanno letto la poesia del primo Novecento solo sulle antologie, e preferiscono letture disinvolte, e leggere facile narrativa e facile saggistica, e scrivono poesie disinvolte”. Se un critico militante, poi, dedica la stessa attenzione (peccato a cui talvolta anche io ho ceduto, non voglio negarlo) a buoni libri di poesia e a libri di nessun valore, “le conseguenze sono gravi”.
Sembra che non interessi più ad alcuno il sentimento della frattura a cui porta la vera poesia: fermarsi ai linguaggi abituali, quelli invasi dal narcisismo, è molto più comodo e facile. La stessa pubblicità, si direbbe, ha perduto oggi la raffinatezza linguistica di un passato abbastanza recente. Viviani ricorda che la poesia “non è incremento di intelligenza e di sensibilità”, ma è “la vertigine di un’esperienza rara, sconvolgente e liberatoria”. E di fronte al limite della parola incomprensibile la maggior parte dei poeti si blocca, non affronta il disarcionamento: meglio puntare sulla biografia, sulla chiacchiera. “Oggi non c’è più il sentimento, ma solo comportamento”. “Non c’è più poesia, ma solo scrittura in versi”.
Cesare a un certo punto ammette la propria incapacità, da buon “inesauribile toscano”, d’essere tollerante, ma preda “ancora di gran belle arrabbiature”. Io, di madre toscana, non esito a comprenderlo. Pochi oggi hanno la facoltà d’intendere quando una parola sia sbagliata, e quando quella parola, proprio quella e nessun’altra, è esatta per una poesia. Essere visionari vuol dire avere la capacità di non sbagliare quella parola. Questo è un tema di cui ha detto e scritto a lungo Milo De Angelis, altro poeta coetaneo che non ammette mezzi termini, né mezzucci di quart’ordine e sbavature, nella scrittura poetica.
Il libro di Viviani avanza per cerchi concentrici, verso il nucleo, il nodo della questione. L’andatura decisa non lascia scampo, raggiunge un bersaglio che può infastidire, che certamente infastidirà alcuni poeti e alcuni critici, poiché non vi si ammette superficialità o assenza di lavoro assiduo e studio profondo. Se qualcuno crede in una “grazia sovrannaturale” per cui ogni frase scritta ha un genitore sicuramente poeta, sbaglia già in partenza. L’appiattimento ha prodotto, per ogni generazione, decine e decine di individui che non distinguono la poesia dalla versificazione: le relazioni personali, e l’onnipresente chiacchiera, fanno loro riconoscere notevoli qualità, ma tutto questo “annienta la poesia”. E uccide mortalmente, già sul nascere, ogni tentativo di parola poetica e successivo pensiero critico.
Il rigoglio di cui tutti parlano, giornalisti e osservatori, è una fandonia. Viviani afferma a ogni pagina quanto sia troppo delicata la parola poetica perché si possa credere che fiorisca e sopravviva in menti dedite soltanto al commercio del proprio nome, della propria chiacchiera, della propria sensibilità. Perentoria la frase: “… non è mai esistita la ‘nuova poesia’…” e continuando: “… questa poesia del Duemila, giovane e meno giovane, ha ignorato la tradizione, ha mancato la nascita, non è nata”.
È vero che le suggestioni circolanti dipendono troppo dal narcisismo, dalla condizione del corpo virtuale, per questo la visione di Viviani è durissima, per lui e per chi si trova intorno ai settant’anni attorniato da un sottobosco deflagrato: “… la poesia, come l’abbiamo letta e amata noi, è finita. A meno che…” E qui Viviani osa poche pagine di precisazioni e speranze: a meno che si esca dalle comodità globali, dalla “comoda stanza piena di cose e di parole”… e soprattutto “… a partire dalla più giovane età – di evitare le chiacchiere”. E si legga poesia, tanta, “dalla prima all’ultima pagina”. Stare appartati, e lontani dalle scuole di scrittura, ed evitare le “parrocchiette” protettive e complici. Ritrovare un’isola, dunque, dove il silenzio esalti l’avvicinamento alla poesia. Perciò occorre stracciare le abitudini.
E se tutto questo assomiglia a una mistica del senso del limite, tanto meglio: seguirla equivale ad avere coscienza di come salvarsi e salvare i prossimi aspiranti poeti. Sia chiaro: per Viviani non si tratta di una religione che promette un Aldilà, ma di una fede inesausta verso l’unica vita che abbiamo, estesa solo seguendo le opere e le stagioni di chi ci ha preceduto.
Buon suggerimento di Seneca.
(Di Cesare Viviani Elio Grasso ha già recensito la raccolta Osare dire).