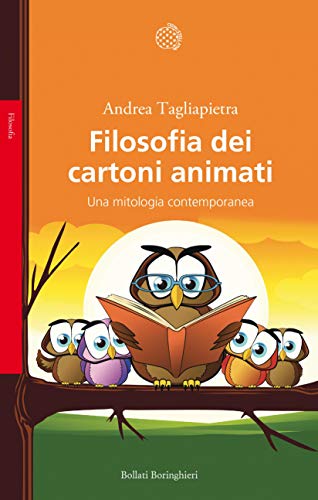Dobbiamo a Jack Halberstam, filosofo e studioso dell’identità di genere, la definizione di film “Pixarvolt” – da Pixar, la casa di produzione di Steve Jobs e John Lasseter, ora Disney, e revolt – per indicare la natura ribelle e liberatoria dei cartoni animati in CGI (Computer Generated Imagery), dalla grande fuga femminista di galline in fuga (2000) a Toy Story (1995), la monumentale trilogia (ora tetralogia) cinematografica che ha definito il canone dei nuovi cartoon. Anche Andrea Tagliapietra, ricercatore presso la Facoltà di Filosofia del San Raffaele e condirettore del Giornale critico di storia delle idee, colloca Toy Story al centro della ritrovata sfida dei cartoni al senso comune e all’ideologia contemporanea, una carica trasformativa che si rinnova nella magia del cinema da “vedere assieme”, nell’interazione e nello sguardo duale adulto-bambino. È il tema stesso di film come Le avventure di Peter Pan (1953) o, per contro, Il Re Leone (1994), riti di passaggio per intere generazioni e, in fondo, anche la premessa del classico e rassicurante “mondo Disney”, dove “l’estetica del cucciolo trionfa sulla crudeltà della lotta per la sopravvivenza” e l’autorità tradizionale del padre presente/assente appare smussata o rarefatta (ma non deposta), compatibile a un “noi” più orizzontale e inclusivo (amici, compagni di avventura, etc.).
Il saggio divide l’universo cartoon in “disneyani”, “anti disneyani” e “giapponesi”. I primi risultano codificati soprattutto dai lungometraggi Disney, a partire da Biancaneve (1937), continente emerso dopo un decennio di esperimenti dalle Silly Symphonies. I secondi riflettono il mondo conflittuale, ripetitivo e frenetico, dei cartoni Warner e MGM, e quindi il mondo di Will Coyote, Bugs Bunny, Silvestro & Titti, Tom & Jerry. Non è chiaro chi siano gli “anti disneyani” oggi, d’altra parte i cartoni della spielberghiana Dreamworks sono sostanzialmente “disneyani”, pur appartenendo al loro principale competitor. Infine ci sono i cartoon “giapponesi”, che l’autore identifica soprattutto con il magistero fantastico dello Studio Ghibli di Hayao Miyazaki e Isao Takahata, dove l’armonia della natura naturans tende ad assimilare la figura e la psicologia dei personaggi a una diversa ecologia della mente e dove il positivo affronta il negativo al di fuori di metafore bibliche occidentali, come parte del sé. Vi compaiono comunque anche altri autori, come Katsuhiro Otomo (Akira, 1988) e Osamu Tezuka (Astroboy, 2009). Stranamente per un saggio che già nel sottotitolo si propone di indagare una mitologia contemporanea come i cartoni animati, non si fa cenno a cicli televisivi come Gundam o Evangelion – questi sì mitologici – o, a proposito di corpi queer, la stessa Lady Oscar (ma a Capitan Harlock sì). Né – in 450 pagine, pur chiaramente senza intenti enciclopedici – a mostri sacri dell’animazione d’avanguardia come Norman McLaren od Oskar Fischinger.
Lo sguardo filosofico dell’autore si appunta invece attraverso sette capitoli densi e ben documentati, su altrettanti nuclei tematici: ermeneutica, antropologia, ontologia ed estetica, semiologia, apocalittica, politica ed etica.
La cifra del saggio emerge soprattutto nel ponte individuato tra antropologia e ontologia dei cartoni animati. Animare l’inanimato, trasformare una lampada Luxo o il vecchio giocattolo di un cow boy in personaggi che attraversano la barriera tra organico e inorganico, è proprio dell’antropologia ibrida dei cartoni, anche quando non ci trascinano tra dinosauri, spose cadaveri o mostri alla Shrek, ma semplicemente in un microcosmo popolato da topi o api. Come l’Odradek kafkiano i cartoni abitano il nonsense e la prima vittima è il pensiero logico, il principio di non contraddizione, il vecchio buon senso. “L’animazione rende visibile il flusso metamorfico dell’evoluzione della vita perché supera l’abituale staticità della realtà (..) là dove il movimento cessa di essere quello delle forme già date – vegetali e animali in un mondo già dato e stabile, ma i trasforma in un movimento all’interno dell’esistenza stessa e si esprime nella trasmissione di alcune forme in altre, nell’eterna incompiutezza dell’esistenza”. Se i cortometraggi di Betty Boop con Louis Armstrong e Cab Calloway sancivano l’alleanza dei cartoon con il jazz degli anni Venti, i moderni cartoni di Pixar celebrano con una libertà senza precedenti nei corpi di The Invincibles, Monster & Co. o nei characters poco freudiani di Inside Out il loro più ovvio superpotere: l’assenza di referente. La silhouette della Pantera Rosa, il cartone più amato da Gilles Deleuze, immagine in divenire, è un simulacro, e non un riflesso (cinematografico o platonico poco importa): inutile cercare una finestra sul reale nella sua apparizione ineffabile. Lo statuto dei cartoon si confronta da sempre – e non c’è Georges Méliès o Andy Wharol che tengano – con il realismo pregiudiziale dei film dal vivo, anche oggi che, tra CGI e motion capture, dal vivo quasi sempre non sono più e tradiscono spesso l’omaggio inconfessabile a Merry Poppins (1964) e a Chi ha incastrato Roger Rabbit (1990) (il cartone che denuncia il complotto della realtà contro i cartoni, nel decennio forse più moscio nella storia dell’animazione).
Tagliapietra cita la “Storia culturale del giocattolo” di Walter Benjamin a proposito del pregiudizio adulto che vorrebbe il bambino adattarsi alla rappresentazione della realtà grazie ai giocattoli, invece di crearla liberamente attraverso il gioco. È una bella riflessione e il pensiero di Benjamin resta dialettico, aperto, al di là del fraintendimento francofortese, in particolare della coppia Adorno-Horkheimer – sulla supposta infantilizzazione di massa dei cartoons, che rimbalza magari ai giorni nostri nel giudizio particolarmente tranchant di uno Slavoj Zizek sull’ideologia di Kung Fu Panda (2008). Altri tempi. Oggi che il modo rischia di precipitare in quella catastrofe – ambientale e non – che è il prequel annunciato di Wall-E (2008) (“Define: Earth”), per Tagliapietra la lezione di Toy Story ci mette invece di fronte all’inversione radicale per cui si restituisce alle cose la capacità di guardare. E diventa più difficile trattare gli esseri umani e gli altri esseri viventi come cose.