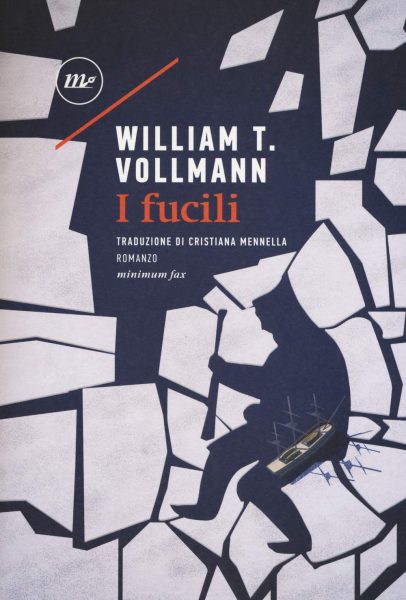Mi si consenta di partire dalla traduttrice, Cristiana Mennella. Lessi per la prima volta The Rifles quando ancora la traduzione italiana era di là da venire (anzi, neanche si sapeva bene se ci sarebbe mai stata); fu una lettura che mi trascinò nel vortice di neve e ghiaccio di una tempesta artica, con una potenza e una violenza da lasciarmi attonito. Ebbene, a leggere la traduzione della Mennella (I fucili, minimum fax, pp. 498, euro 19 stampa) ho riprovato, dopo più di dieci anni (fors’anche più di quindici) le stesse sensazioni. Se il Moby Dick melvilliano era (e resta) una balena di romanzo, questo è un iceberg di quelli enormi, come se ne incontrano in quei territori tra Groenlandia e Canada dove Vollmann ha ambientato le sue storie: eppure la Mennella è riuscita a dominarlo. Complimenti.
Veniamo ora al contesto, che è importante per capire questo libro. I fucili esce nel 1994; lunghe sono state le sue peregrinazioni editoriali, che finalmente l’hanno fatto approdare a minimum fax. Si tratta del terzo (in ordine di pubblicazione) dei Sette Sogni: una folle e colossale impresa che (a mio modesto avviso) darà a Vollmann una fama duratura, una serie di sette romanzi storici che partono con 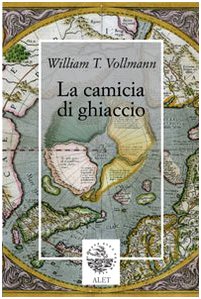 La camicia di ghiaccio (Alet, 2007), dove si racconta l’incontro o meglio lo scontro tra i vichinghi e gli indiani americani intorno all’anno Mille; continua con Venga il tuo regno (Alet, 2011), incentrato sulla tragica storia degli uroni e del loro rapporto con i gesuiti francesi del Quebec; segue I fucili, del quale parleremo in questo articolo; quindi abbiamo Argall: The True Story of Pocahontas and Captain John Smith (2001) ancora non tradotto in italiano; e infine The Dying Grass, uscito nel 2015 negli Stati Uniti e anch’esso inedito da noi. A questi cinque ponderosi volumi (Argall ammonta a più di 700 pagine, The Dying Grass supera le 1.300) ne andrebbero aggiunti due che Vollmann ancora non ha scritto, e cioè The Poison Shirt, che dovrebbe raccontare la guerra tra i coloni puritani del New England e gli indiani Wampanoag, e The Cloud-Shirt, descritto dall’autore in questi termini: «Navajo contro Hopi (o forse Navajo contro compagnia petrolifera) in Arizona».
La camicia di ghiaccio (Alet, 2007), dove si racconta l’incontro o meglio lo scontro tra i vichinghi e gli indiani americani intorno all’anno Mille; continua con Venga il tuo regno (Alet, 2011), incentrato sulla tragica storia degli uroni e del loro rapporto con i gesuiti francesi del Quebec; segue I fucili, del quale parleremo in questo articolo; quindi abbiamo Argall: The True Story of Pocahontas and Captain John Smith (2001) ancora non tradotto in italiano; e infine The Dying Grass, uscito nel 2015 negli Stati Uniti e anch’esso inedito da noi. A questi cinque ponderosi volumi (Argall ammonta a più di 700 pagine, The Dying Grass supera le 1.300) ne andrebbero aggiunti due che Vollmann ancora non ha scritto, e cioè The Poison Shirt, che dovrebbe raccontare la guerra tra i coloni puritani del New England e gli indiani Wampanoag, e The Cloud-Shirt, descritto dall’autore in questi termini: «Navajo contro Hopi (o forse Navajo contro compagnia petrolifera) in Arizona».
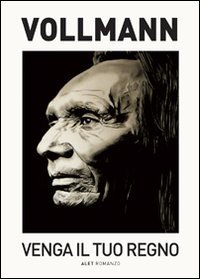 Se pensiamo che Argall tratta dell’incontro tra i colonizzatori inglesi delle Virginia e il popolo nativo dei Powhatan, e che The Dying Grass racconta lo sterminio delle tribù indiane delle grandi pianure, appare chiaro che questo colossale ciclo di romanzi è tutto incentrato sulla storia degli Stati Uniti, ripercorsa attraverso una serie di collisioni (forse questo è il termine giusto) tra le popolazioni originarie del Nordamerica (quelli che noi continuiamo a chiamare indiani) e gli europei, a partire dall’anno mille per arrivare al ventesimo secolo (periodo in cui dovrebbe essere ambientato l’ultimo romanzo). Un tema tremendamente impegnativo, per affrontare il quale Vollmann ha avuto bisogno di una tela enorme: sommando i volumi già pubblicati, siamo ben oltre le 3.000 pagine.
Se pensiamo che Argall tratta dell’incontro tra i colonizzatori inglesi delle Virginia e il popolo nativo dei Powhatan, e che The Dying Grass racconta lo sterminio delle tribù indiane delle grandi pianure, appare chiaro che questo colossale ciclo di romanzi è tutto incentrato sulla storia degli Stati Uniti, ripercorsa attraverso una serie di collisioni (forse questo è il termine giusto) tra le popolazioni originarie del Nordamerica (quelli che noi continuiamo a chiamare indiani) e gli europei, a partire dall’anno mille per arrivare al ventesimo secolo (periodo in cui dovrebbe essere ambientato l’ultimo romanzo). Un tema tremendamente impegnativo, per affrontare il quale Vollmann ha avuto bisogno di una tela enorme: sommando i volumi già pubblicati, siamo ben oltre le 3.000 pagine.
Come gli altri romanzi della serie, I fucili è basato su un considerevole e scrupoloso lavoro di ricerca, e in questo Vollmann è un classico romanziere americano. Da quelle parti esiste l’espressione to research a novel, che si può rendere vagamente come «fare ricerche per poi scrivere un romanzo». Come vedete, la loro è più sintetica; e se uno ci pensa un attimo vengono in mente i due padri del romanzo americano, Nathaniel Hawthorne con la sua Lettera scarlatta, che ricostruisce la vita dei puritani del New England alla metà del Seicento, e Herman Melville che associa alla storia di Moby Dick e del capitano Achab una vera enciclopedia della baleneria. E non dimentichiamo che Melville quando parlava di balene e baleniere non solo aveva fatto i compiti, ma era stato sul campo, marinaio imbarcato su un veliero impegnato nella caccia al più grande animale del mondo. E poi c’è Hemingway, che consigliava agli scrittori di parlare di ciò che conoscono, che era stato a Parigi e a Pamplona prima di scrivere Fiesta e ripetutamente in Italia prima di cominciare Addio alle armi. Da questa tradizione di romanzo nato dall’esperienza diretta, e di costruzione del testo fondata sulla ricerca documentale, proviene Vollmann, nella scia di questi illustri predecessori, ma anche del grande vecchio della narrativa americana, Thomas Pynchon, altro instancabile topo di biblioteca.
Però Vollmann è più hemingwayano che pynchoniano. Lui non è invisibile come zio Tom; nel suo romanzo ci deve stare. Lui, William T. Vollmann, con i suoi occhiali e la sua camicia a quadrettoni. Cosa diceva a Fabio Zucchella nella bella intervista che uscì sul numero 29 di PULP Libri? leggete, leggete.
Con la serie dei Seven Dreams ho cercato di andare nei luoghi in cui si sono svolti gli eventi di cui poi avrei voluto parlare, per ricreare i meccanismo della coscienza individuale del protagonista: così ho pensato che il modo migliore di farlo era quello di vedere ciò che lui aveva visto. Se Eric il Rosso aveva vissuto in una certa casa in Islanda, la cosa migliore che potessi fare era andare alle rovine della casa di Eric il Rosso in Islanda, e guardarmi attorno per vedere i fiordi, le navi, la vegetazione eccetera, per scoprire in che modo l’ambiente poteva influenzare il personaggio, per cercare di ricostruirne il comportamento. Ecco perché i Seven Dreams li chiamo Libri dei Paesaggi Americani. (…) E proprio per la stessa ragione, se devo scrivere di una prostituta che fuma crack, io devo fare del sesso con le prostitute e trascorrere giorni e settimane con loro, e fumare crack assieme a loro… (…) Altrimenti che scrittore sei, se ti inventi le cose?
Va detto che I fucili ricostruisce la storia della tragica spedizione delle due navi inglesi, l’Erebus e il Terror (nomen, omen…) che, al comando di Sir John Franklin tentarono disperatamente di trovare il leggendario passaggio a Nord-Ovest tra il 1846 e il 1848, restando poi imprigionate tra i ghiacci. Nessuno dei membri dei due equipaggi tornò a raccontare la storia, che è stata ricostruita a pezzi e bocconi negli anni successivi da diverse spedizioni inviate alla ricerca di Franklin e dei suoi uomini. Quasi certamente morirono tutti di malattie e di fame, in un ambiente che definirlo inospitale è fargli un complimento.  Altro fattore chiave del disastro fu la fornitura di carne in scatola (all’epoca una novità) che causò un avvelenamento da piombo, e i pessimi rapporti con gli inuit – quelli che chiamiamo erroneamente eschimesi – gli unici capaci di sopravvivere in quelle terre estreme. Se vogliamo, è la storia di una folle ambizione, di una sorta di ricerca dell’Eldorado, ma non nelle torride giungle sudamericane, quanto nelle rarefatte distese di ghiaccio dell’Artide. Una follia che porterà alla disperazione e alla morte. Non sarà un caso se questa vicenda è stata anche raccontata da uno scrittore horror come Dan Simmons, nel suo romanzo La scomparsa dell’Erebus, dal quale è stata anche tratta una serie televisiva, The Terror (il romanzo di Simmons è anche stato ristampato in Italia col titolo originale per sfruttare l’effetto traino della serie TV).
Altro fattore chiave del disastro fu la fornitura di carne in scatola (all’epoca una novità) che causò un avvelenamento da piombo, e i pessimi rapporti con gli inuit – quelli che chiamiamo erroneamente eschimesi – gli unici capaci di sopravvivere in quelle terre estreme. Se vogliamo, è la storia di una folle ambizione, di una sorta di ricerca dell’Eldorado, ma non nelle torride giungle sudamericane, quanto nelle rarefatte distese di ghiaccio dell’Artide. Una follia che porterà alla disperazione e alla morte. Non sarà un caso se questa vicenda è stata anche raccontata da uno scrittore horror come Dan Simmons, nel suo romanzo La scomparsa dell’Erebus, dal quale è stata anche tratta una serie televisiva, The Terror (il romanzo di Simmons è anche stato ristampato in Italia col titolo originale per sfruttare l’effetto traino della serie TV).
Ebbene, Vollmann non si è limitato a raccontare quel «folle volo», a tratti di dantesca grandiosità, ma è andato a passare diversi giorni nella base artica americana abbandonata di Isachsen, sull’isola di Ellef Ringnes, per vedere cosa si prova quando fuori si sta trenta o quaranta gradi sotto zero; e non contento di questo, è andato a vivere tra gli inuit ormai inurbati, e intreccia alla storia del viaggio di Franklin quella della sua relazione con una giovane inuit di nome Reepah, con la quale entra in contatto si potrebbe dire carnale col popolo dell’estremo nord. Entrambe queste storie parallele si intrecciano incessantemente con la vicenda di Franklin e della sua disastrosa spedizione, con la massima indifferenza per l’ordine cronologico degli avvenimenti, tanto che la narrazione inizia proprio con Vollmann in cammino sull’isola di Cornwallis, «con il mare sempre appena oltre un piccolo dosso ghiaioso, e il sole come un bianco disco abbagliante nella parete di nubi», senza mai raggiungere la riva e le onde del mare artico.
Vollmann è minuzioso nella sua ricostruzione sia delle proprie esperienze personali che dei fatti storici: inserisce nel romanzo cartine disegnate da lui (con uno stile assai personale e decisamente affascinante), schizzi dei luoghi visitati, persino un dettagliato elenco dell’equipaggiamento che ha portato con sé a Resolute per sopravvivere in un ambiente decisamente letale. E onestamente ammette di aver sbagliato sacco a pelo, narrando delle sofferenze che questo errore tecnico gli ha causato. Come pure elogia il fucile a pompa che si è portato appresso per difendersi dagli orsi polari, bellissimi da vedere in TV ma in realtà micidiali predatori che non esitano minimamente ad attaccare l’uomo.
E proprio sui fucili bisogna chiudere il discorso su questo romanzo-memoriale dove il confine tra vita vissuta e storia ricostruita è quantomai labile. Perché sono queste armi a dare il nome al libro? Ma perché Vollmann ci tiene a spiegare che a sottomettere gli inuit, e a fargli fare la fine degli altri popoli nordamericani, quasi spazzati via dalla civiltà degli europei venuti nel loro continente, non fu tanto il fatto di essere sprovvisti di armi da fuoco. Al contrario: fu fatale la scelta dei bianchi di vendere i fucili agli inuit, per poi fornire loro le pallottole a prezzi folli. Fu proprio il fatto di essere muniti della letale tecnologia europea a rovinare gli inuit, costretti a cacciare animali da pelliccia in quantità industriale per acquistare le munizioni con cui abbattere gli animali dei quali alimentarsi (essendo la loro, a causa delle caratteristiche dell’ambiente polare, una dieta pressoché esclusivamente carnivora). E anche questa triste storia di sfruttamento e devastazione ambientale ci viene raccontata da Vollmann, o meglio, come lui stesso ama definirsi, William il cieco.
 I fucili è un romanzo (se così lo possiamo definire), follemente ambizioso, quasi quanto il piano di Franklin di raggiungere il Pacifico passando a nord del continente americano (cosa che oggi, col riscaldamento globale, si può fare abbastanza agevolmente). Ma l’ambizione dell’idea narrativa di Vollmann è sostenuta da un considerevole talento letterario (personalmente lo ritengo il più dotato e originale nella generazione dei cinquantenni, quella che segue i mostri sacri Roth, Pynchon, McCarthy e Morrison), e anche da una disarmante modestia, visto che presenta la sua scombinata impresa polare più come un’idea bislacca e a momenti mortale che come un’impresa eroica. E in qualche modo la sua follia diventa metafora di quella del navigatore inglese e dei suoi uomini, in un complesso gioco di specchi che è forse il pregio più rilevante di questo libro-iceberg, la cui pubblicazione è a mio modesto avviso il vero evento letterario dell’anno.
I fucili è un romanzo (se così lo possiamo definire), follemente ambizioso, quasi quanto il piano di Franklin di raggiungere il Pacifico passando a nord del continente americano (cosa che oggi, col riscaldamento globale, si può fare abbastanza agevolmente). Ma l’ambizione dell’idea narrativa di Vollmann è sostenuta da un considerevole talento letterario (personalmente lo ritengo il più dotato e originale nella generazione dei cinquantenni, quella che segue i mostri sacri Roth, Pynchon, McCarthy e Morrison), e anche da una disarmante modestia, visto che presenta la sua scombinata impresa polare più come un’idea bislacca e a momenti mortale che come un’impresa eroica. E in qualche modo la sua follia diventa metafora di quella del navigatore inglese e dei suoi uomini, in un complesso gioco di specchi che è forse il pregio più rilevante di questo libro-iceberg, la cui pubblicazione è a mio modesto avviso il vero evento letterario dell’anno.